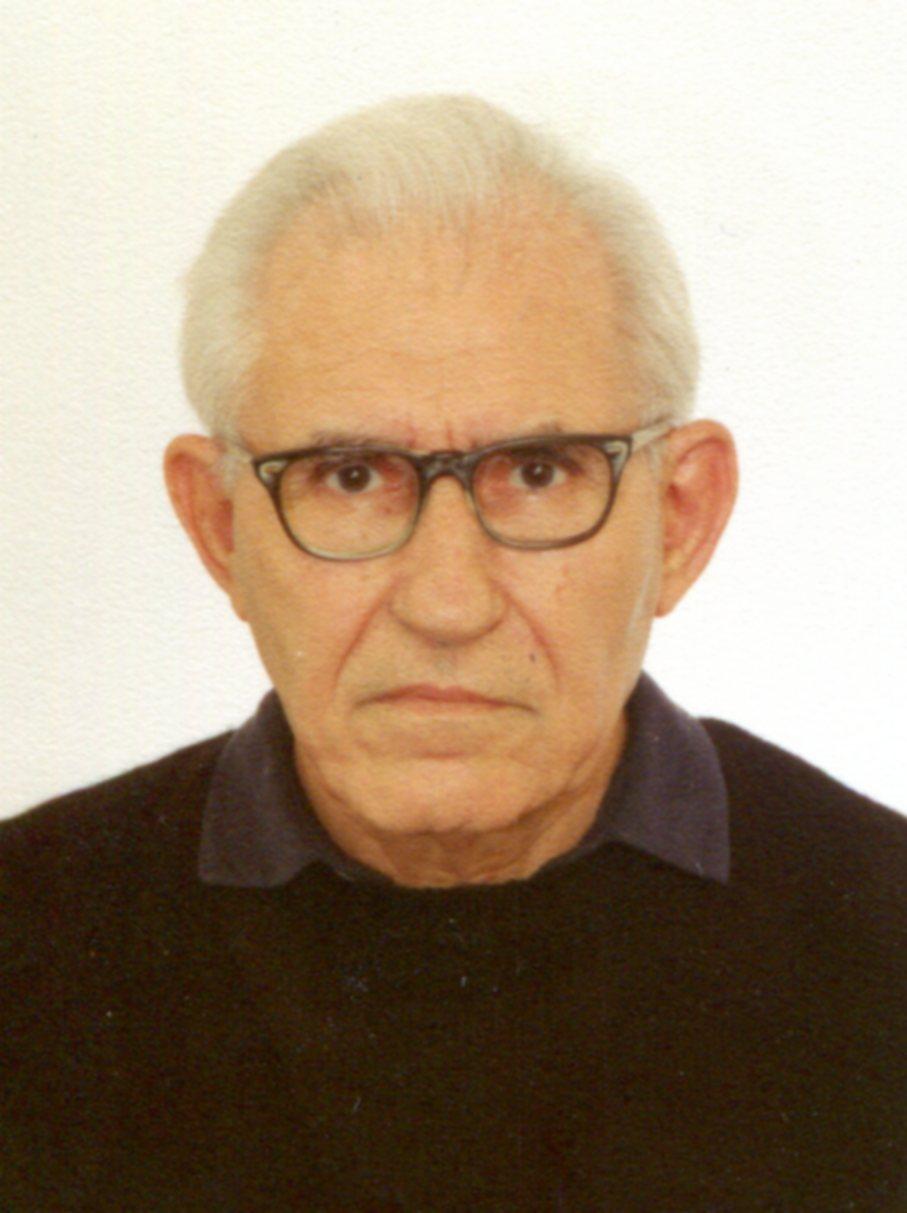Daniel Comboni
Misioneros Combonianos
Área institucional
Otros links
Newsletter
In Pace Christi
Sina Ottorino Filippo
Fecha de nacimiento :
17/08/1915
Lugar de nacimiento :
Lonato
Votos temporales :
07/10/1933
Votos perpetuos :
07/10/1938
Fecha de ordenación :
08/04/1939
Fecha de fallecimiento :
16/01/2003
Lugar de fallecimiento :
Cairo/EG
P. Ottorino Filippo Sina (17.08.1915 –16.01.2003)
P. Filippo Ottorino Sina è nato a Castelvenzago, una frazione di Lonato, provincia di Brescia, ma diocesi di Verona, il 17 agosto 1915. Era decimo di 12 figli, sei maschi e sei femmine. Un fratello e una sorella sono arrivati dopo di lui. Al battesimo, papà Giuseppe, un solido lavoratore che si adattava a qualsiasi attività pur di tirare avanti la copiosa nidiata, volle chiamarlo Ottorino. Il parroco protestò perché quel nome non esisteva sul calendario. Il padrino allora, lo zio Filippo, fabbro ferraio e tipo allegrone, disse: “Chiamatelo Filippo come me”. “Si potrebbe chiamarlo anche Decimo”, precisò il papà rifacendosi al numero progressivo dei figli. Così il nuovo arrivato si chiamò Ottorino-Filippo-Decimo.
La frazione di Castelvenzago era povera come tutti i suoi abitanti. Non esisteva neppure la scuola per cui gli scolari si radunavano nella vecchia chiesa di San Giovanni Battista dove si celebrava la Messa solo qualche volta all’anno. Una maestra faceva scuola per la prima e la seconda elementare al mattino, e alla terza al pomeriggio. Gli scolari trovavano posto su vecchie panche. E tutto finiva lì. Ma il Signore aveva deciso che uno di quei ragazzini, il più piccolo e il più smilzo, diventasse suo missionario, e allora… un brutto giorno (ma poi ci si rese conto che quello era stato un bel giorno) la casa dove abitava la famiglia Sina fu distrutta da un furioso incendio. Fortunatamente le vite furono risparmiate, ma solo le vite; tutto il resto finì in un cumulo di cenere.
“Cosa si fa adesso?”, disse mamma Virginia Lombardi, stringendosi attorno i più piccoli. “Si va a Brescia al Fiumicello dove la zia Carolina, sorella della mamma, è disposta a darci alloggio nella sua casa - tagliò corto papà Giuseppe. – Così i nostri figli potranno almeno frequentare una scuola come si deve”.
La vecchia casa in località Fiumicello, per la verità, non faceva al loro caso perché era formata da tre ambienti: una cucina, una camera da letto per i genitori e un grande camerone dove su due enormi letti separati da una tenda, dormivano, in uno le ragazze, e nel secondo i ragazzi.
La vita riprese con coraggio e fede in Dio, due cose che non sono mai mancate nella famiglia Sina. Alla mattina alle cinque, con qualsiasi tempo, i ragazzi saltavano fuori dal letto per andare alla Messa e poi a scuola. D’inverno, con il freddo che c’era, quell’operazione si trasformava in un atto eroico, ma allora non ci si faceva caso.
Quella Messa mattutina, secondo la mamma, non era sufficiente ad alimentare la fede per cui la santa donna vi aggiungeva abbondanti preghiere, sia al mattino che alla sera. Era bello sentire quella comunità unita nella lode del Signore e della Madonna con i genitori che facevano da animatori.
La chiamata
Ottorino stava terminando la quinta elementare. Ormai era pronto ad accogliere la chiamata del Signore. Mancava l’occasione. Questa capitò il giorno della Giornata Missionaria Mondiale del 1926, la prima Giornata Missionaria Mondiale nella storia della Chiesa. Ottorino udì nella sua chiesa un missionario proveniente dall’Istituto Comboni di Viale Venezia, che parlava di Africa e di africani che attendevano chi portasse loro il messaggio evangelico. Questo missionario era P. Vincenzo Pellegrini.
“Vado io”, disse Ottorino nel suo cuore. Da quel giorno il desiderio di farsi missionario si è acceso come una fiammella che non solo non si sarebbe mai spenta, ma sarebbe cresciuta in vigore e luminosità fino ad illuminare anche gli altri.
Andò a casa e ne parlò con il papà il quale gli disse un secco no. “Missionario! – commentò il genitore notando l’amarezza dipinta sul volto del figlio – non sai neanche che cosa sia!”. Ottorino chinò ancora di più la testa e tacque perché gli avevano insegnato che non ci si deve mai opporre al volere dei genitori.
“Se proprio ti piace studiare – disse il papà dopo qualche giorno vedendo il figlio costantemente abbacchiato – con l’aiuto dell’arciprete potresti frequentare il Collegio Arici, tenuto dai Gesuiti”.
“Grazie, papà”, rispose Ottorino. Con il nuovo anno, cominciò a frequentare il collegio come esterno. Cioè andava a scuola al mattino; a mezzogiorno mangiava ciò che si era portato da casa e al pomeriggio tornava a casa. La retta era di 25 lire al mese, pagata dall’arciprete, Don Giuseppe Bertazzoli che vedeva in Ottorino la stoffa del sacerdote.
Ricordando quel periodo, P. Sina dice: “Io ero povero e il papà mi dava ogni giorno quel tanto per comperarmi una fetta di una specie di torta dolciastra che costituiva il mio pranzo. A mangiarla andavo in refettorio dove gli altri studenti, molti figli di benestanti, sedevano davanti a tavole bene imbandite. Io mangiavo il mio pezzo di torta e poi, con più fame di prima, andavo a studiare fino alle 16.00, l’ora di tornare a casa dove continuavo lo studio e preparavo i compiti”.
L’incontro con i “piccoli missionari”
Il Collegio Arici era frequentato anche dagli alunni dell’Istituto Comboni. Arrivavano in fila e in silenzio come tanti soldatini con le loro divise ben stirate. Ascoltavano con attenzione le lezioni e poi, in silenzio come erano arrivati, tornavano a casa. I professori li guardavano con ammirazione perché sapevano che sarebbero diventati missionari d’Africa, apostoli, evangelizzatori, forse martiri. Anche Ottorino li guardava con uguale ammirazione e un po’ li invidiava.
Intanto il seme della vocazione che il Signore aveva seminato nel suo cuore l’anno prima, continuava a crescere e a buttare nuovi germogli. Un giorno il ragazzino manifestò ad un padre gesuita, un veneto, il suo desiderio di farsi missionario e questi lo invitò ad andare in Viale Venezia, dai Comboniani. Il papà, saputa la cosa, gli disse: “Se proprio insisti con la tua idea per le missioni, io non mi oppongo”. E gli diede il sospirato permesso.
Così Ottorino entrò nell’Istituto Comboni nel 1927 per frequentare la seconda media (che allora si chiamava ginnasio). Era superiore P. Giocondo Bombieri che poi sarebbe diventato suo padre maestro in noviziato. Questi, vedendo il nuovo venuto così magro e piccolo, lo fece visitare. “Ha solo patito tanta fame questo ragazzo – sentenziò il medico – ma è sano come un pesce”.
Allora esisteva solo la parte vecchia della casa e i ragazzi, pochi per la verità (nella classe di Sina erano in sei) avevano alcuni banchetti in fondo al refettorio dei padri e lì frequentavano le lezioni un po’ in qualche modo. Dal 1927, infatti, gli alunni dei Comboniani non andavano più all’Arici, ma avevano le loro scuole interne.
Nonostante una scuola così precaria, Ottorino faceva enormi progressi nello studio, anche perché gli piaceva studiare e aveva trovato il metodo giusto per farlo. I registri del tempo sono ancora custoditi nell’Archivio di Brescia. Ebbene, accanto al nome di Ottorino, ci sono solo “9” e “10” in tutte le materie. Anche come condotta le note dei superiori assicurano che Ottorino era un ragazzino “ordinato, studioso, esemplare, gentile con i compagni, bene educato e riservato, amante della preghiera, dello studio e del sacrificio”.
“L’ho conosciuto fin dal ginnasio, a Brescia – scrive P. Antonino Orlando. – Lui era in quinta ed io in prima. Era sempre il primo della classe, anche in quel lontano 1931 quando ricevette il primo premio dalle mani del Superiore Generale P. Pietro Simoncelli”.
Pure abitando a Brescia città anche Sina durante i quattro anni di permanenza a Brescia, non poté mai andare a casa. Allora si andava in vacanza in famiglia solo 5 giorni prima di entrare in noviziato. Durante il noviziato, che frequentò a Venegono Superiore, gli morì il papà. P. Bombieri gli concesse tre giorni per il funerale, però doveva andare a dormire all’Istituto Comboni. Cosa che Ottorino fece.
Prigioniero in Inghilterra
Ottorino entrò nel noviziato di Venegono Superiore, Varese, nel 1931 e fece la prima professione il 7 ottobre 1933. Poi rimase a Venegono per completare il liceo nel seminario di Milano a Venegono Inferiore. Per la teologia fu inviato a Roma insieme ad altri compagni. Studiò alla Pontificia Università Urbaniana dove conseguì la licenza in teologia summa cum laude.
Fu ordinato sacerdote a Roma il sabato Santo 8 aprile 1939, dal vescovo cappuccino Mons. Luca Ermenegildo Pasetto, nella chiesa dei Lazzaristi. Partì subito per l’Inghilterra per lo studio dell’inglese. Qui lo sorprese la seconda guerra mondiale per cui rimase “internato civile” nell’isola di Man fra i prigionieri italiani fino al 1947. Ma non perse tempo: oltre che al lavoro pastorale come cappellano e come insegnate ai prigionieri italiani, frequentò l’università di Londra conseguendo il titolo di Bachelor of Arts.
Questi anni di prigionia in Inghilterra meriterebbero una trattazione a parte e prolungata se consideriamo il bene che hanno fatto i nostri confratelli ai prigionieri italiani per utilizzare al meglio quel tempo di forzato riposo mediante l’attivazione di scuole e di altre attività intellettuali, senza parlare del conforto spirituale e psicologico che hanno saputo infondere in tanti cuori sfiduciati. Per questo periodo rimandiamo al libro “...e lo accolse nella sua casa” nel quale si racconta l’analoga vicenda di P. Renato Bresciani.
Al Collegio Comboni di Khartoum
Finalmente, nel 1947, P. Sina poté partire per l’Africa e fu assegnato a Khartoum, Sudan, dove lavorò per sei mesi al Comboni College come insegnante di lingua e letteratura inglese. E poi, nel 1962, oltre che insegnante, divenne consigliere di Mons. Baroni, e direttore del Comboni College. In questo incarico si mostrò un educatore di prima qualità. Il suo non era un compito facile con 950 studenti di tante razze e tante religioni e una trentina di professori. La sua responsabilità richiedeva fermezza, ma anche bontà, competenza ed equilibrio. Ed egli è riuscito a mettere d’accordo queste qualità tanto da farsi amare da tutti.
Scrive P. Giuseppe Farina che fu con lui molti anni: “Uomo semplice, quasi dimesso e schivo, era un lavoratore infaticabile. Quando lo incontrai nel 1958 era vice superiore della comunità dei missionari e rettore del Comboni College. La sua stanza da letto era attigua alla mia. Più di una volta ho notato che, dopo una giornata di intensa attività, non usava il letto per riposare, ma si accontentava di una sedia. Da quella posizione, un po’ studiava o correggeva i compiti e un po’ dormiva o metteva a punto i programmi. Vorrei dire che nella sua attività al Comboni College ha adottato il metodo del suo grande predecessore P. Agostino Baroni (che in quel periodo era vescovo di Khartoum) con il quale è sempre andato molto d’accordo”.
P. Antonino Orlando assicura che “fra tutti i Comboniani che insegnavano al Comboni College di Khartoum, P. Sina era uno dei più preparati. Seguì in modo tutto speciale gli studenti universitari, riuniti nella St. Augustine’s Society. Parlava l’inglese perfettamente ad aveva una memoria formidabile. Una sera, al Garden College, doveva leggere una conferenza sulla teoria dell’evoluzione. Purtroppo aveva dimenticato il testo scritto a casa. Non si scompose: svolse la sua conferenza parlando di getto… Pochi come lui hanno lavorato per preparare dei leaders sia nell’ambito scolastico come nella vita politica. Pochi come lui hanno amato i sudanesi. Con quanta gioia si dichiarava, come San Pietro Claver, a servizio degli africani… Insegnò inglese ai piccoli e ai grandi, spiegò il catechismo, seguì i catechisti, preparò le coppie che si preparavano al matrimonio…”.
Superiore provinciale e vicario generale
Nel 1965 P. Sina fu nominato superiore provinciale dei Comboniani residenti nel Nord Sudan. Nel 1969 andò al Capitolo Generale dell’Istituto a Roma e venne eletto vicario generale. Prima di allontanarsi da Khartoum diede la chiave della cassaforte all’amministratore dicendogli semplicemente: “Pensaci tu”. Qualche giorno dopo P. Giuseppe Farina aprì la cassa pensando di trovare qualche soldo. Invece trovò una scatola piena di biglietti con tanti nomi. Vi era scritto: “Prestato a Gabriele 5 sterline; prestato a John due sterline, ecc…” I biglietti erano tantissimi e tutti di quel tono. Sicuro che nessuno avrebbe restituito quei soldi, P. Giuseppe stracciò i biglietti. Certamente la carità di P. Sina era già registrata in cielo.
Il segreto di questo suo cuore generoso va cercato nell’infanzia di P. Sina. Un giorno, accompagnando un confratello alla casa dove era nato, disse: “Vedi quanta povertà! Eravamo in tanti e abbiamo vissuto un’esistenza stentata, il pane non sempre bastava, eppure io non ho mai visto la mia mamma o il mio papà mandar via qualche povero che bussava alla nostra porta”.
A Khartoum andava ogni venerdì alle prigioni per le confessioni dei cristiani. La prigione era uno stanzone non tanto grande, dal soffitto basso e con una sola finestrella, zeppo di detenuti legati con catene ai piedi e ai polsi. Il caldo e la puzza erano insopportabili, eppure P. Sina stava lì tutto il tempo che era necessario per dare un po’ di tranquillità e conforto a quegli uomini, molti dei quali erano in prigione solo perché avevano manifestato idee contrarie a quelle del regime.
Un uomo nella burrasca
Prima del Capitolo Generale, P. Sina presiedette la Commissione Precapitolare, molto importante per impostare il rinnovamento dell’Istituto richiesto dal Concilio Vaticano II. I capitolari poi lo elessero vicario generale dell’Istituto fino al 1975. Sappiamo che questi furono gli anni “bollenti” della contestazione giovanile e della “crisi di autorità” che ebbe i suoi riflessi anche nelle comunità religiose. Fu un periodo molto difficile.
P. Sina ebbe molta parte nel rinnovamento postconciliare dell’Istituto Comboniano. Inutile dire che questa sua incombenza di guida e moderatore in un periodo così turbolento, gli procurò qualche critica e incomprensione.
P. Giuseppe Zeno Picotti, che gli fu molto vicino, scrive: “Questo suo impegno (di applicare il Concilio) non è stato facile né indolore per le opposizioni che trovava in molti che ancora si aggrappavano alle vecchie tradizioni e ad un modo di vivere la vita religiosa ormai non più adatto ai tempi. Ha avuto anche il merito di aiutare, il Superiore Generale, P. Tarcisio Agostoni, in questo cammino di rinnovamento, anche se non senza difficoltà, ma con ottimo risultato. Erano momenti in cui gli ‘esperimenti’ di nuove vie più adatte ai tempi, specie nella formazione, richiesti però dal Concilio e dai documenti della Chiesa, potevano portare ad eccessive aperture. È fuori dubbio, comunque, che P. Sina abbia sempre agito in perfetta buona fede di cui io sono testimone. Egli ha sempre voluto aiutare l’Istituto e i Comboniani per un servizio più attuale al Regno di Dio, sfrondando tante strutture ormai obsolete e controproducenti, salvando tuttavia i veri valori della vita missionaria e della consacrazione religiosa, come il Concilio chiedeva”.
Superiore provinciale per la seconda volta
Dopo il Capitolo Generale del 1975, P. Sina ritornò a Khartoum dove fu eletto di nuovo superiore provinciale del Sudan. Nel 1982, con il ritorno dei Missionari nel Sud Sudan, chiese di andare al Sud dove i Comboniani erano stati espulsi 18 anni prima ed ora c’era tanto da fare. Fu trasferito in una semplice missione alla periferia di Juba, tra i poverissimi, dove ha aperto una scuola e una chiesa fatta di paglia e fango. Qui fu parroco per 10 anni. Sempre a Juba fondò il Comboni College, importante istituzione per la formazione dei leader.
Scrive P. Giuseppe Farina: “Anch’io andai al Sud in quel periodo. Posso testimoniare che P. Sina ha donato tutto se stesso senza risparmio. Spesso veniva da me che ero amministratore e mi diceva: ‘Vedi se puoi darmi qualcosa per i poveri che sono tanti; io non ho più nulla e non so dove sbattere la testa’. Un’altra cosa che mi ha colpito in P. Sina è stato il suo spirito di preghiera. Pregava molto, pregava bene. Proprio dalla preghiera traeva la forza per superare i momenti difficili della missione e della sua vita”.
“P. Sina – ha scritto P. Luigi Penzo che era assistente generale quando P. Sina era vicario generale e poi è stato suo compagno di missione – era stato arricchito dal Signore di doni straordinari. Possedeva un’intelligenza profonda. Conosceva benissimo le materie che insegnava, ma soprattutto conosceva bene l’Istituto, i nostri problemi, i confratelli e le persone con cui veniva a contatto. Egli possedeva anche una grande fede, e la sua conoscenza diventava ‘sapienza’, perché sapeva giudicare gli avvenimenti e le persone alla luce che gli veniva dal Signore. P. Sina possedeva anche una straordinaria apertura di mente, mentre diversi confratelli anziani andavano in crisi per ciò che succedeva nella Chiesa e nell’Istituto, egli non si turbava perché sapeva valutare tutto con quell’ottimismo cristiano che viene dalla speranza nel Signore”.
Nel 1992 avendo partecipato ad una manifestazione degli studenti contro l’imposizione della legge islamica ai non musulmani, fu espulso da Juba ed esiliato a Khartoum, da dove venne successivamente espulso nel 1995. Furono due momenti amari per P. Sina, tuttavia accettò la croce con serenità e calma, sicuro che Dio aveva i suoi piani anche in questa faccenda.
L’angelo dei rifugiati
P. Sina chiese allora di poter lavorare in Egitto per essere “rifugiato con i rifugiati Sudanesi”, come scrisse egli stesso in occasione del 60mo anniversario di Sacerdozio, celebrato al Cairo l’8 aprile 1999. In data 4 febbraio 1996 aveva scritto: “Accetto con gratitudine, anche se con dolore, di lasciare il Sudan per l’Egitto. Cercherò di fare quello che potrò per questa terra in cui Comboni fece tanto”.
In una relazione sulla sua attività al Cairo, scrisse: “Abbassyia, Cairo, Ahmed Said Street, N° 72. È il numero che appare sopra una porta di ferro, colore verde, lungo una delle principali arterie del traffico in una delle più grandi città del mondo, Cairo. Se riesci da aprirla, ti trovi all’entrata di un cortile lungo una sessantina di metri e largo sette, che termina con un’altra porta di ferro verde. Aprendola, ci si immette in una delle vie più strette del Cairo, Shurafa Street, non più di quattro o cinque metri di larghezza.
Questo cortile così corto e così stretto, è fiancheggiato da una parte da una chiesa alta e spaziosa, la chiesa del Sacro Cuore. Sul fianco opposto sorge un edificio di tre piani, quasi della stessa lunghezza del cortile. Lungo i lati di Ahmed Said Street e di Shurafa street s’innalzano fabbricati di dieci e più piani. Gli architetti che hanno costruito gli edifici che torreggiano ai quattro lati del cortile, sembra che si siano messi d’accordo nello sforzo di soffocare qualsiasi manifestazione di vita osasse affermarsi in quella specie di budello. Se questa era la loro intenzione, essi hanno fatto fiasco nel senso più completo della parola perché quel cortile così corto e così stretto pulsa ogni giorno di vita dalle prime ore del mattino fino alle ore più tarde della sera.
Se riesci ad aprire una delle due porte verdi, vedrai il cortile formicolare di ragazzi e di ragazze, tutti neri, dai cinque ai quindici/sedici anni d’età, dalle sei o sette del mattino fino alle cinque del pomeriggio. Sono i figli e le figlie dei sudanesi scappati dal Sudan. Il nome ufficiale della scuola è “St. Charles Lwanga Basic Education Centre”, conosciuta dal governo egiziano ma non riconosciuta ufficialmente, con più di mille alunni divisi in due turni di classi che vanno dalla scuola materna all’ottava”.
Il cortile del miracolo
“Prima del suono del campanello che segna l’inizio delle lezioni, vedresti queste centinaia di ragazzi e di ragazze abbandonarsi al gioco con slancio irresistibile. Sono evidentemente pieni di gioia per il dono della vita e danno espressione alla loro gioia nei modi più spontanei. Ma al suono del campanello si allineano in silenzio per la preghiera o il canto dell’inno nazionale sudanese, cantato a squarciagola e con entusiasmo incontenibile, per infilarsi poi in aule designate per una quarantina di alunni, ma destinate a contenerne sessanta e anche più. Il cortile così corto e così stretto, le aule che lo circondano, sono il teatro della loro attività fino, come già detto, alle ore cinque del pomeriggio. A quell’ora esso si spopola di ragazzi e di ragazze, ma solo per ripopolarsi immediatamente di giovani e di anziani, uomini e donne, anche loro tutti neri e in gran parte alti come giganti, vestiti impeccabilmente, con scarpe lucide, col sorriso sulle labbra che spesso si cambia in risate sonore che echeggiano da un fianco all’altro del cortile. Questi nuovi frequentatori del cortile sono i padri, le madri, i fratelli, le sorelle dei frequentatori del mattino e del pomeriggio. Vengono dai vari quartieri del Cairo per incontrarsi e scambiare le loro esperienze, felici e infelici, o per darsi all’una o all’altra delle molte attività di formazione umana e cristiana che il Centro offre loro.
Dopo le cinque, il cortile ritorna ancora a popolarsi di nuovo di ragazzi e di ragazze che l’avevano invaso alla mattina. Vi ritornano per abbandonarsi di nuovo al gioco come la mattina o per partecipare anche loro ad una o all’altra delle attività di formazione adatte a loro. Allora vedi i più giovani e gli anziani raggruppati in crocchi di tre o quattro, in piedi o seduti, discutere animatamente fra di loro, indisturbati dai ragazzi tutti intenti ai loro giochi, che si intrufolano tra i crocchi senza disturbarsi a vicenda. È chiaro che, sia i grandi come i piccoli, amano questo luogo di ritrovo, perché quando arriva l’ora in cui lo devono lasciare per tornare a casa, bisogna quasi forzarli ad andarsene”.
Far causa comune
“Osservando il sorriso che appare costantemente sulle labbra di grandi e piccoli, ascoltando le risate sonore che risuonano di continuo nel cortile, guardando la gioia e la spensieratezza dei più piccoli, si direbbe che tutta questa gente non ha nessun problema. Invece tutti, senza eccezione, anche se in maniera diversa, hanno problemi più numerosi e più intricati dei folti capelli che coprono le loro teste. Infatti sono tutti, grandi e piccoli, sudanesi scappati dal loro paese per sfuggire alle vessazioni, alla persecuzione e alle torture a cui erano esposti”.
Parlando dei rapporti di P. Sina con i sudanesi, P. Penzo scrive: “Aveva il cuore aperto agli altri, pieno di comprensione e di bontà. Li amava, si sentiva coinvolto nella loro vita, nei problemi e nella loro tragica storia. In questo egli è stato un vero Comboniano perché ha saputo far causa comune con i più poveri. Pensando a lui mi vengono in mente le parole di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2 ‘Voi siete testimoni che mi sono comportato in mezzo a voi come una madre, per la tenerezza che vi ho dimostrato; e come un padre per il lavoro perseverante che ho fatto per amor vostro’. Ma P. Sina possedeva in grado sublime la virtù dell’umiltà. Rifuggiva da tutto ciò che era esteriorità. Ha lavorato nel nascondimento, non ha mai messo in mostra le sue doti e non si è mai vantato di ciò che faceva. Anche a questo punto penso a Paolo quando descrive la sua vita ai presbiteri di Efeso, nel capitolo 20 degli Atti: ‘Il Signore mi è testimone come io abbia vissuto in mezzo a voi con tutta umiltà, servendo lui e servendo voi, sacrificandomi per voi e lavorando per voi notte e giorno per portarvi alla fede nel Signore Gesù’. Ora me lo sento vicino come una santo, un amico, un protettore”.
Il calvario dei sud sudanesi
“Il Sudan – scrisse P. Sina - divenne indipendente il 1° gennaio 1956. Nei cinquant’anni precedenti era stato un condominio Anglo-egiziano, durante il quale il principale condomino del paese, l’Inghilterra, era riuscita a mantenere una convivenza pacifica tra il nord del Sudan, arabo di lingue e cultura e musulmano di religione, e il Sud africano-nero di cultura e praticante la religione africana tradizionale o, nel caso di una minoranza sempre crescente, la religione cristiana.
Già prima dell’indipendenza era cominciato lo scontro tra il Nord, deciso a imporre la propria cultura e religione, e il Sud ugualmente deciso a conservare la propria cultura e religione. Lo scontro degenerò ben presto in una guerra civile che, iniziata nel 1956, si protrasse fino al 1972, devastando il Sud e costringendo centinaia di migliaia di abitanti a cercare rifugio nei paesi limitrofi, quali l’Etiopia, il Kenya, l’Uganda, il Congo, la Repubblica Centrafricana. Nel 1972 il capo del governo di Khartoum, il generale Jafar el Nimeiry, che deteneva il potere, decise di concedere al Sud una certa misura di autonomia locale e di non insistere troppo sull’arabizzazione e islamizzazione del Sud, attraverso l’accordo di Addis Abeba, firmato in quella città dai rappresentanti delle due parti del Sudan nello stesso anno.
Le clausole di quell’accordo furono osservate con relativa fedeltà fino al 1982, quando lo stesso capo del governo di Khartoum che le aveva firmate, decise di ignorarle e di riprendere ad oltranza il tentativo di arabizzare e islamizzare il Sud. Questa decisione segnò l’inizio di una seconda guerra civile fra Nord e Sud, più crudele e devastatrice della prima. Iniziata nel 1983, essa non dà alcun segno di voler terminare. Anch’essa, ancor più della prima, causò la fuga di centinaia di migliaia di sudanesi dal Sud verso gli stessi paesi limitrofi e anche verso il Ciad, la Libia e l’Egitto.
La fuga dal Sud verso l’Egitto avviene in due stadi. La prima è la fuga dal Sud verso il Nord del Sudan per sfuggire agli attacchi e bombardamenti dell’esercito del Nord e alle milizie delle tribù governative e alle tribù arabe che attaccano e distruggono villaggi e città dandole alle fiamme e portando via, non solo il bestiame, ma anche le donne e i bambini come schiavi e costringendo chi può a darsi alla fuga verso il Nord.
L’arrivo al Nord non coincide con il termine delle malversazioni da parte del governo centrale. È seguito da imprigionamenti, torture incredibili, dall’arruolamento forzato dei giovani nell’esercito nazionale e dal loro invio al Sud per combattere e uccidere la propria gente. Per evitare tutti questi mali ed altri ancora, i sudanesi del Sud, una volta arrivati al Nord, cercano rifugio in Egitto sperando di trovare un termine alle loro sofferenze.
Il loro numero, all’inizio un piccolo rigagnolo, è andato aumentando continuamente. Ogni venerdì arrivano dal Sudan alcune centinaia di sudanesi del Sud: donne, bambini, giovani, adulti. Sostano all’esterno della porta N° 72 di Ahmed Said Street, attendendo che amici o parenti arrivati prima di loro, diano loro ospitalità.
La stragrande maggioranza di loro si stabilisce al Cairo o nella zona del delta. Si calcola che il loro numero complessivo si aggiri attorno ai 30.000 o 35.000. La loro speranza è quella di poter trovare una sistemazione in Egitto o in uno dei paesi disposti ad accettarli come profughi: l’America, il Canada, l’Australia. Purtroppo tali speranze sono destinate ad essere in gran parte deluse”.
Gente sradicata
“La migliore parola per descrivere la situazione in cui si trovano i sud sudanesi arrivando in Egitto, è quella coniata dalle Organizzazioni Internazionali. In inglese essa è uprooted che in italiano significa ‘sradicati’. Questa parola non significa solo che i profughi sudanesi vengono violentemente sradicati dall’ambiente naturale in cui sono nati e cresciuti. Essa esprime anche tutta la difficoltà che avranno nel gettare radici in un terreno culturale tutto differente. Questo è ciò che attende i sudanesi del Sud al loro arrivo in Egitto.
L’ambiente egiziano è assai differente da quello sudanese. Arrivando in Egitto, i sudanesi non sono accolti a braccia aperte e respirano un’atmosfera differente da quella del Sudan. I sudanesi in Egitto non hanno alcun diritto; sono lasciati vivere in pace se non commettono sbagli, se non danno nessun disturbo. In Egitto non sono più esposti ai pericoli e alle sofferenze della guerra civile, ma questo è tutto ciò che possono attendersi. Eppure questa gente è ottimista.
Per quanto riguarda i piccoli, si potrebbe attribuire l’ottimismo alla spensieratezza naturale di tale età e al fatto che da una parte non hanno ancora esperimentato tutte le difficoltà e amarezze della vita propria dei grandi e dall’altra al fatto che la vita presenta loro quotidianamente nuove esperienze che assorbono il loro continuo interesse. Ma questo non si può affermare dei più grandi che hanno già avuta una vita tribolata, segnata da sofferenze, persecuzioni e magari torture.
All’inizio della mia presenza tra i sudanesi d’Egitto, attraverso la conversazione con loro, cercai una risposta a questa domanda. Ed eccola: “Noi sudanesi del Sud siamo convinti che il Sudan è il nostro paese datoci da Dio stesso. Anche se per adesso Egli ha permesso che ne siamo allontanati, questo non può durare per sempre, perché egli è misericordioso e giusto. Verrà un giorno, forse presto, quando potremo tornare alla terra che lui ci ha dato”.
Salvare l’Africa per mezzo degli africani
“Noi, sparuto gruppo di Comboniani al Cairo, cerchiamo di tener vivo questo incrollabile ottimismo dei sudanesi del Sud aiutandoli a risolvere i loro problemi e a creare una specie di atmosfera in cui, se non possono gettar radici, possono almeno respirare e vivere. In ossequio allo spirito del nostro Fondatore, il Beato Daniele Comboni, che è quello di salvare l’Africa per mezzo degli africani, coinvolgiamo i sudanesi stessi in tutte le nostre attività. Esse sono tutte, senza eccezione, programmate da un consiglio pastorale composto di rappresentanti delle varie tribù ed eseguite sotto la sua alta sorveglianza.
Il cortile corto e stretto di Ahmed Said Street, N° 72, ha un ruolo molto importante nel tenere alto il morale dei sudanesi del Cairo. Le varie attività che vi si svolgono, da una parte sono una medicina che sana tante ferite versandovi sopra l’olio della condivisione di esperienze felici o meno felici. Al momento di lasciare il cortile per far ritorno alle proprie case i pesi che gravavano sulle spalle di ciascuno sono diventati un po’ più leggeri con l’essere messi anche sulle spalle degli altri. Dall’altra parte, le stesse attività del Centro, danno nuova forza agli spiriti rinfrancandoli per la lotta quotidiana. “Aetiopum semper servus” era il motto che San Pietro Claver a Cartagena continuava a ripetersi e che animava lo spirito con cui si dedicava al servizio degli Africani che approdavano a quel porto. Non pretendo di paragonare noi stessi, almeno non me stesso, a quel grande santo e apostolo dei neri. Vorrei dire che noi Comboniani, che l’abbiamo preso come uno dei nostri santi patroni, al Cairo come lui a Cartagena (mi pare di poterlo dire con tutta verità e tutta umiltà) cerchiamo di non risparmiarci in nulla. E se qualche volta sotto “il pondus diei et oestus” veniamo in qualche misura meno al nostro impegno di servi degli africani, il Signore ci dà la sua grazia affinché riprendiamo il nostro lavoro di servi degli africani con maggior alacrità”.
Fino alla fine
P. Sina continuò a servire con tanto zelo, generosità e coraggio. Nonostante l’età, si impegnò in modo particolare nella formazione dei catechisti e nella pastorale matrimoniale in parrocchia e nei neo-nati centri per i Sudanesi nella periferia del Cairo. Era sempre disponibile anche per l’assistenza spirituale nelle diverse comunità religiose.
I rifugiati sudanesi, senza casa, senza lavoro, senza assistenza sanitaria, in attesa di una qualsiasi sistemazione, diventarono lo scopo della sua vita. P. Sina era spesso negli uffici governativi del Cairo per seguire le pratiche degli immigrati. Questo lavoro gli era facilitato dalla conoscenza delle lingue (arabo, francese, inglese) e dal suo modo gentile di trattare, ma gli comportava tanta fatica fisica. Tuttavia non si è mai tirato indietro.
In una lettera del 19 novembre 2002 scrisse: “Nei tre centri scolastici abbiamo 1.800 scolari. Io non ho più nessun insegnamento, ma il vedere tutta questa gioventù, così piena di vita e di gioia nonostante i loro problemi, mi riempie il cuore di tanta consolazione”.
Scrive P. Picotti: “Alla fine di novembre 2002 le forze cominciarono a venirgli meno e fu ricoverato per 33 giorni in ospedale senza nessun risultato. Aveva chiesto di poter essere curato in Italia col solo desiderio di poter tornare e riprendere il suo lavoro, ma la sua situazione precipitò durante la notte tra il 12 e il 13 gennaio, e il Signore lo chiamò al premio finale la sera del 16 gennaio 2003. Amorevolmente assistito dai confratelli, dalle Suore Comboniane e da alcuni amici sudanesi si spense all’età di 88 anni. I sudanesi lo piangono come avessero perso un padre, i confratelli e le suore per non aver più un esempio e una guida”.
Al funerale, di fronte a centinaia di persone raccoltesi per il saluto finale ad un vero fratello e padre, Mary, una catechista sudanese, ha pregato con queste parole: “Signore, c’è uno di noi, P. Philip Sina, che è vissuto tra di noi ed ora è con te in cielo. Egli conosceva e aveva sperimentato il nostro dolore, conosceva così bene le ingiustizie che abbiamo subito per tanto tempo: ascoltalo, Ti preghiamo, è il nostro avvocato.”
P. Cosimo Spadavecchia, che con P. Sina aveva lavorato in Cairo per sei anni, così si è espresso durante l’omelia: “P. Philip veramente ci ha mostrato chi è Gesù... Era sempre pronto a ricevere chi lo cercava e ad ascoltarlo. A chi gli chiedeva spiegazione della Parola di Dio era sempre pronto a mostrare Gesù.... Sul suo letto nell’ospedale soffriva: tanti andavano a trovarlo ma lui non lasciva vedere la sua sofferenza, perché era in unione con il Cristo sofferente. È quando è morto era in unione con Cristo. È morto pregando e con il Cristo Crocifisso può dire: “Guardate, sono innalzato davanti a voi”.
Certamente P. Sina è stato uno dei grandi nel campo dell’educazione. “Oggigiorno – scrive P. Antonino Orlando – si parla tanto di poveri da sfamare in terra di missione e spesso ci si dimentica di quanto progresso culturale e civile abbiano apportato i missionari con le loro scuole che hanno acceso una fiaccola di sapere nel Sudan e nel mondo ed hanno avviato migliaia di giovani d’ambo i sessi a percepire il valore di un dialogo tra cristiani e musulmani, che ha già dato i suoi frutti e che ne darà ancora di più in avvenire. Nel ricordo di P. Sina voglio elevare un inno di lode in favore di tutti quei Comboniani che hanno dato i più bei decenni della loro vita missionaria nell’insegnamento nelle scuole. Non interviste per loro, né seguito di mass media, ma un duro lavoro nel silenzio, noti solo a Dio”.
Ora P. Ottorino Sina riposa nel cimitero di Helwan accanto a P. Paolo Adamini, l’altro missionario bresciano recentemente scomparso,che pure aveva speso tutta la sua vita al servizio dei Sudanesi. P. Lorenzo Gaiga, mccj
P. Filippo Ottorino Sina è nato a Castelvenzago, una frazione di Lonato, provincia di Brescia, ma diocesi di Verona, il 17 agosto 1915. Era decimo di 12 figli, sei maschi e sei femmine. Un fratello e una sorella sono arrivati dopo di lui. Al battesimo, papà Giuseppe, un solido lavoratore che si adattava a qualsiasi attività pur di tirare avanti la copiosa nidiata, volle chiamarlo Ottorino. Il parroco protestò perché quel nome non esisteva sul calendario. Il padrino allora, lo zio Filippo, fabbro ferraio e tipo allegrone, disse: “Chiamatelo Filippo come me”. “Si potrebbe chiamarlo anche Decimo”, precisò il papà rifacendosi al numero progressivo dei figli. Così il nuovo arrivato si chiamò Ottorino-Filippo-Decimo.
La frazione di Castelvenzago era povera come tutti i suoi abitanti. Non esisteva neppure la scuola per cui gli scolari si radunavano nella vecchia chiesa di San Giovanni Battista dove si celebrava la Messa solo qualche volta all’anno. Una maestra faceva scuola per la prima e la seconda elementare al mattino, e alla terza al pomeriggio. Gli scolari trovavano posto su vecchie panche. E tutto finiva lì. Ma il Signore aveva deciso che uno di quei ragazzini, il più piccolo e il più smilzo, diventasse suo missionario, e allora… un brutto giorno (ma poi ci si rese conto che quello era stato un bel giorno) la casa dove abitava la famiglia Sina fu distrutta da un furioso incendio. Fortunatamente le vite furono risparmiate, ma solo le vite; tutto il resto finì in un cumulo di cenere.
“Cosa si fa adesso?”, disse mamma Virginia Lombardi, stringendosi attorno i più piccoli. “Si va a Brescia al Fiumicello dove la zia Carolina, sorella della mamma, è disposta a darci alloggio nella sua casa - tagliò corto papà Giuseppe. – Così i nostri figli potranno almeno frequentare una scuola come si deve”.
La vecchia casa in località Fiumicello, per la verità, non faceva al loro caso perché era formata da tre ambienti: una cucina, una camera da letto per i genitori e un grande camerone dove su due enormi letti separati da una tenda, dormivano, in uno le ragazze, e nel secondo i ragazzi.
La vita riprese con coraggio e fede in Dio, due cose che non sono mai mancate nella famiglia Sina. Alla mattina alle cinque, con qualsiasi tempo, i ragazzi saltavano fuori dal letto per andare alla Messa e poi a scuola. D’inverno, con il freddo che c’era, quell’operazione si trasformava in un atto eroico, ma allora non ci si faceva caso.
Quella Messa mattutina, secondo la mamma, non era sufficiente ad alimentare la fede per cui la santa donna vi aggiungeva abbondanti preghiere, sia al mattino che alla sera. Era bello sentire quella comunità unita nella lode del Signore e della Madonna con i genitori che facevano da animatori.
La chiamata
Ottorino stava terminando la quinta elementare. Ormai era pronto ad accogliere la chiamata del Signore. Mancava l’occasione. Questa capitò il giorno della Giornata Missionaria Mondiale del 1926, la prima Giornata Missionaria Mondiale nella storia della Chiesa. Ottorino udì nella sua chiesa un missionario proveniente dall’Istituto Comboni di Viale Venezia, che parlava di Africa e di africani che attendevano chi portasse loro il messaggio evangelico. Questo missionario era P. Vincenzo Pellegrini.
“Vado io”, disse Ottorino nel suo cuore. Da quel giorno il desiderio di farsi missionario si è acceso come una fiammella che non solo non si sarebbe mai spenta, ma sarebbe cresciuta in vigore e luminosità fino ad illuminare anche gli altri.
Andò a casa e ne parlò con il papà il quale gli disse un secco no. “Missionario! – commentò il genitore notando l’amarezza dipinta sul volto del figlio – non sai neanche che cosa sia!”. Ottorino chinò ancora di più la testa e tacque perché gli avevano insegnato che non ci si deve mai opporre al volere dei genitori.
“Se proprio ti piace studiare – disse il papà dopo qualche giorno vedendo il figlio costantemente abbacchiato – con l’aiuto dell’arciprete potresti frequentare il Collegio Arici, tenuto dai Gesuiti”.
“Grazie, papà”, rispose Ottorino. Con il nuovo anno, cominciò a frequentare il collegio come esterno. Cioè andava a scuola al mattino; a mezzogiorno mangiava ciò che si era portato da casa e al pomeriggio tornava a casa. La retta era di 25 lire al mese, pagata dall’arciprete, Don Giuseppe Bertazzoli che vedeva in Ottorino la stoffa del sacerdote.
Ricordando quel periodo, P. Sina dice: “Io ero povero e il papà mi dava ogni giorno quel tanto per comperarmi una fetta di una specie di torta dolciastra che costituiva il mio pranzo. A mangiarla andavo in refettorio dove gli altri studenti, molti figli di benestanti, sedevano davanti a tavole bene imbandite. Io mangiavo il mio pezzo di torta e poi, con più fame di prima, andavo a studiare fino alle 16.00, l’ora di tornare a casa dove continuavo lo studio e preparavo i compiti”.
L’incontro con i “piccoli missionari”
Il Collegio Arici era frequentato anche dagli alunni dell’Istituto Comboni. Arrivavano in fila e in silenzio come tanti soldatini con le loro divise ben stirate. Ascoltavano con attenzione le lezioni e poi, in silenzio come erano arrivati, tornavano a casa. I professori li guardavano con ammirazione perché sapevano che sarebbero diventati missionari d’Africa, apostoli, evangelizzatori, forse martiri. Anche Ottorino li guardava con uguale ammirazione e un po’ li invidiava.
Intanto il seme della vocazione che il Signore aveva seminato nel suo cuore l’anno prima, continuava a crescere e a buttare nuovi germogli. Un giorno il ragazzino manifestò ad un padre gesuita, un veneto, il suo desiderio di farsi missionario e questi lo invitò ad andare in Viale Venezia, dai Comboniani. Il papà, saputa la cosa, gli disse: “Se proprio insisti con la tua idea per le missioni, io non mi oppongo”. E gli diede il sospirato permesso.
Così Ottorino entrò nell’Istituto Comboni nel 1927 per frequentare la seconda media (che allora si chiamava ginnasio). Era superiore P. Giocondo Bombieri che poi sarebbe diventato suo padre maestro in noviziato. Questi, vedendo il nuovo venuto così magro e piccolo, lo fece visitare. “Ha solo patito tanta fame questo ragazzo – sentenziò il medico – ma è sano come un pesce”.
Allora esisteva solo la parte vecchia della casa e i ragazzi, pochi per la verità (nella classe di Sina erano in sei) avevano alcuni banchetti in fondo al refettorio dei padri e lì frequentavano le lezioni un po’ in qualche modo. Dal 1927, infatti, gli alunni dei Comboniani non andavano più all’Arici, ma avevano le loro scuole interne.
Nonostante una scuola così precaria, Ottorino faceva enormi progressi nello studio, anche perché gli piaceva studiare e aveva trovato il metodo giusto per farlo. I registri del tempo sono ancora custoditi nell’Archivio di Brescia. Ebbene, accanto al nome di Ottorino, ci sono solo “9” e “10” in tutte le materie. Anche come condotta le note dei superiori assicurano che Ottorino era un ragazzino “ordinato, studioso, esemplare, gentile con i compagni, bene educato e riservato, amante della preghiera, dello studio e del sacrificio”.
“L’ho conosciuto fin dal ginnasio, a Brescia – scrive P. Antonino Orlando. – Lui era in quinta ed io in prima. Era sempre il primo della classe, anche in quel lontano 1931 quando ricevette il primo premio dalle mani del Superiore Generale P. Pietro Simoncelli”.
Pure abitando a Brescia città anche Sina durante i quattro anni di permanenza a Brescia, non poté mai andare a casa. Allora si andava in vacanza in famiglia solo 5 giorni prima di entrare in noviziato. Durante il noviziato, che frequentò a Venegono Superiore, gli morì il papà. P. Bombieri gli concesse tre giorni per il funerale, però doveva andare a dormire all’Istituto Comboni. Cosa che Ottorino fece.
Prigioniero in Inghilterra
Ottorino entrò nel noviziato di Venegono Superiore, Varese, nel 1931 e fece la prima professione il 7 ottobre 1933. Poi rimase a Venegono per completare il liceo nel seminario di Milano a Venegono Inferiore. Per la teologia fu inviato a Roma insieme ad altri compagni. Studiò alla Pontificia Università Urbaniana dove conseguì la licenza in teologia summa cum laude.
Fu ordinato sacerdote a Roma il sabato Santo 8 aprile 1939, dal vescovo cappuccino Mons. Luca Ermenegildo Pasetto, nella chiesa dei Lazzaristi. Partì subito per l’Inghilterra per lo studio dell’inglese. Qui lo sorprese la seconda guerra mondiale per cui rimase “internato civile” nell’isola di Man fra i prigionieri italiani fino al 1947. Ma non perse tempo: oltre che al lavoro pastorale come cappellano e come insegnate ai prigionieri italiani, frequentò l’università di Londra conseguendo il titolo di Bachelor of Arts.
Questi anni di prigionia in Inghilterra meriterebbero una trattazione a parte e prolungata se consideriamo il bene che hanno fatto i nostri confratelli ai prigionieri italiani per utilizzare al meglio quel tempo di forzato riposo mediante l’attivazione di scuole e di altre attività intellettuali, senza parlare del conforto spirituale e psicologico che hanno saputo infondere in tanti cuori sfiduciati. Per questo periodo rimandiamo al libro “...e lo accolse nella sua casa” nel quale si racconta l’analoga vicenda di P. Renato Bresciani.
Al Collegio Comboni di Khartoum
Finalmente, nel 1947, P. Sina poté partire per l’Africa e fu assegnato a Khartoum, Sudan, dove lavorò per sei mesi al Comboni College come insegnante di lingua e letteratura inglese. E poi, nel 1962, oltre che insegnante, divenne consigliere di Mons. Baroni, e direttore del Comboni College. In questo incarico si mostrò un educatore di prima qualità. Il suo non era un compito facile con 950 studenti di tante razze e tante religioni e una trentina di professori. La sua responsabilità richiedeva fermezza, ma anche bontà, competenza ed equilibrio. Ed egli è riuscito a mettere d’accordo queste qualità tanto da farsi amare da tutti.
Scrive P. Giuseppe Farina che fu con lui molti anni: “Uomo semplice, quasi dimesso e schivo, era un lavoratore infaticabile. Quando lo incontrai nel 1958 era vice superiore della comunità dei missionari e rettore del Comboni College. La sua stanza da letto era attigua alla mia. Più di una volta ho notato che, dopo una giornata di intensa attività, non usava il letto per riposare, ma si accontentava di una sedia. Da quella posizione, un po’ studiava o correggeva i compiti e un po’ dormiva o metteva a punto i programmi. Vorrei dire che nella sua attività al Comboni College ha adottato il metodo del suo grande predecessore P. Agostino Baroni (che in quel periodo era vescovo di Khartoum) con il quale è sempre andato molto d’accordo”.
P. Antonino Orlando assicura che “fra tutti i Comboniani che insegnavano al Comboni College di Khartoum, P. Sina era uno dei più preparati. Seguì in modo tutto speciale gli studenti universitari, riuniti nella St. Augustine’s Society. Parlava l’inglese perfettamente ad aveva una memoria formidabile. Una sera, al Garden College, doveva leggere una conferenza sulla teoria dell’evoluzione. Purtroppo aveva dimenticato il testo scritto a casa. Non si scompose: svolse la sua conferenza parlando di getto… Pochi come lui hanno lavorato per preparare dei leaders sia nell’ambito scolastico come nella vita politica. Pochi come lui hanno amato i sudanesi. Con quanta gioia si dichiarava, come San Pietro Claver, a servizio degli africani… Insegnò inglese ai piccoli e ai grandi, spiegò il catechismo, seguì i catechisti, preparò le coppie che si preparavano al matrimonio…”.
Superiore provinciale e vicario generale
Nel 1965 P. Sina fu nominato superiore provinciale dei Comboniani residenti nel Nord Sudan. Nel 1969 andò al Capitolo Generale dell’Istituto a Roma e venne eletto vicario generale. Prima di allontanarsi da Khartoum diede la chiave della cassaforte all’amministratore dicendogli semplicemente: “Pensaci tu”. Qualche giorno dopo P. Giuseppe Farina aprì la cassa pensando di trovare qualche soldo. Invece trovò una scatola piena di biglietti con tanti nomi. Vi era scritto: “Prestato a Gabriele 5 sterline; prestato a John due sterline, ecc…” I biglietti erano tantissimi e tutti di quel tono. Sicuro che nessuno avrebbe restituito quei soldi, P. Giuseppe stracciò i biglietti. Certamente la carità di P. Sina era già registrata in cielo.
Il segreto di questo suo cuore generoso va cercato nell’infanzia di P. Sina. Un giorno, accompagnando un confratello alla casa dove era nato, disse: “Vedi quanta povertà! Eravamo in tanti e abbiamo vissuto un’esistenza stentata, il pane non sempre bastava, eppure io non ho mai visto la mia mamma o il mio papà mandar via qualche povero che bussava alla nostra porta”.
A Khartoum andava ogni venerdì alle prigioni per le confessioni dei cristiani. La prigione era uno stanzone non tanto grande, dal soffitto basso e con una sola finestrella, zeppo di detenuti legati con catene ai piedi e ai polsi. Il caldo e la puzza erano insopportabili, eppure P. Sina stava lì tutto il tempo che era necessario per dare un po’ di tranquillità e conforto a quegli uomini, molti dei quali erano in prigione solo perché avevano manifestato idee contrarie a quelle del regime.
Un uomo nella burrasca
Prima del Capitolo Generale, P. Sina presiedette la Commissione Precapitolare, molto importante per impostare il rinnovamento dell’Istituto richiesto dal Concilio Vaticano II. I capitolari poi lo elessero vicario generale dell’Istituto fino al 1975. Sappiamo che questi furono gli anni “bollenti” della contestazione giovanile e della “crisi di autorità” che ebbe i suoi riflessi anche nelle comunità religiose. Fu un periodo molto difficile.
P. Sina ebbe molta parte nel rinnovamento postconciliare dell’Istituto Comboniano. Inutile dire che questa sua incombenza di guida e moderatore in un periodo così turbolento, gli procurò qualche critica e incomprensione.
P. Giuseppe Zeno Picotti, che gli fu molto vicino, scrive: “Questo suo impegno (di applicare il Concilio) non è stato facile né indolore per le opposizioni che trovava in molti che ancora si aggrappavano alle vecchie tradizioni e ad un modo di vivere la vita religiosa ormai non più adatto ai tempi. Ha avuto anche il merito di aiutare, il Superiore Generale, P. Tarcisio Agostoni, in questo cammino di rinnovamento, anche se non senza difficoltà, ma con ottimo risultato. Erano momenti in cui gli ‘esperimenti’ di nuove vie più adatte ai tempi, specie nella formazione, richiesti però dal Concilio e dai documenti della Chiesa, potevano portare ad eccessive aperture. È fuori dubbio, comunque, che P. Sina abbia sempre agito in perfetta buona fede di cui io sono testimone. Egli ha sempre voluto aiutare l’Istituto e i Comboniani per un servizio più attuale al Regno di Dio, sfrondando tante strutture ormai obsolete e controproducenti, salvando tuttavia i veri valori della vita missionaria e della consacrazione religiosa, come il Concilio chiedeva”.
Superiore provinciale per la seconda volta
Dopo il Capitolo Generale del 1975, P. Sina ritornò a Khartoum dove fu eletto di nuovo superiore provinciale del Sudan. Nel 1982, con il ritorno dei Missionari nel Sud Sudan, chiese di andare al Sud dove i Comboniani erano stati espulsi 18 anni prima ed ora c’era tanto da fare. Fu trasferito in una semplice missione alla periferia di Juba, tra i poverissimi, dove ha aperto una scuola e una chiesa fatta di paglia e fango. Qui fu parroco per 10 anni. Sempre a Juba fondò il Comboni College, importante istituzione per la formazione dei leader.
Scrive P. Giuseppe Farina: “Anch’io andai al Sud in quel periodo. Posso testimoniare che P. Sina ha donato tutto se stesso senza risparmio. Spesso veniva da me che ero amministratore e mi diceva: ‘Vedi se puoi darmi qualcosa per i poveri che sono tanti; io non ho più nulla e non so dove sbattere la testa’. Un’altra cosa che mi ha colpito in P. Sina è stato il suo spirito di preghiera. Pregava molto, pregava bene. Proprio dalla preghiera traeva la forza per superare i momenti difficili della missione e della sua vita”.
“P. Sina – ha scritto P. Luigi Penzo che era assistente generale quando P. Sina era vicario generale e poi è stato suo compagno di missione – era stato arricchito dal Signore di doni straordinari. Possedeva un’intelligenza profonda. Conosceva benissimo le materie che insegnava, ma soprattutto conosceva bene l’Istituto, i nostri problemi, i confratelli e le persone con cui veniva a contatto. Egli possedeva anche una grande fede, e la sua conoscenza diventava ‘sapienza’, perché sapeva giudicare gli avvenimenti e le persone alla luce che gli veniva dal Signore. P. Sina possedeva anche una straordinaria apertura di mente, mentre diversi confratelli anziani andavano in crisi per ciò che succedeva nella Chiesa e nell’Istituto, egli non si turbava perché sapeva valutare tutto con quell’ottimismo cristiano che viene dalla speranza nel Signore”.
Nel 1992 avendo partecipato ad una manifestazione degli studenti contro l’imposizione della legge islamica ai non musulmani, fu espulso da Juba ed esiliato a Khartoum, da dove venne successivamente espulso nel 1995. Furono due momenti amari per P. Sina, tuttavia accettò la croce con serenità e calma, sicuro che Dio aveva i suoi piani anche in questa faccenda.
L’angelo dei rifugiati
P. Sina chiese allora di poter lavorare in Egitto per essere “rifugiato con i rifugiati Sudanesi”, come scrisse egli stesso in occasione del 60mo anniversario di Sacerdozio, celebrato al Cairo l’8 aprile 1999. In data 4 febbraio 1996 aveva scritto: “Accetto con gratitudine, anche se con dolore, di lasciare il Sudan per l’Egitto. Cercherò di fare quello che potrò per questa terra in cui Comboni fece tanto”.
In una relazione sulla sua attività al Cairo, scrisse: “Abbassyia, Cairo, Ahmed Said Street, N° 72. È il numero che appare sopra una porta di ferro, colore verde, lungo una delle principali arterie del traffico in una delle più grandi città del mondo, Cairo. Se riesci da aprirla, ti trovi all’entrata di un cortile lungo una sessantina di metri e largo sette, che termina con un’altra porta di ferro verde. Aprendola, ci si immette in una delle vie più strette del Cairo, Shurafa Street, non più di quattro o cinque metri di larghezza.
Questo cortile così corto e così stretto, è fiancheggiato da una parte da una chiesa alta e spaziosa, la chiesa del Sacro Cuore. Sul fianco opposto sorge un edificio di tre piani, quasi della stessa lunghezza del cortile. Lungo i lati di Ahmed Said Street e di Shurafa street s’innalzano fabbricati di dieci e più piani. Gli architetti che hanno costruito gli edifici che torreggiano ai quattro lati del cortile, sembra che si siano messi d’accordo nello sforzo di soffocare qualsiasi manifestazione di vita osasse affermarsi in quella specie di budello. Se questa era la loro intenzione, essi hanno fatto fiasco nel senso più completo della parola perché quel cortile così corto e così stretto pulsa ogni giorno di vita dalle prime ore del mattino fino alle ore più tarde della sera.
Se riesci ad aprire una delle due porte verdi, vedrai il cortile formicolare di ragazzi e di ragazze, tutti neri, dai cinque ai quindici/sedici anni d’età, dalle sei o sette del mattino fino alle cinque del pomeriggio. Sono i figli e le figlie dei sudanesi scappati dal Sudan. Il nome ufficiale della scuola è “St. Charles Lwanga Basic Education Centre”, conosciuta dal governo egiziano ma non riconosciuta ufficialmente, con più di mille alunni divisi in due turni di classi che vanno dalla scuola materna all’ottava”.
Il cortile del miracolo
“Prima del suono del campanello che segna l’inizio delle lezioni, vedresti queste centinaia di ragazzi e di ragazze abbandonarsi al gioco con slancio irresistibile. Sono evidentemente pieni di gioia per il dono della vita e danno espressione alla loro gioia nei modi più spontanei. Ma al suono del campanello si allineano in silenzio per la preghiera o il canto dell’inno nazionale sudanese, cantato a squarciagola e con entusiasmo incontenibile, per infilarsi poi in aule designate per una quarantina di alunni, ma destinate a contenerne sessanta e anche più. Il cortile così corto e così stretto, le aule che lo circondano, sono il teatro della loro attività fino, come già detto, alle ore cinque del pomeriggio. A quell’ora esso si spopola di ragazzi e di ragazze, ma solo per ripopolarsi immediatamente di giovani e di anziani, uomini e donne, anche loro tutti neri e in gran parte alti come giganti, vestiti impeccabilmente, con scarpe lucide, col sorriso sulle labbra che spesso si cambia in risate sonore che echeggiano da un fianco all’altro del cortile. Questi nuovi frequentatori del cortile sono i padri, le madri, i fratelli, le sorelle dei frequentatori del mattino e del pomeriggio. Vengono dai vari quartieri del Cairo per incontrarsi e scambiare le loro esperienze, felici e infelici, o per darsi all’una o all’altra delle molte attività di formazione umana e cristiana che il Centro offre loro.
Dopo le cinque, il cortile ritorna ancora a popolarsi di nuovo di ragazzi e di ragazze che l’avevano invaso alla mattina. Vi ritornano per abbandonarsi di nuovo al gioco come la mattina o per partecipare anche loro ad una o all’altra delle attività di formazione adatte a loro. Allora vedi i più giovani e gli anziani raggruppati in crocchi di tre o quattro, in piedi o seduti, discutere animatamente fra di loro, indisturbati dai ragazzi tutti intenti ai loro giochi, che si intrufolano tra i crocchi senza disturbarsi a vicenda. È chiaro che, sia i grandi come i piccoli, amano questo luogo di ritrovo, perché quando arriva l’ora in cui lo devono lasciare per tornare a casa, bisogna quasi forzarli ad andarsene”.
Far causa comune
“Osservando il sorriso che appare costantemente sulle labbra di grandi e piccoli, ascoltando le risate sonore che risuonano di continuo nel cortile, guardando la gioia e la spensieratezza dei più piccoli, si direbbe che tutta questa gente non ha nessun problema. Invece tutti, senza eccezione, anche se in maniera diversa, hanno problemi più numerosi e più intricati dei folti capelli che coprono le loro teste. Infatti sono tutti, grandi e piccoli, sudanesi scappati dal loro paese per sfuggire alle vessazioni, alla persecuzione e alle torture a cui erano esposti”.
Parlando dei rapporti di P. Sina con i sudanesi, P. Penzo scrive: “Aveva il cuore aperto agli altri, pieno di comprensione e di bontà. Li amava, si sentiva coinvolto nella loro vita, nei problemi e nella loro tragica storia. In questo egli è stato un vero Comboniano perché ha saputo far causa comune con i più poveri. Pensando a lui mi vengono in mente le parole di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 2 ‘Voi siete testimoni che mi sono comportato in mezzo a voi come una madre, per la tenerezza che vi ho dimostrato; e come un padre per il lavoro perseverante che ho fatto per amor vostro’. Ma P. Sina possedeva in grado sublime la virtù dell’umiltà. Rifuggiva da tutto ciò che era esteriorità. Ha lavorato nel nascondimento, non ha mai messo in mostra le sue doti e non si è mai vantato di ciò che faceva. Anche a questo punto penso a Paolo quando descrive la sua vita ai presbiteri di Efeso, nel capitolo 20 degli Atti: ‘Il Signore mi è testimone come io abbia vissuto in mezzo a voi con tutta umiltà, servendo lui e servendo voi, sacrificandomi per voi e lavorando per voi notte e giorno per portarvi alla fede nel Signore Gesù’. Ora me lo sento vicino come una santo, un amico, un protettore”.
Il calvario dei sud sudanesi
“Il Sudan – scrisse P. Sina - divenne indipendente il 1° gennaio 1956. Nei cinquant’anni precedenti era stato un condominio Anglo-egiziano, durante il quale il principale condomino del paese, l’Inghilterra, era riuscita a mantenere una convivenza pacifica tra il nord del Sudan, arabo di lingue e cultura e musulmano di religione, e il Sud africano-nero di cultura e praticante la religione africana tradizionale o, nel caso di una minoranza sempre crescente, la religione cristiana.
Già prima dell’indipendenza era cominciato lo scontro tra il Nord, deciso a imporre la propria cultura e religione, e il Sud ugualmente deciso a conservare la propria cultura e religione. Lo scontro degenerò ben presto in una guerra civile che, iniziata nel 1956, si protrasse fino al 1972, devastando il Sud e costringendo centinaia di migliaia di abitanti a cercare rifugio nei paesi limitrofi, quali l’Etiopia, il Kenya, l’Uganda, il Congo, la Repubblica Centrafricana. Nel 1972 il capo del governo di Khartoum, il generale Jafar el Nimeiry, che deteneva il potere, decise di concedere al Sud una certa misura di autonomia locale e di non insistere troppo sull’arabizzazione e islamizzazione del Sud, attraverso l’accordo di Addis Abeba, firmato in quella città dai rappresentanti delle due parti del Sudan nello stesso anno.
Le clausole di quell’accordo furono osservate con relativa fedeltà fino al 1982, quando lo stesso capo del governo di Khartoum che le aveva firmate, decise di ignorarle e di riprendere ad oltranza il tentativo di arabizzare e islamizzare il Sud. Questa decisione segnò l’inizio di una seconda guerra civile fra Nord e Sud, più crudele e devastatrice della prima. Iniziata nel 1983, essa non dà alcun segno di voler terminare. Anch’essa, ancor più della prima, causò la fuga di centinaia di migliaia di sudanesi dal Sud verso gli stessi paesi limitrofi e anche verso il Ciad, la Libia e l’Egitto.
La fuga dal Sud verso l’Egitto avviene in due stadi. La prima è la fuga dal Sud verso il Nord del Sudan per sfuggire agli attacchi e bombardamenti dell’esercito del Nord e alle milizie delle tribù governative e alle tribù arabe che attaccano e distruggono villaggi e città dandole alle fiamme e portando via, non solo il bestiame, ma anche le donne e i bambini come schiavi e costringendo chi può a darsi alla fuga verso il Nord.
L’arrivo al Nord non coincide con il termine delle malversazioni da parte del governo centrale. È seguito da imprigionamenti, torture incredibili, dall’arruolamento forzato dei giovani nell’esercito nazionale e dal loro invio al Sud per combattere e uccidere la propria gente. Per evitare tutti questi mali ed altri ancora, i sudanesi del Sud, una volta arrivati al Nord, cercano rifugio in Egitto sperando di trovare un termine alle loro sofferenze.
Il loro numero, all’inizio un piccolo rigagnolo, è andato aumentando continuamente. Ogni venerdì arrivano dal Sudan alcune centinaia di sudanesi del Sud: donne, bambini, giovani, adulti. Sostano all’esterno della porta N° 72 di Ahmed Said Street, attendendo che amici o parenti arrivati prima di loro, diano loro ospitalità.
La stragrande maggioranza di loro si stabilisce al Cairo o nella zona del delta. Si calcola che il loro numero complessivo si aggiri attorno ai 30.000 o 35.000. La loro speranza è quella di poter trovare una sistemazione in Egitto o in uno dei paesi disposti ad accettarli come profughi: l’America, il Canada, l’Australia. Purtroppo tali speranze sono destinate ad essere in gran parte deluse”.
Gente sradicata
“La migliore parola per descrivere la situazione in cui si trovano i sud sudanesi arrivando in Egitto, è quella coniata dalle Organizzazioni Internazionali. In inglese essa è uprooted che in italiano significa ‘sradicati’. Questa parola non significa solo che i profughi sudanesi vengono violentemente sradicati dall’ambiente naturale in cui sono nati e cresciuti. Essa esprime anche tutta la difficoltà che avranno nel gettare radici in un terreno culturale tutto differente. Questo è ciò che attende i sudanesi del Sud al loro arrivo in Egitto.
L’ambiente egiziano è assai differente da quello sudanese. Arrivando in Egitto, i sudanesi non sono accolti a braccia aperte e respirano un’atmosfera differente da quella del Sudan. I sudanesi in Egitto non hanno alcun diritto; sono lasciati vivere in pace se non commettono sbagli, se non danno nessun disturbo. In Egitto non sono più esposti ai pericoli e alle sofferenze della guerra civile, ma questo è tutto ciò che possono attendersi. Eppure questa gente è ottimista.
Per quanto riguarda i piccoli, si potrebbe attribuire l’ottimismo alla spensieratezza naturale di tale età e al fatto che da una parte non hanno ancora esperimentato tutte le difficoltà e amarezze della vita propria dei grandi e dall’altra al fatto che la vita presenta loro quotidianamente nuove esperienze che assorbono il loro continuo interesse. Ma questo non si può affermare dei più grandi che hanno già avuta una vita tribolata, segnata da sofferenze, persecuzioni e magari torture.
All’inizio della mia presenza tra i sudanesi d’Egitto, attraverso la conversazione con loro, cercai una risposta a questa domanda. Ed eccola: “Noi sudanesi del Sud siamo convinti che il Sudan è il nostro paese datoci da Dio stesso. Anche se per adesso Egli ha permesso che ne siamo allontanati, questo non può durare per sempre, perché egli è misericordioso e giusto. Verrà un giorno, forse presto, quando potremo tornare alla terra che lui ci ha dato”.
Salvare l’Africa per mezzo degli africani
“Noi, sparuto gruppo di Comboniani al Cairo, cerchiamo di tener vivo questo incrollabile ottimismo dei sudanesi del Sud aiutandoli a risolvere i loro problemi e a creare una specie di atmosfera in cui, se non possono gettar radici, possono almeno respirare e vivere. In ossequio allo spirito del nostro Fondatore, il Beato Daniele Comboni, che è quello di salvare l’Africa per mezzo degli africani, coinvolgiamo i sudanesi stessi in tutte le nostre attività. Esse sono tutte, senza eccezione, programmate da un consiglio pastorale composto di rappresentanti delle varie tribù ed eseguite sotto la sua alta sorveglianza.
Il cortile corto e stretto di Ahmed Said Street, N° 72, ha un ruolo molto importante nel tenere alto il morale dei sudanesi del Cairo. Le varie attività che vi si svolgono, da una parte sono una medicina che sana tante ferite versandovi sopra l’olio della condivisione di esperienze felici o meno felici. Al momento di lasciare il cortile per far ritorno alle proprie case i pesi che gravavano sulle spalle di ciascuno sono diventati un po’ più leggeri con l’essere messi anche sulle spalle degli altri. Dall’altra parte, le stesse attività del Centro, danno nuova forza agli spiriti rinfrancandoli per la lotta quotidiana. “Aetiopum semper servus” era il motto che San Pietro Claver a Cartagena continuava a ripetersi e che animava lo spirito con cui si dedicava al servizio degli Africani che approdavano a quel porto. Non pretendo di paragonare noi stessi, almeno non me stesso, a quel grande santo e apostolo dei neri. Vorrei dire che noi Comboniani, che l’abbiamo preso come uno dei nostri santi patroni, al Cairo come lui a Cartagena (mi pare di poterlo dire con tutta verità e tutta umiltà) cerchiamo di non risparmiarci in nulla. E se qualche volta sotto “il pondus diei et oestus” veniamo in qualche misura meno al nostro impegno di servi degli africani, il Signore ci dà la sua grazia affinché riprendiamo il nostro lavoro di servi degli africani con maggior alacrità”.
Fino alla fine
P. Sina continuò a servire con tanto zelo, generosità e coraggio. Nonostante l’età, si impegnò in modo particolare nella formazione dei catechisti e nella pastorale matrimoniale in parrocchia e nei neo-nati centri per i Sudanesi nella periferia del Cairo. Era sempre disponibile anche per l’assistenza spirituale nelle diverse comunità religiose.
I rifugiati sudanesi, senza casa, senza lavoro, senza assistenza sanitaria, in attesa di una qualsiasi sistemazione, diventarono lo scopo della sua vita. P. Sina era spesso negli uffici governativi del Cairo per seguire le pratiche degli immigrati. Questo lavoro gli era facilitato dalla conoscenza delle lingue (arabo, francese, inglese) e dal suo modo gentile di trattare, ma gli comportava tanta fatica fisica. Tuttavia non si è mai tirato indietro.
In una lettera del 19 novembre 2002 scrisse: “Nei tre centri scolastici abbiamo 1.800 scolari. Io non ho più nessun insegnamento, ma il vedere tutta questa gioventù, così piena di vita e di gioia nonostante i loro problemi, mi riempie il cuore di tanta consolazione”.
Scrive P. Picotti: “Alla fine di novembre 2002 le forze cominciarono a venirgli meno e fu ricoverato per 33 giorni in ospedale senza nessun risultato. Aveva chiesto di poter essere curato in Italia col solo desiderio di poter tornare e riprendere il suo lavoro, ma la sua situazione precipitò durante la notte tra il 12 e il 13 gennaio, e il Signore lo chiamò al premio finale la sera del 16 gennaio 2003. Amorevolmente assistito dai confratelli, dalle Suore Comboniane e da alcuni amici sudanesi si spense all’età di 88 anni. I sudanesi lo piangono come avessero perso un padre, i confratelli e le suore per non aver più un esempio e una guida”.
Al funerale, di fronte a centinaia di persone raccoltesi per il saluto finale ad un vero fratello e padre, Mary, una catechista sudanese, ha pregato con queste parole: “Signore, c’è uno di noi, P. Philip Sina, che è vissuto tra di noi ed ora è con te in cielo. Egli conosceva e aveva sperimentato il nostro dolore, conosceva così bene le ingiustizie che abbiamo subito per tanto tempo: ascoltalo, Ti preghiamo, è il nostro avvocato.”
P. Cosimo Spadavecchia, che con P. Sina aveva lavorato in Cairo per sei anni, così si è espresso durante l’omelia: “P. Philip veramente ci ha mostrato chi è Gesù... Era sempre pronto a ricevere chi lo cercava e ad ascoltarlo. A chi gli chiedeva spiegazione della Parola di Dio era sempre pronto a mostrare Gesù.... Sul suo letto nell’ospedale soffriva: tanti andavano a trovarlo ma lui non lasciva vedere la sua sofferenza, perché era in unione con il Cristo sofferente. È quando è morto era in unione con Cristo. È morto pregando e con il Cristo Crocifisso può dire: “Guardate, sono innalzato davanti a voi”.
Certamente P. Sina è stato uno dei grandi nel campo dell’educazione. “Oggigiorno – scrive P. Antonino Orlando – si parla tanto di poveri da sfamare in terra di missione e spesso ci si dimentica di quanto progresso culturale e civile abbiano apportato i missionari con le loro scuole che hanno acceso una fiaccola di sapere nel Sudan e nel mondo ed hanno avviato migliaia di giovani d’ambo i sessi a percepire il valore di un dialogo tra cristiani e musulmani, che ha già dato i suoi frutti e che ne darà ancora di più in avvenire. Nel ricordo di P. Sina voglio elevare un inno di lode in favore di tutti quei Comboniani che hanno dato i più bei decenni della loro vita missionaria nell’insegnamento nelle scuole. Non interviste per loro, né seguito di mass media, ma un duro lavoro nel silenzio, noti solo a Dio”.
Ora P. Ottorino Sina riposa nel cimitero di Helwan accanto a P. Paolo Adamini, l’altro missionario bresciano recentemente scomparso,che pure aveva speso tutta la sua vita al servizio dei Sudanesi. P. Lorenzo Gaiga, mccj