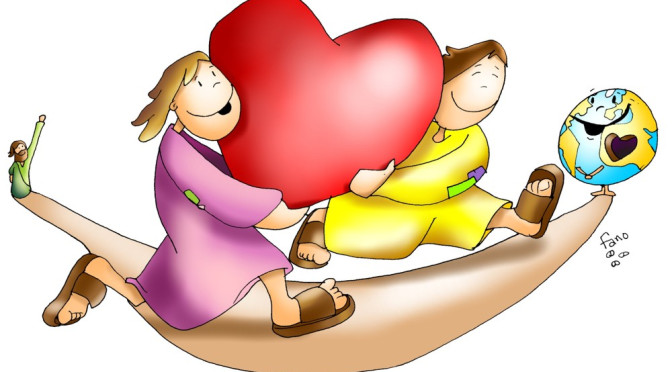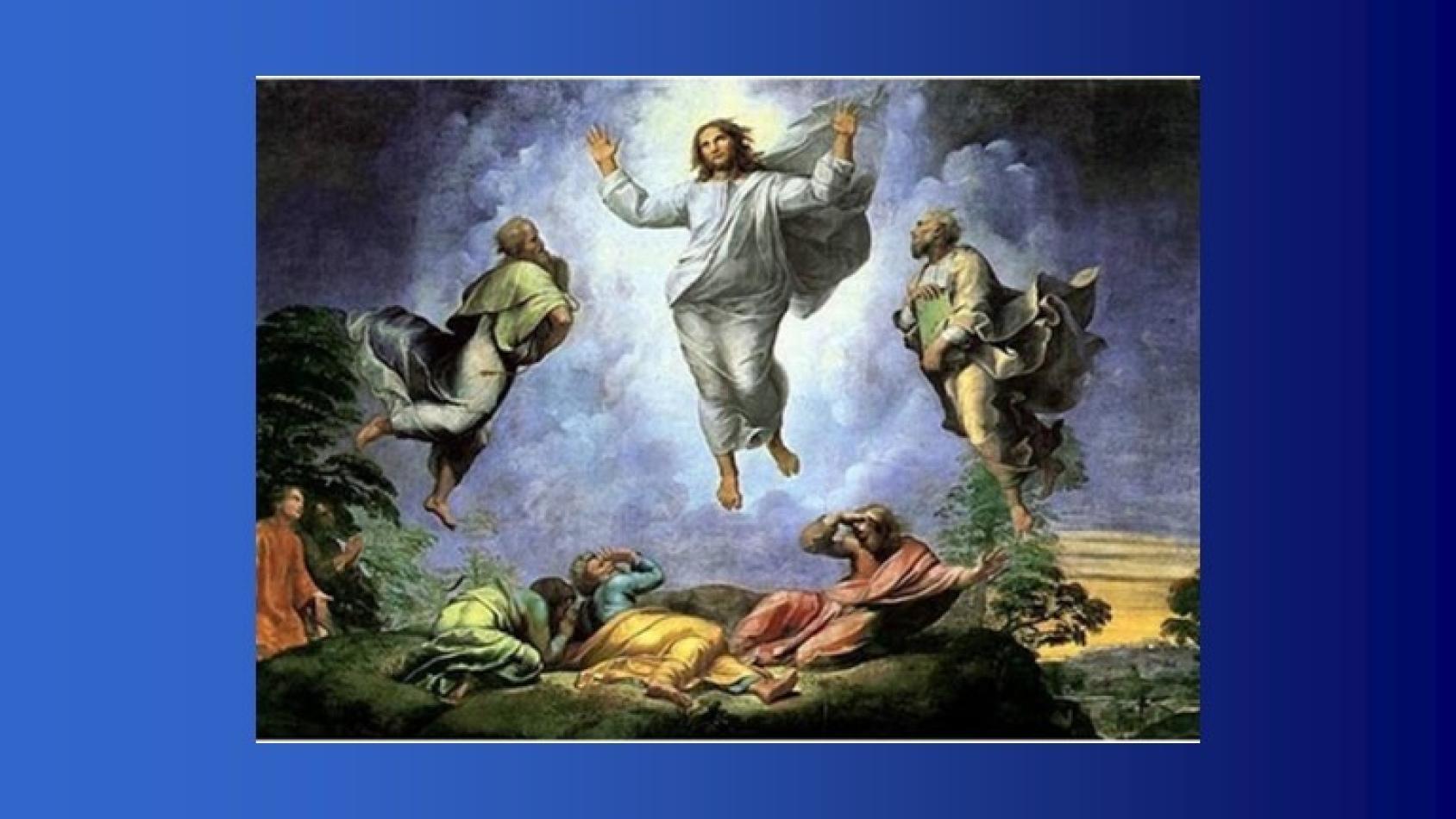Daniel Comboni
Comboni Missionare
Institutioneller Bereich
Andere Links
Newsletter
Mit den letzten beiden Sonntagen der Osterzeit treten wir in die unmittelbare Vorbereitung auf die Feste Christi Himmelfahrt und Pfingsten ein. Es sind die Sonntage des Abschieds. Das Evangelium dieses und des nächsten Sonntags bietet uns Abschnitte aus der Abschiedsrede Jesu an seine Jünger während des Letzten Abendmahls. Es handelt sich um sein Testament vor seinem Leiden und Tod. [...]
Die wahre Neuheit ist die Liebe
„Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander!“
Johannes 13,31–35
Mit den letzten beiden Sonntagen der Osterzeit treten wir in die unmittelbare Vorbereitung auf die Feste Christi Himmelfahrt und Pfingsten ein. Es sind die Sonntage des Abschieds. Das Evangelium dieses und des nächsten Sonntags bietet uns Abschnitte aus der Abschiedsrede Jesu an seine Jünger während des Letzten Abendmahls. Es handelt sich um sein Testament vor seinem Leiden und Tod.
Warum werden diese Texte gerade in der Osterzeit gelesen? Die Kirche folgt der alten Tradition, in dieser Zeit die fünf Kapitel des Johannesevangeliums zu lesen, die sich auf das Letzte Abendmahl beziehen (Kapitel 13 bis 17), in denen Jesus den Sinn seines Todes und seiner „Pascha“ erklärt.
Man könnte auch sagen, dass ein Testament erst nach dem Tod eröffnet wird. Jesus hinterlässt sein Erbe, seinen Besitz, uns – seinen Erben. Das herausragende Vermächtnis ist das Gebot der Liebe, das Thema des heutigen Evangeliums.
1. Ein Wort vereint die drei heutigen Lesungen: NEU oder NEUHEIT
- In der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte wird von der Neuheit berichtet, die Paulus und Barnabas der Gemeinde von Antiochia mitteilen, die sie auf Missionsreise geschickt hatte: „wie Gott den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet hatte“.
- In der zweiten Lesung aus der Offenbarung sieht Johannes „einen neuen Himmel und eine neue Erde“ und „die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen“ und hört die Stimme sagen: „Siehe, ich mache alles neu.“
- Im Evangelium gibt Jesus uns „ein neues Gebot“.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der Langeweile überwiegt, besonders unter jungen Menschen. Wir brauchen ständig Anreize, Neuheiten, um unseren Alltag ansprechender und attraktiver zu gestalten. Leider verwechseln wir Neuheit oft mit bloßer Abwechslung. Viele sogenannte Neuheiten sind nur alte Dinge im neuen Gewand und altern schnell, hinterlassen uns enttäuscht und unzufrieden.
Echte Neuheiten hingegen machen uns oft Angst, weil sie unsere Prinzipien und unseren Lebensstil erschüttern. Sie verlangen von uns ein „Neu-geboren-werden“, wie Jesus zu Nikodemus sagte (Joh 3,3).
Dies gilt für jeden Christen, ebenso wie für jede christliche Gemeinschaft und die ganze Kirche. Die Treue zur Tradition darf nicht zum Vorwand werden, sich ins Vergangene zurückzuziehen, an alten, überholten Traditionen festzuhalten. Der Vorwurf, die Kirche sei in der Vergangenheit verhaftet, muss uns dazu bringen, unsere Offenheit für das erneuernde Wirken des Geistes zu hinterfragen.
Das Hören und Annehmen des Wortes, das uns Neuheit bringt, verlangt von uns einen offenen Geist und ein offenes Herz. Die Gefahr besteht darin, sich dem Neuen zu verschließen, das immer ein wenig Unordnung in unser Leben bringt. Noch schlimmer wäre es, wenn dieses Wort für unser Ohr „alt“ klingt – nur weil wir es schon so oft gehört haben. Beten wir also zum Herrn, dass er uns zu „neuen Schläuchen“ mache, um seinen „neuen Wein“ zu empfangen!
2. Eine neue HERRLICHKEIT
„Als Judas hinausgegangen war [aus dem Abendmahlssaal], sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht.“
Beim Hören des heutigen Evangeliums richtet sich unsere Aufmerksamkeit sofort auf das „neue Gebot“, aber diese Neuheit wird von einer anderen eingeleitet – einer unverständlichen, erschütternden und skandalösen –, weil sie unsere Sicht der Realität auf den Kopf zu stellen scheint.
Als Judas hinausgeht, um ihn zu verraten, spricht Jesus nicht etwa von Trauer oder Schmerz, sondern von „Verherrlichung“ – und das gleich fünfmal. Jesus verbindet seine Herrlichkeit und die Gottes mit dem Verrat des Judas! Welche Art von Herrlichkeit ist das? Es ist die, am Kreuz erhöht zu werden, denn das Kreuz ist der höchste Ausdruck der Liebe Gottes.
Judas verkörpert die Vorstellung eines „siegreichen“ Messias; Jesus hingegen offenbart sich als ein „besiegter“ Messias. Der wahre Messias folgt der Logik der Liebe. „Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe – um es wieder zu nehmen“ (Joh 10,17), sagte der Gute Hirte am vergangenen Sonntag.
Diese verkehrte Sicht der Realität ist ein Schlag in den Magen angesichts unserer ständigen Suche nach „Ehrgeiz“ und Eitelkeit. Fragen wir uns also: Welche Art von Herrlichkeit suche ich – in meinen Gedanken, in meinen Wünschen, in meinen Fantasien und Absichten? Die Art der Herrlichkeit, die wir suchen, offenbart, ob wir glauben oder nicht. Jesus sagt: „Wie könnt ihr glauben, wenn ihr voneinander Ehre annehmt, aber nicht die Ehre sucht, die vom einzigen Gott kommt?“ (Joh 5,44)
3. Ein neues GEBOT
„Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander.“ (vgl. auch Joh 15,12 und 15,17)
Worin besteht diese Neuheit?
- Es ist „neu“, weil es nicht spontan oder natürlich ist, es entspringt nicht dem Instinkt.
- Es ist neu, weil es auf Unentgeltlichkeit beruht, nicht auf Gegenseitigkeit.
- Es ist neu, weil es das alte „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ aufhebt.
- Es ist neu, weil es über die Weisheit des alten Gebotes hinausgeht: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lev 19,18).
- Es ist neu, weil jetzt Jesus selbst das Maß der Liebe ist: „Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.“
- Es ist neu, vor allem weil es nie veralten wird. Was in der Zeit lebt, wird irgendwann alt. Doch was zu den „neuen Himmeln und der neuen Erde“ gehört, altert nicht mehr, denn es nimmt Anteil an Gottes Ewigkeit.
- Es ist neu, weil es das letzte und endgültige, das eschatologische Gebot ist. Glaube und Hoffnung werden vergehen, doch nur die Liebe bleibt bestehen (1 Kor 13,13). Denn die Liebe ist das Wesen Gottes: „Gott ist die Liebe“ (1 Joh 4,8). Daher macht es keinen Sinn mehr, zwischen Gottesliebe und Nächstenliebe zu unterscheiden, zwischen „vertikaler“ und „horizontaler“ Liebe, denn die Liebe ist eine.
Diese Art von Liebe wird das entscheidende Kriterium sein, um den Jünger Jesu zu erkennen:
„Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.“
4. Wie erlangen wir diese neue LIEBE?
Es heißt: „Dem Herzen kann man nicht befehlen.“ Wie können wir also diese Liebe empfangen? Durch das Betrachten der Eucharistie, wo diese Liebe gefeiert wird. „Indem wir den Blick auf Jesus richten“ (Hebr 12,2). Indem wir den Gekreuzigten mit Liebe und Zärtlichkeit betrachten, wo diese Liebe sich vollendet hat.
Oder, um es mit den Worten des heiligen Daniele Comboni zu sagen, der zu seinen Missionaren sprach:
„Die Augen stets auf Jesus Christus gerichtet halten, ihn zärtlich lieben und immer besser zu verstehen suchen, was es heißt, dass ein Gott für das Heil der Seelen am Kreuz gestorben ist. Wenn sie mit lebendigem Glauben dieses Geheimnis so großer Liebe betrachten und genießen, werden sie selig sein, alles zu verlieren und für ihn zu sterben – mit ihm.“ (Schriften, 2721–2722)