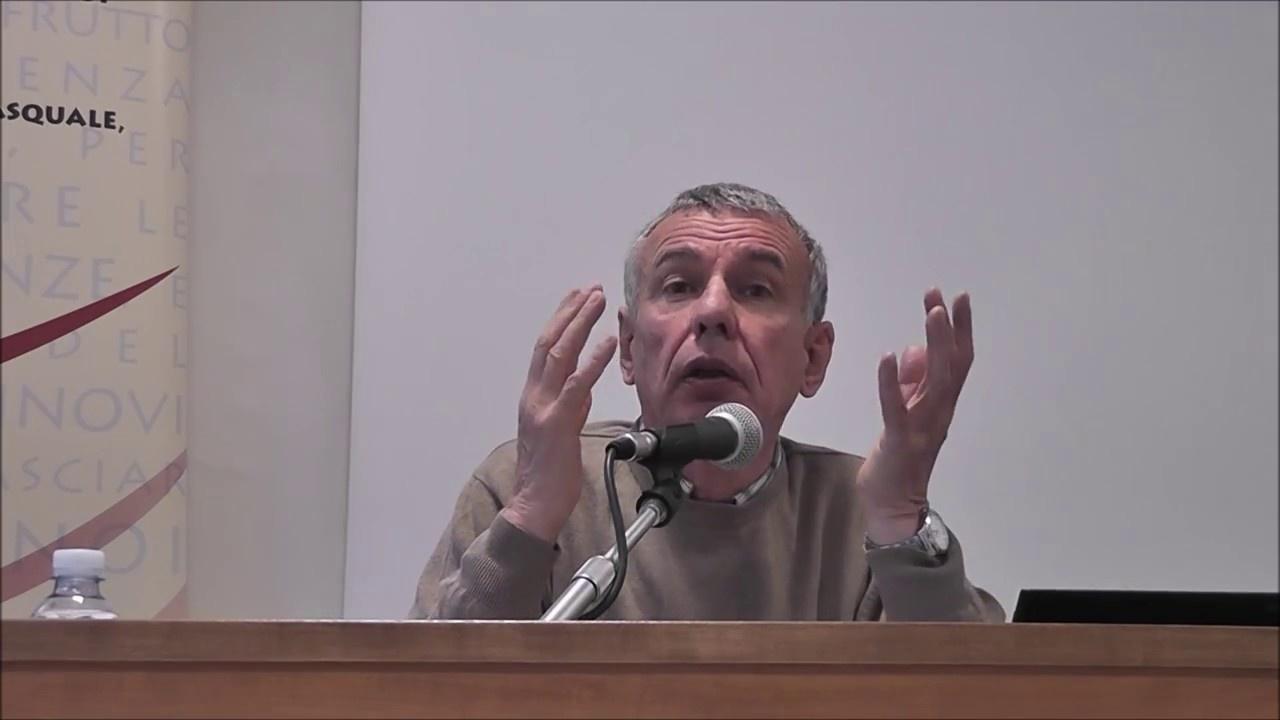Daniel Comboni
Comboni Missionare
Institutioneller Bereich
Andere Links
Newsletter
Lunedì 19 maggio 2025
Il Vescovo di Bentiu, mons. Christian Carlassare, ci racconta la festa per l’anniversario della fondazione della missione di Yoynyang, nata grazie al sostegno della Diocesi di Como. “Penso che questo gemellaggio – dice mons. Christian – sia nato grazie alla figura del vicario apostolico di Karthoum, mons. Paolo Tranquillo Silvestri (nato a Livigno l’11 giugno 1876 e morto a Rebbio il 22 gennaio 1949, ndr), consacrato vescovo proprio nella cattedrale di Como nel dicembre 1924”.
Nel cuore d’Africa c’è una piccola Como o, forse, dovremmo dire c’era una piccola “Como africana”. Era proprio con questo appellativo o con il termine “Nuova Como” che sulla rivista dei missionari comboniani dell’epoca – La Nigrizia – ci si riferiva alla missione di Yoynyang fondata nel 1925 lungo il corso del Nilo Bianco dai compagni di San Daniele Comboni, in quello che oggi è il nord del Sud Sudan. Una terra allora remota, abitata dal popolo Nuer, che era possibile raggiungere solo a bordo di piroscafi che percorrevano, controcorrente, il corso del fiume. A cento anni di distanza, tra guerre civili, espulsioni dei missionari, epidemie e inondazioni, la Chiesa è ancora presente, viva grazie soprattutto alla fede tenace dei catechisti, tanto da aver festeggiato domenica 11 maggio questo importante anniversario. Ne abbiamo parlato con mons. Christian Carlassare, vescovo di Bentiu, diocesi sotto la cui giurisdizione ricade oggi il territorio della missione di Yoyniang. Il religioso comboniano ci ha raccontato il significato profondo di questo anniversario e il legame di questa missione con la diocesi di Como.
Vescovo Carlassare, cosa ha significato per lei e la sua Chiesa questo anniversario?
«Prima di tutto significa gratitudine al Signore, perché essere ancora qui dopo cent’anni è un dono. I missionari comboniani arrivarono a Yoynyang nel 1925, e quel nome – in lingua Nuer – è stato tradotto come “Nuova Como”, a testimonianza di un legame profondo con l’Italia e con la vostra diocesi. Ma solo quattordici anni dopo, nel 1939, dovettero abbandonare la missione. La colonia inglese, allora al potere, non gradiva la presenza di missionari italiani in un’area strategica e vicina al confine con l’Etiopia. Subentrarono allora i missionari inglesi, che continuarono l’opera fino al 1964. Poi anche loro vennero espulsi, questa volta dal governo di Khartoum e, insieme a loro, circa 200 missionari comboniani allora presenti nel Paese. Tutte le missioni vennero abbandonate. Da quel momento, la presenza ecclesiale fu fragile, ma non scomparve.
Furono i catechisti laici, a mantenere viva la fede. E grazie a loro, la Chiesa ha resistito. Negli anni ’70 fu ordinato il primo prete Nuer, padre Zaccaria Bol Chatiem, che riaprì la missione come parrocchia, portandola avanti fino allo scoppio della seconda guerra di indipendenza, nel 1983. I comboniani tornarono solo nel 1996, ma non a Yoynyang, bensì in una zona rurale più a sud. In quegli anni si era formato un piccolo gruppo di missionari che rientravano nei territori liberati dalla guerriglia. L’area di Bentiu, sotto il controllo governativo, era inaccessibile, ma i villaggi attorno venivano raggiunti. Un lavoro difficile, in una zona vastissima, estesa quasi quanto la Lombardia. Eppure si è continuato, sempre a fianco dei laici, che sono stati la vera spina dorsale della Chiesa. Celebrando questi 100 anni, guardiamo indietro a una storia sofferta ma viva».
Ci racconta qualcosa del legame tra questa missione e Como?
«Ho letto degli articoli storici della rivista Nigrizia che parlano della fondazione della missione e menzionano proprio il nome “Nuova Como” dato a Yoynyang. All’epoca, ogni nuova missione riceveva il patrocinio di una diocesi italiana. Penso che questo gemellaggio sia nato grazie alla figura del vicario apostolico di Karthoum, mons. Paolo Tranquillo Silvestri (nato a Livigno l’11 giugno 1876 e morto a Rebbio il 22 gennaio 1949, ndr), consacrato vescovo proprio nella cattedrale di Como nel dicembre 1924. Questa missione, fortemente voluta da lui, nacque anche grazie al sostegno economico e spirituale della diocesi comasca. Bisogna pensare che allora avviare una missione comportava costi enormi: lunghi viaggi in battello, la costruzione delle case, della scuola, del catecumenato. La popolazione locale non avrebbe mai potuto sostenerne le spese».
Allora il tasso di mortalità tra i religiosi era altissimo...
«La missione in Africa Centrale, fin dai tempi di Comboni, ha chiamato molti giovani a donare la vita. Un missionario che partiva dall’Italia sapeva che forse non sarebbe mai tornato. I viaggi erano lunghi, e spesso si moriva di malaria o altre malattie. Accanto a ogni missione, c’è sempre un piccolo cimitero. Sulle lapidi leggi nomi di persone morte a 30, 35, 40 anni. Comboni stesso morì a 50 anni di febbre malarica: un’eccezione, direi. Queste persone, con tutti i loro limiti, hanno affidato la loro vita al Signore. Non erano eroi, ma avevano un grande desiderio di annunciare il Vangelo. Comboni credeva che la parola del Vangelo fosse fonte di vita e di dignità, una luce capace di riscattare chi era schiacciato dalla miseria e dalla paura. E ancora oggi vediamo che, quando è vissuto in profondità, il Vangelo cambia le persone. Libera dai legami della vendetta, della violenza, della superstizione».
Cosa abbiamo da imparare oggi da quello slancio missionario?
«Purtroppo oggi abbiamo perso la spinta missionaria. Pensiamo che vada bene così: ognuno creda a quello che vuole, e se è una brava persona, Dio sarà misericordioso. È vero, ma non basta. Dovremmo capire quanto sia importante la conversione al Vangelo. La Chiesa deve mantenere vivo il carisma dell’annuncio, il desiderio di passare ad altri la Buona Notizia della Risurrezione, che sconfigge la morte e tutto ciò che porta morte. Anche la nostra società occidentale, pur diversa, affronta le sue sfide. È una società che non dà più vita, che ha perso la speranza. In questo l’Africa ha tanto da insegnarci: nonostante le contraddizioni, è aperta alla vita. Più del 50% della popolazione ha meno di 21 anni. Le Chiese sono piene di giovani, l’80% dei fedeli in alcune parrocchie sono ragazzi e ragazze in cerca di senso, di fiducia, di una visione per il futuro. Spesso i loro sogni vengono spezzati da istituzioni corrotte, da governi che li manipolano per il potere. Ma nella Chiesa trovano una liberazione: la possibilità di essere sé stessi, di esprimere i propri doni, di vivere la vocazione che il Signore ha dato loro».
Il Sud Sudan è oggi uno dei Paesi più poveri del mondo, dove la guerra ha lasciato conseguenze pesanti sulla vita della popolazione…
«Il conflitto interno del 2013-2019 ha distrutto tutto. A Bentiu e Rukona si trovano i campi più grandi del Paese: 140.000 persone che vivono ancora lì. Dopo la firma dell’accordo di pace – anche grazie al gesto profetico di Papa Francesco che baciò i piedi dei leader – la pace è arrivata, ma non la ripresa. La situazione economica è disastrosa, la moneta svalutata, e la gente non ha potuto ricominciare da capo. Nel 2019 è arrivata anche un’inondazione del Nilo, che ha colpito il 40% del territorio della Diocesi. Nel 2023 ha raggiunto addirittura il 60%. La gente ha perso tutto: terreni, bestiame, case. Le città sono ora abitate da sfollati, mentre chi vive nei campi non riesce a uscirne.
Secondo l’ONU, su 1,2 milioni di abitanti, 800.000 sono in bisogno di aiuti umanitari. Il Vangelo oggi si traduce nel portare pace, dare speranza, offrire opportunità concrete: formazione, preghiera, cooperative. E oggi si aggiunge anche la crisi politica: nuovi scontri interni al governo, divisioni che vengono strumentalizzate, facendo leva sulle differenze etniche per mantenere il potere. È un crimine gravissimo».
Papa Francesco si era speso personalmente per la pace in Sud Sudan compiendo gesti inimmaginabili (come lo storico viaggio del 2023). Quanto vi manca la sua voce?
«Ci manca tantissimo la sua voce forte, di denuncia, ma anche di paternità e misericordia verso i deboli. Durante la sua visita – che ha toccato profondamente tutti, cattolici e non – lo abbiamo sentito padre della nostra nazione. E penso che la sua parola non morirà. Rimane viva, perché si fonda sul Vangelo. La visita ha rafforzato la Chiesa locale: vescovi, sacerdoti, catechisti oggi si sentono più chiamati a essere voci profetiche. Preghiamo perché la Chiesa continui a rispondere a questa vocazione. E speriamo che anche Papa Leone XIV, il nuovo pontefice, mantenga viva questa attenzione speciale della Santa Sede verso un Paese come il nostro, così provato e così bisognoso di pace».
Michele Luppi
Il Settimanale della Diocesi di Como