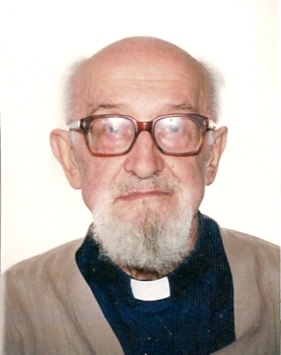Daniel Comboni
Missionários Combonianos
Área institucional
Outros links
Newsletter
In Pace Christi
Dutto Antonio
Data de nascimento :
14/02/1926
Local de nascimento :
Boves
Votos temporários :
09/09/1948
Votos perpétuos :
22/09/1950
Data de ordenação :
19/05/1951
Data da morte :
20/03/2003
Local da morte :
Verona
P. Antonio Dutto aveva 77 anni, dei quali 47 passati in Uganda. La sua è stata una vita donata al Signore pur con il suo carattere duro, serio e un po’ chiuso, proprio della sua terra piemontese. Ha lavorato tanti anni nel West Nile, tra i Lango, nella missione di Aduku, sulle rive del lago Kioga. Qui ha costruito una cristianità molto attiva e viva. I confratelli lo ricordano come un grande lavoratore, fedele al suo dovere di ogni giorno, uomo di responsabilità, quindi stimato anche dai superiori e dal vescovo.
Si è dato alla missione senza calcoli e senza misura perché per lui la missione era tutto e veniva sopra ogni altra cosa. Ciò lo ha portato ad essere esigente con se stesso e con gli altri. Per questo alle volte non è stato capito e qualcuno ha fatto fatica a volergli bene.
P. Antonio Dutto era nato a Boves, Cuneo, il 14 febbraio 1926 da una famiglia di solidi contadini che coniugavano lavoro e fede.
Da piccolo entrò nel seminario diocesano. In seminario, però, s’imbatté in un professore di latino, Don Attilio Graffino, che aveva le missioni nel cuore, tanto che, prima di morire, volle lasciare parte dei suoi beni ad esse. Questi fu lo straordinario animatore missionario che inviò alle missioni una schiera di ottimi missionari. Ricordiamo, per esempio, P. Attilio Aletto, P. Giovanni Audisio, P. Pietro Audisio, P. Lorenzo Bono, P. Agostino Cometto, P. Francesco Cordero, P. Giorgio Ferrero, P. Severino Peano… per nominare solo i morti. Anche P. Dutto fa parte di questa eletta schiera.
Scrivendo al superiore dei Comboniani da Boves il 22 giugno 1946, Antonio disse: “La mamma (Ramero Anna) non si oppone, no, alla mia vocazione missionaria, ma è addolorata e piange e ciò mi fa tanto soffrire. Ma sento, tra nostalgia e sacrificio, una gioia intima, quella che mi è data dalla certezza che la sofferenza ha tanto valore davanti a Dio. Parlo della mia sofferenza e anche di quella della mamma”.
Antonio non nomina il papà (Giuseppe) perché era morto di polmonite qualche anno prima. Lasciava un fratello più giovane di lui. In un’altra lettera dice, tra l’altro: “Spero di poter entrare tra i figli di Mons. Comboni che ho imparato ad amare attraverso i libri e le riviste”.
Ad un certo punto si è fatta avanti anche la tentazione: “Trovo molto duri questi ultimi giorni, molto più duri di quanto avrei creduto, e in certi momenti mi pare di essermi ingannato a credermi chiamato alle missioni. Esperimento, però, ad ogni scoraggiamento la mano della Mamma Celeste che mi viene sempre incontro con qualche soccorso imprevisto… Sono in relazione con P. Lorenzo Bono e con P. Attilio Aletto che è venuto a trovarmi. È stato il Cuore di Gesù a mandarli perché, dopo la loro visita, la mamma pare più rassegnata a lasciarmi partire. Inoltre è stato un bene anche per me, perché mi ha recato un po’ più di fervore e di amore alla mia vocazione”.
Il 3 settembre 1946 entrò nel noviziato di Venegono Superiore dove era padre maestro P. Antonio Todesco. “Ha avuto qualche difficoltà all’inizio – scrisse costui – ma poi si notò subito generosità e corrispondenza. È di buona pietà e attaccamento alla vocazione. Come carattere è un po’ duro e serio, non sempre socievole. Frequenta la prima teologia”. Durante il secondo anno passò a Gozzano, dove era stato aperto il noviziato, ed ebbe come padre maestro P. Giovanni Giordani, il quale lo trovò “equilibrato e di buona volontà, accurato nei suoi lavori e si adatta facilmente a tutti”.
Destinazione Uganda
Antonio Dutto fece la professione il 9 settembre del 1948 e poi passò a Venegono Superiore per lo scolasticato. Nella sua domanda dei voti affermò che voleva farsi missionario “per dedicarsi alla salvezza degli infedeli”. Emise i voti perpetui il 9 settembre 1950, con 12 mesi di dispensa dallo scadere del terzo anno dai temporanei.
Ordinato sacerdote nel 1951 a Milano dal Card. Ildefonso Schuster, fu destinato all’Uganda; così nel dicembre del 1952 andò a Londra per lo studio dell’inglese. Nel 1952 lo troviamo come insegnante nel seminario di Lacor (Gulu), ma dopo quattro anni passò alla pastorale nelle missioni di Anaka (1957-1958), Aduku (1958-1965), Opit (1965-1968), Padibe (1968-1975), Pajule (1975-1976), Namukora (1976-1978), Kalongo (1978-1982), Awach (1982-1984), Kitgum (1984-1986), Parombo (1987-1990), Kalongo (1990-1994). Fu un parroco zelante e grande lavoratore. Al ministero sacerdotale missionario univa anche il lavoro materiale quando si trovò senza Fratelli in missione. Fece buona pratica di meccanica, come registra P. Longino Urbani.
Egli ha sempre sofferto di asma, per di più Aduku è una missione costruita sulla riva di una palude, quindi molto umida, molto spesso caratterizzata da un’afa che rendeva difficoltoso il respiro anche ai sani.
“Sono stanco morto – ha scritto - non me la sento di assumere un ufficio di responsabilità. Almeno per un po’ ho bisogno di quiete altrimenti sarò costretto ad andare in Italia e sapete quanto mi costi lasciare la missione”.
P. Antonio ha sofferto molto, tanto che più di una volta dovette essere trasportato di urgenza a Gulu. Il dottore ad un certo punto ha detto al provinciale: “Se lasciate ancora P. Antonio ad Aduku finirà per lasciarci la vita”. Allora venne mandato in altre missioni.
Una forte Parola di Dio
Ad un certo punto nella vita di P. Antonio è intervenuto un fatto che è stato come una Parola di Dio che è caduta e gli ha cambiato la vita, chiedendogli qualche cosa di grosso, di esigente, un cambiamento radicale, troncando di botto la sua vita, mettendolo su un letto di ospedale. Riportiamo il fatto come lo ha raccontato lui stesso al giornale diocesano di Cuneo, La Guida, in data 1 luglio 1994.
“Questa volta sono rientrato in Italia in modo tragico su un piccolo aereo a reazione che mi ha portato direttamente da Nairobi a Verona presso la Clinica Universitaria. Ma non hanno potuto fare altro che amputarmi la gamba destra. È stato un colpo duro. Tutto era cominciato la mattina del 6 maggio. Ero partito dalla mia missione di Kalongo e dovevo raggiungere Kampala per prendere l’aereo per Roma. Venivo in Italia per un periodo di riposo. Viaggiavano con me un autista africano e due dottori di Bologna, marito e moglie. Io sedevo davanti di lato all’autista e i due dottori si erano messi a riposare dietro. La strada attraversava la savana. A circa 130 chilometri dal luogo di partenza alcuni colpi di grosse armi da fuoco colpirono la cabina con un fracasso indiavolato. Sentii delle pallottole colpirmi, vidi sangue, poi credo di essere svenuto.
Mi risvegliai per terra, sul ciglio della strada. Poco lontano c’era l’autista con una gamba spezzata. I due dottori non erano stati colpiti e cercarono di aiutarmi, ma furono presi violentemente con tutti i bagagli e portati nel bosco. Alcuni rovesciarono la nostra auto, un’ambulanza Toyota. La incendiarono, poi scomparvero anche loro nel bosco. Seppi poi che i dottori furono rilasciati dopo averli alleggeriti di tutto quel che avevano: orologi, soldi, valigie, loro e mie.
Io ero stato colpito da tre pallottole: una di striscio alla mascella destra, una alla spalla destra ed una alla gamba destra. Era la più grave perché aveva tagliato l’arteria. Pregai il Signore di aiutarmi. Pensavo che mi sarei dissanguato e così pure l’autista che gemeva e gridava. Arrivarono dei soldati governativi che erano di pattuglia ad un centro poco lontano. Cercarono di sollevarci, mandarono dei messaggi ma, a quella distanza, che cosa si poteva sperare?
Il Signore è stato buono: dopo mezz’ora è passato un’auto. Era un confratello missionario che andava a celebrare in una cappella. Decidemmo che ci portasse a Kitgum (80 Km) dove la missione ha un piccolo ospedale con un medico italiano e uno tedesco. Mi curarono le ferite e mi fecero trasfusioni di sangue. Mi cucirono la mandibola con un cordino tolto dai freni di una bicicletta (dopo averlo sterilizzato) perché non c’era filo appropriato in ospedale. Alle ferite da arma da fuoco si aggiungevano anche l’asma e il diabete.
Non ci vedevo più e capivo a stento. Il giorno seguente hanno deciso di mandarmi a Nairobi con un piccolo aereo Cesna. Là mi ricoverarono. C’era un medico africano e uno italiano i quali pensarono di mandarmi d’urgenza in Italia.
Nell’ospedale di Borgo Roma, a Verona, mi hanno detto che dovevano amputarmi la gamba. In un primo tempo, rifiutai. Infatti ero già in sala operatoria quando ho voluto essere riportato in reparto. Nel taglio della gamba vedevo compromessa tutta la mia attività missionaria, la cosa più preziosa che mi restava. A questo punto mi hanno detto: ‘O l’amputazione o la morte’. ‘Vada per l’amputazione’ ho risposto. Oltre all’amputazione mi dovettero fare dei trapianti di pelle per le altre ferite.
Ora continuo le cure nella Casa Madre dei Comboniani a Verona, trascinandomi su una sedia a rotelle. Per un certo tempo cercai di adattarmi alla protesi, sempre nella speranza di tornare in missione, ma quell’arto artificiale mi causava fatica, quindi difficoltà di respirazione (causa l’asma) e abrasioni (dovute al diabete) per cui ho dovuto rassegnarmi a passare la vita su quella sedia a rotelle.
Cosa vorrà il Signore da me? Una suora africana mi ha scritto: ‘Prego per te tutti i giorni perché guarisca e torni tra noi, anche se zoppicante. Noi ti vogliamo qui’.
Chi erano gli assalitori? Certamente un gruppo di ex soldati ugandesi ribelli al governo. Ci sono tra loro uomini di altri paesi che vogliono la guerra, forniscono armi e seminano odio. Il popolo Acioli tra il quale ho lavorato dal 1952 è fatto di gente pacifica. A Kalongo dove ho passato gli ultimi tre anni, ma c’ero già stato prima, sono tutti cattolici. In questo periodo soffrono la fame perché non è piovuto. Continuano a venire in missione, specialmente donne, bambini affamati, e poveri vecchi.
A Kalongo c’è l’ospedale iniziato negli anni Quaranta dal dottore P. Giuseppe Ambrosoli di Como, morto in concetto di santità nel 1987. Tutti gli dimostrano grande venerazione e lo pregano come un santo. Anch’io lo prego perché interceda per me e mi aiuti a riprendere il lavoro missionario. Confido per questo anche nella Madonna, Regina della pace.
Ho ricevuto tante lettere da persone conosciute e sconosciute. Ringrazio tutti della simpatia e della preghiera. Assicuro tutti del mio ricordo e saluto tutti cordialmente”.
Il calice amaro
Pensando a quanto è accaduto a P. Antonio, vengono in mente gli Apostoli quando Gesù ha annunciato loro la croce. Anche loro hanno fatto fatica ad accettarla, perché non capivano e avevano paura di chiedere spiegazione. Anche P. Antonio a questa chiamata forte di Dio ha fatto fatica a dire il suo sì. Tuttavia nella fedeltà alla preghiera, all’adorazione, ha trovato la forza di chinare il capo e accettare quel calice amaro che il Signore gli porgeva. È un fatto che non riusciva a rassegnarsi di essere in Italia, e per di più nell’immobilità. Appena rimessosi un po’ con la sua gamba di legno, scriveva: “Il mio pensiero è sempre lì in Uganda. Rivedo i posti e le persone e ricordo tutti nella preghiera”. Nel 1995 proseguiva: “Spero che Mons. Comboni mi faccia un regalo per la sua beatificazione e mi faccia tornare in missione”. Intanto leggeva con piacere le notizie che arrivavano dall’Uganda: “Grazie della stampa che mi mandate; mi porta sempre un po’ di aria ugandese e mi fa bene. Faccio qualche chiacchierata con i confratelli di passaggio e sono sempre in attesa di notizie buone. Quando arrivano è una festa, peccato che siano quasi sempre brutte”. Nel 1996 aggiunse: “La speranza di tornare in Uganda mi dà coraggio e buona volontà per sforzarmi di più”. Un assistente generale, però, gli disse che ormai mettesse da parte il pensiero di tornare, sia per la situazione in Uganda, sia per la sua menomazione. “La tua lettera mi ha fatto male – gli rispose – perché tende a spegnere in me la speranza. Tuttavia io confido sempre nel Signore; sarà quello che lui vorrà”.
Nel 1997, scrivendo al provinciale d’Uganda, diceva che incominciava a camminare abbastanza bene e che quindi sperava di tornare nella sua missione: “Io cammino abbastanza bene anche se da povero vecchio. Incomincio a pensare al ritorno”. L’anno seguente insisteva: “Spero ancora di tornare in Uganda. Tu cosa ne pensi? Anche se stai per deporre le redini”. Al suo successore che andò a trovarlo a Verona nel 2000, disse: “Voglio che tu mi conosca, così che tu possa accettarmi in Uganda”. Ma proprio nel 2000 fu assegnato definitivamente alla provincia italiana, segno che ormai l’idea della missione doveva restare un sogno che lui avrebbe nutrito con la preghiera e il sacrificio.
La vocazione alla sofferenza
A questo punto P. Antonio ha chinato il capo e ha capito che la vocazione missionaria non è solo chiamata al lavoro, ma anche chiamata alla sofferenza, invito a donare la vita, nella totale disponibilità al Signore, come la Madonna quando ha detto il suo sì. Ha anche capito che l’offerta silenziosa di una vita apparentemente inutile, davanti a Dio può valere di più di tanto agitarsi, di tanto correre sentendosi utili o, peggio ancora, indispensabili. Ed ha esperimentato nella sua carne che cosa voglia dire entrare nel mistero di Cristo attraverso la sofferenza e la morte.
Fino all’ultimo, tuttavia, mostrava una particolare attenzione ai problemi della missione che accompagnava con la sua incessante preghiera. La sua passione per la missione era un fuoco che lo purificava, lo sosteneva e gli dava una ragione di vivere sulla sua sedia a rotelle che per lui costituì il suo purgatorio. Fino all’ultimo volle essere presente alla vita della comunità, alla vita di preghiera e anche ai momenti di ricreazione.
Ultimamente era intervenuto anche lo scompenso cardiaco. Dimagriva, era sempre più debole. Negli ultimi giorni aveva bisogno dell’ossigeno, finché il 20 marzo consegnò la sua anima a Dio. Dopo il funerale in Casa Madre la salma è stata portata al suo paese dove riposa accanto ai suoi cari. (P. Lorenzo Gaiga, mccj)
Si è dato alla missione senza calcoli e senza misura perché per lui la missione era tutto e veniva sopra ogni altra cosa. Ciò lo ha portato ad essere esigente con se stesso e con gli altri. Per questo alle volte non è stato capito e qualcuno ha fatto fatica a volergli bene.
P. Antonio Dutto era nato a Boves, Cuneo, il 14 febbraio 1926 da una famiglia di solidi contadini che coniugavano lavoro e fede.
Da piccolo entrò nel seminario diocesano. In seminario, però, s’imbatté in un professore di latino, Don Attilio Graffino, che aveva le missioni nel cuore, tanto che, prima di morire, volle lasciare parte dei suoi beni ad esse. Questi fu lo straordinario animatore missionario che inviò alle missioni una schiera di ottimi missionari. Ricordiamo, per esempio, P. Attilio Aletto, P. Giovanni Audisio, P. Pietro Audisio, P. Lorenzo Bono, P. Agostino Cometto, P. Francesco Cordero, P. Giorgio Ferrero, P. Severino Peano… per nominare solo i morti. Anche P. Dutto fa parte di questa eletta schiera.
Scrivendo al superiore dei Comboniani da Boves il 22 giugno 1946, Antonio disse: “La mamma (Ramero Anna) non si oppone, no, alla mia vocazione missionaria, ma è addolorata e piange e ciò mi fa tanto soffrire. Ma sento, tra nostalgia e sacrificio, una gioia intima, quella che mi è data dalla certezza che la sofferenza ha tanto valore davanti a Dio. Parlo della mia sofferenza e anche di quella della mamma”.
Antonio non nomina il papà (Giuseppe) perché era morto di polmonite qualche anno prima. Lasciava un fratello più giovane di lui. In un’altra lettera dice, tra l’altro: “Spero di poter entrare tra i figli di Mons. Comboni che ho imparato ad amare attraverso i libri e le riviste”.
Ad un certo punto si è fatta avanti anche la tentazione: “Trovo molto duri questi ultimi giorni, molto più duri di quanto avrei creduto, e in certi momenti mi pare di essermi ingannato a credermi chiamato alle missioni. Esperimento, però, ad ogni scoraggiamento la mano della Mamma Celeste che mi viene sempre incontro con qualche soccorso imprevisto… Sono in relazione con P. Lorenzo Bono e con P. Attilio Aletto che è venuto a trovarmi. È stato il Cuore di Gesù a mandarli perché, dopo la loro visita, la mamma pare più rassegnata a lasciarmi partire. Inoltre è stato un bene anche per me, perché mi ha recato un po’ più di fervore e di amore alla mia vocazione”.
Il 3 settembre 1946 entrò nel noviziato di Venegono Superiore dove era padre maestro P. Antonio Todesco. “Ha avuto qualche difficoltà all’inizio – scrisse costui – ma poi si notò subito generosità e corrispondenza. È di buona pietà e attaccamento alla vocazione. Come carattere è un po’ duro e serio, non sempre socievole. Frequenta la prima teologia”. Durante il secondo anno passò a Gozzano, dove era stato aperto il noviziato, ed ebbe come padre maestro P. Giovanni Giordani, il quale lo trovò “equilibrato e di buona volontà, accurato nei suoi lavori e si adatta facilmente a tutti”.
Destinazione Uganda
Antonio Dutto fece la professione il 9 settembre del 1948 e poi passò a Venegono Superiore per lo scolasticato. Nella sua domanda dei voti affermò che voleva farsi missionario “per dedicarsi alla salvezza degli infedeli”. Emise i voti perpetui il 9 settembre 1950, con 12 mesi di dispensa dallo scadere del terzo anno dai temporanei.
Ordinato sacerdote nel 1951 a Milano dal Card. Ildefonso Schuster, fu destinato all’Uganda; così nel dicembre del 1952 andò a Londra per lo studio dell’inglese. Nel 1952 lo troviamo come insegnante nel seminario di Lacor (Gulu), ma dopo quattro anni passò alla pastorale nelle missioni di Anaka (1957-1958), Aduku (1958-1965), Opit (1965-1968), Padibe (1968-1975), Pajule (1975-1976), Namukora (1976-1978), Kalongo (1978-1982), Awach (1982-1984), Kitgum (1984-1986), Parombo (1987-1990), Kalongo (1990-1994). Fu un parroco zelante e grande lavoratore. Al ministero sacerdotale missionario univa anche il lavoro materiale quando si trovò senza Fratelli in missione. Fece buona pratica di meccanica, come registra P. Longino Urbani.
Egli ha sempre sofferto di asma, per di più Aduku è una missione costruita sulla riva di una palude, quindi molto umida, molto spesso caratterizzata da un’afa che rendeva difficoltoso il respiro anche ai sani.
“Sono stanco morto – ha scritto - non me la sento di assumere un ufficio di responsabilità. Almeno per un po’ ho bisogno di quiete altrimenti sarò costretto ad andare in Italia e sapete quanto mi costi lasciare la missione”.
P. Antonio ha sofferto molto, tanto che più di una volta dovette essere trasportato di urgenza a Gulu. Il dottore ad un certo punto ha detto al provinciale: “Se lasciate ancora P. Antonio ad Aduku finirà per lasciarci la vita”. Allora venne mandato in altre missioni.
Una forte Parola di Dio
Ad un certo punto nella vita di P. Antonio è intervenuto un fatto che è stato come una Parola di Dio che è caduta e gli ha cambiato la vita, chiedendogli qualche cosa di grosso, di esigente, un cambiamento radicale, troncando di botto la sua vita, mettendolo su un letto di ospedale. Riportiamo il fatto come lo ha raccontato lui stesso al giornale diocesano di Cuneo, La Guida, in data 1 luglio 1994.
“Questa volta sono rientrato in Italia in modo tragico su un piccolo aereo a reazione che mi ha portato direttamente da Nairobi a Verona presso la Clinica Universitaria. Ma non hanno potuto fare altro che amputarmi la gamba destra. È stato un colpo duro. Tutto era cominciato la mattina del 6 maggio. Ero partito dalla mia missione di Kalongo e dovevo raggiungere Kampala per prendere l’aereo per Roma. Venivo in Italia per un periodo di riposo. Viaggiavano con me un autista africano e due dottori di Bologna, marito e moglie. Io sedevo davanti di lato all’autista e i due dottori si erano messi a riposare dietro. La strada attraversava la savana. A circa 130 chilometri dal luogo di partenza alcuni colpi di grosse armi da fuoco colpirono la cabina con un fracasso indiavolato. Sentii delle pallottole colpirmi, vidi sangue, poi credo di essere svenuto.
Mi risvegliai per terra, sul ciglio della strada. Poco lontano c’era l’autista con una gamba spezzata. I due dottori non erano stati colpiti e cercarono di aiutarmi, ma furono presi violentemente con tutti i bagagli e portati nel bosco. Alcuni rovesciarono la nostra auto, un’ambulanza Toyota. La incendiarono, poi scomparvero anche loro nel bosco. Seppi poi che i dottori furono rilasciati dopo averli alleggeriti di tutto quel che avevano: orologi, soldi, valigie, loro e mie.
Io ero stato colpito da tre pallottole: una di striscio alla mascella destra, una alla spalla destra ed una alla gamba destra. Era la più grave perché aveva tagliato l’arteria. Pregai il Signore di aiutarmi. Pensavo che mi sarei dissanguato e così pure l’autista che gemeva e gridava. Arrivarono dei soldati governativi che erano di pattuglia ad un centro poco lontano. Cercarono di sollevarci, mandarono dei messaggi ma, a quella distanza, che cosa si poteva sperare?
Il Signore è stato buono: dopo mezz’ora è passato un’auto. Era un confratello missionario che andava a celebrare in una cappella. Decidemmo che ci portasse a Kitgum (80 Km) dove la missione ha un piccolo ospedale con un medico italiano e uno tedesco. Mi curarono le ferite e mi fecero trasfusioni di sangue. Mi cucirono la mandibola con un cordino tolto dai freni di una bicicletta (dopo averlo sterilizzato) perché non c’era filo appropriato in ospedale. Alle ferite da arma da fuoco si aggiungevano anche l’asma e il diabete.
Non ci vedevo più e capivo a stento. Il giorno seguente hanno deciso di mandarmi a Nairobi con un piccolo aereo Cesna. Là mi ricoverarono. C’era un medico africano e uno italiano i quali pensarono di mandarmi d’urgenza in Italia.
Nell’ospedale di Borgo Roma, a Verona, mi hanno detto che dovevano amputarmi la gamba. In un primo tempo, rifiutai. Infatti ero già in sala operatoria quando ho voluto essere riportato in reparto. Nel taglio della gamba vedevo compromessa tutta la mia attività missionaria, la cosa più preziosa che mi restava. A questo punto mi hanno detto: ‘O l’amputazione o la morte’. ‘Vada per l’amputazione’ ho risposto. Oltre all’amputazione mi dovettero fare dei trapianti di pelle per le altre ferite.
Ora continuo le cure nella Casa Madre dei Comboniani a Verona, trascinandomi su una sedia a rotelle. Per un certo tempo cercai di adattarmi alla protesi, sempre nella speranza di tornare in missione, ma quell’arto artificiale mi causava fatica, quindi difficoltà di respirazione (causa l’asma) e abrasioni (dovute al diabete) per cui ho dovuto rassegnarmi a passare la vita su quella sedia a rotelle.
Cosa vorrà il Signore da me? Una suora africana mi ha scritto: ‘Prego per te tutti i giorni perché guarisca e torni tra noi, anche se zoppicante. Noi ti vogliamo qui’.
Chi erano gli assalitori? Certamente un gruppo di ex soldati ugandesi ribelli al governo. Ci sono tra loro uomini di altri paesi che vogliono la guerra, forniscono armi e seminano odio. Il popolo Acioli tra il quale ho lavorato dal 1952 è fatto di gente pacifica. A Kalongo dove ho passato gli ultimi tre anni, ma c’ero già stato prima, sono tutti cattolici. In questo periodo soffrono la fame perché non è piovuto. Continuano a venire in missione, specialmente donne, bambini affamati, e poveri vecchi.
A Kalongo c’è l’ospedale iniziato negli anni Quaranta dal dottore P. Giuseppe Ambrosoli di Como, morto in concetto di santità nel 1987. Tutti gli dimostrano grande venerazione e lo pregano come un santo. Anch’io lo prego perché interceda per me e mi aiuti a riprendere il lavoro missionario. Confido per questo anche nella Madonna, Regina della pace.
Ho ricevuto tante lettere da persone conosciute e sconosciute. Ringrazio tutti della simpatia e della preghiera. Assicuro tutti del mio ricordo e saluto tutti cordialmente”.
Il calice amaro
Pensando a quanto è accaduto a P. Antonio, vengono in mente gli Apostoli quando Gesù ha annunciato loro la croce. Anche loro hanno fatto fatica ad accettarla, perché non capivano e avevano paura di chiedere spiegazione. Anche P. Antonio a questa chiamata forte di Dio ha fatto fatica a dire il suo sì. Tuttavia nella fedeltà alla preghiera, all’adorazione, ha trovato la forza di chinare il capo e accettare quel calice amaro che il Signore gli porgeva. È un fatto che non riusciva a rassegnarsi di essere in Italia, e per di più nell’immobilità. Appena rimessosi un po’ con la sua gamba di legno, scriveva: “Il mio pensiero è sempre lì in Uganda. Rivedo i posti e le persone e ricordo tutti nella preghiera”. Nel 1995 proseguiva: “Spero che Mons. Comboni mi faccia un regalo per la sua beatificazione e mi faccia tornare in missione”. Intanto leggeva con piacere le notizie che arrivavano dall’Uganda: “Grazie della stampa che mi mandate; mi porta sempre un po’ di aria ugandese e mi fa bene. Faccio qualche chiacchierata con i confratelli di passaggio e sono sempre in attesa di notizie buone. Quando arrivano è una festa, peccato che siano quasi sempre brutte”. Nel 1996 aggiunse: “La speranza di tornare in Uganda mi dà coraggio e buona volontà per sforzarmi di più”. Un assistente generale, però, gli disse che ormai mettesse da parte il pensiero di tornare, sia per la situazione in Uganda, sia per la sua menomazione. “La tua lettera mi ha fatto male – gli rispose – perché tende a spegnere in me la speranza. Tuttavia io confido sempre nel Signore; sarà quello che lui vorrà”.
Nel 1997, scrivendo al provinciale d’Uganda, diceva che incominciava a camminare abbastanza bene e che quindi sperava di tornare nella sua missione: “Io cammino abbastanza bene anche se da povero vecchio. Incomincio a pensare al ritorno”. L’anno seguente insisteva: “Spero ancora di tornare in Uganda. Tu cosa ne pensi? Anche se stai per deporre le redini”. Al suo successore che andò a trovarlo a Verona nel 2000, disse: “Voglio che tu mi conosca, così che tu possa accettarmi in Uganda”. Ma proprio nel 2000 fu assegnato definitivamente alla provincia italiana, segno che ormai l’idea della missione doveva restare un sogno che lui avrebbe nutrito con la preghiera e il sacrificio.
La vocazione alla sofferenza
A questo punto P. Antonio ha chinato il capo e ha capito che la vocazione missionaria non è solo chiamata al lavoro, ma anche chiamata alla sofferenza, invito a donare la vita, nella totale disponibilità al Signore, come la Madonna quando ha detto il suo sì. Ha anche capito che l’offerta silenziosa di una vita apparentemente inutile, davanti a Dio può valere di più di tanto agitarsi, di tanto correre sentendosi utili o, peggio ancora, indispensabili. Ed ha esperimentato nella sua carne che cosa voglia dire entrare nel mistero di Cristo attraverso la sofferenza e la morte.
Fino all’ultimo, tuttavia, mostrava una particolare attenzione ai problemi della missione che accompagnava con la sua incessante preghiera. La sua passione per la missione era un fuoco che lo purificava, lo sosteneva e gli dava una ragione di vivere sulla sua sedia a rotelle che per lui costituì il suo purgatorio. Fino all’ultimo volle essere presente alla vita della comunità, alla vita di preghiera e anche ai momenti di ricreazione.
Ultimamente era intervenuto anche lo scompenso cardiaco. Dimagriva, era sempre più debole. Negli ultimi giorni aveva bisogno dell’ossigeno, finché il 20 marzo consegnò la sua anima a Dio. Dopo il funerale in Casa Madre la salma è stata portata al suo paese dove riposa accanto ai suoi cari. (P. Lorenzo Gaiga, mccj)