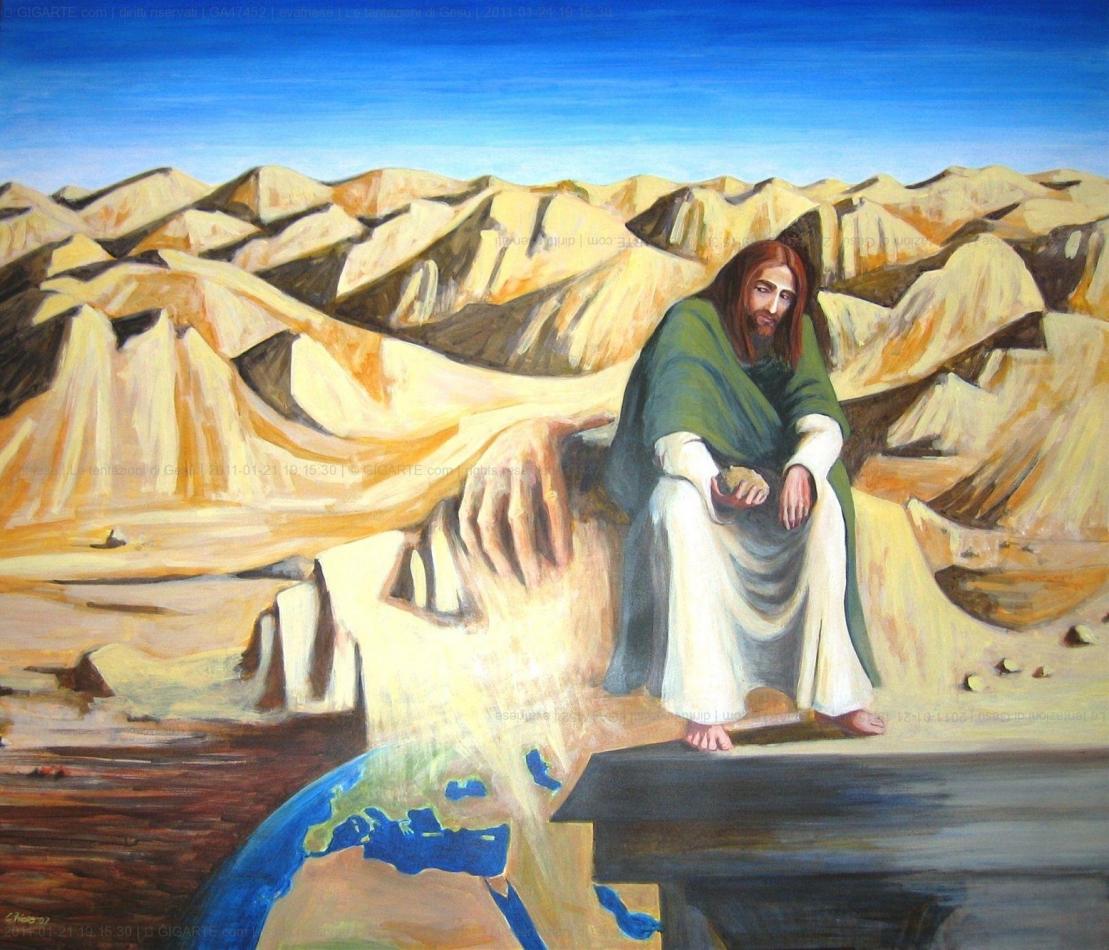Daniel Comboni
Misjonarze Kombonianie
Obszar instytucjonalny
Inne linki
Newsletter
In questa 30a domenica Gesù continua il suo insegnamento sulla preghiera. Domenica scorsa, con la parabola del giudice corrotto e della povera vedova, ci aveva detto QUANDO pregare: sempre, senza stancarsi mai. Oggi, invece, COME pregare. E lo fa con un’altra parabola, da noi ben conosciuta, del fariseo e del pubblicano. [...]
“Chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato.”
Luca 18,9-14
In questa 30a domenica Gesù continua il suo insegnamento sulla preghiera. Domenica scorsa, con la parabola del giudice corrotto e della povera vedova, ci aveva detto QUANDO pregare: sempre, senza stancarsi mai. Oggi, invece, COME pregare. E lo fa con un’altra parabola, da noi ben conosciuta, del fariseo e del pubblicano. Curiosamente, la figura del giudice appare di nuovo nel sottofondo delle letture di questa domenica. Sarà forse perché non riusciamo a separarci dalla nostra immagine di un Dio Giudice, per il bene, giustificandoci, o per il male, condannandoci?
Il fariseo e il pubblicano
L’evangelista introduce il brano del Vangelo, esplicitando l’intenzione di Gesù: questa parabola era “per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri”.
“Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano…”
Gesù, introducendoli nella parabola, ha già ben delineato questi due personaggi. Il fariseo apparteneva ad un gruppo religioso laicale (attivo dal II sec. a.C. fino al I sec. d.C.). Etimologicamente, “fariseo” significa “separato”. Volendo osservare integralmente la Legge di Mosè, i farisei si separavano dagli altri per non contaminarsi. Erano i “puri”, molto stimati dalla gente per la loro pietà e conoscenza della Legge.
Il pubblicano, invece, era un esattore delle imposte (dal latino publicanus, a sua volta derivato da publicum, che significa “erario dello stato”). I pubblicani erano considerati peccatori e impuri. Erano odiati e disprezzati dal popolo, perché in connivenza con gli invasori romani e sfruttatori della povera gente.
Entrambi i personaggi “salgono” in preghiera al Tempio ed espongono davanti a Dio quello che sono. Perché a Dio non si può mentire. Il fariseo fa una preghiera di ringraziamento. Allo specchio della Legge si vede giusto, ineccepibile e si auto-compiace. Lui non è come gli altri. Si guarda attorno e vede solo ladri, ingiusti e adùlteri. Si gonfia il petto e fa il resoconto delle sue buone opere davanti a Dio, il suo contabile. Si sente a posto con i conti, anzi ha accumulato crediti per il paradiso. Oggi diremmo che è il cristiano perfetto e irreprensibile, con il cielo garantito.
Il pubblicano, invece, resta in fondo. Non si azzarda ad avvicinarsi al Santo. Il fardello dei suoi peccati curva la sua fronte. Sa di essere un peccatore impietrito. Riesce solo a dire: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”, battendosi il petto.
Gesù conclude la parabola affermando con autorità: “Io vi dico: questi [il pubblicano che aveva implorato pietà], a differenza dell’altro [il fariseo che si riteneva perfetto], tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato.” .
Quale dei due mi rappresenta?
Lo confesso: vorrei essere come il fariseo
Oggi tutti guarderebbero di cattivo occhio il fariseo e si batterebbero il petto come il pubblicano. Mi dispiace per il povero fariseo. Lo confesso: io invidio questo fariseo! Vorrei essere come lui: un fedele osservante di tutta la legge! Perfetto, irreprensibile! Tutta la vita ho cercato di imitarlo, senza riuscirci però! In fondo, vorrei poter anch’io compiacermi, come lui, della mia vita.
Mi sembra che Gesù sia stato piuttosto severo con il fariseo, mettendolo in cattiva luce. E, dopo tutto, la sua preghiera era iniziata bene, con il ringraziamento. Sì, poi si è distratto, guardandosi indietro (capita a tutti, o no?), e alla vista del pubblicano non è riuscito a controllare il suo astio per questi collaborazionisti ed è scivolato nel giudizio! Peccato!
La tentazione di scimmiottare il pubblicano
Perché non sono riuscito ad essere come il fariseo, non mi resta che battermi il petto e ripetere la preghiera del pubblicano: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Ma mi chiedo quanto io abbia interiorizzato l’atteggiamento del peccatore convinto e pentito. In fondo, lui era pubblicamente un peccatore e per lui non c’era scampo. Io invece sono un prete, che, suppositivamente, dovrebbe essere di esempio. Non è così semplice fare con altrettanta convinzione la preghiera di questo pubblicano e appellarsi alla sola misericordia di Dio. Al momento stesso di confessarmi peccatore, noto la tendenza a mettermi uno scalino più in alto rispetto ai miei fratelli peccatori. Peccatore sì, ma non esageriamo!…
Due gemelli nel grembo del cuore
Dopotutto mi chiedo chi sono io veramente: il fariseo che vorrei essere o il pubblicano che non vorrei essere? Ahimè, credo di portarli entrambi nel mio cuore, come due gemelli! Come fanno a coabitare?! Alla fine dovranno pure imparare a convivere.
Al mio fariseo dico continuamente di non cercare l’autocompiacimento, ma di compiacere invece il Padre. Al mio pubblicano non smetto di ripetere che Dio lo ama così com’è. Non deve meritarsi l’amore del Padre. È gratuito! Anzi, la mia povertà e debolezza mi valgono le attenzioni preferenziali di Gesù, che è venuto per i pubblicani e i peccatori.
Riuscirò a educarli entrambi? Non lo so, ma intanto ci provo. Una cosa io so: che solo quando i due diventeranno uno potrò entrare nel Regno dei cieli!
Per la riflessione personale
Meditare su alcuni versetti della prima e della seconda lettura.
Nella prima, il Siràcide (35,15-22) ci invita a pregare come il povero, perché:“La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata; non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità.”
Nella seconda, Paolo, stanco, vecchio e in prigione, si congeda del suo giovane discepolo Timoteo con tono commovente, affidandosi alla giustizia di Dio:
“Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno.” (2Tm 4,6-8.16-18).
Che possiamo dirlo anche noi, alla fine della nostra vita!
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
Gesù è come uno specchio. Ci mostra una realtà invertita. Con le parole di Shakespeare nei primi versi del Macbeth: il bello è brutto e il brutto è bello. Nel Vangelo di Luca, egli parla di «alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri». È un episodio in apparenza semplice. Solo poche righe, scarsi commenti, quasi nessuna trama. Ma nelle ellissi di questa storia, attraverso lo specchio, qualcosa luccica, silenziosamente.
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano». Quindi l’unica ambientazione, come un disegno di Piranesi, è il tempio: Visione di antichità in inchiostro e gesso. Nella parabola, immagino due uomini non troppo distanti tra loro. «Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano”». Mi piace il pronome dimostrativo “questo”; implica sdegno, addirittura disprezzo. Mi piace anche il fatto che Gesù all’improvviso ci situi in un monologo interiore, una narrazione in terza persona ravvicinata. Ricordiamo che anche Paolo di Tarso era un fariseo, principe tra gli ipocriti. «Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io», dice Paolo in Timoteo. Tuttavia ha finito col diventare l’Apostolo dei Gentili, viaggiando in lungo e in largo per diffondere la Buona Novella.
Ritornando alla parabola narrata in Luca, ecco che cosa il fariseo sussurra a se stesso più di 2000 anni fa: «Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». È presuntuoso e si crede privilegiato. Pensa che poiché osserva gli editti e paga il tributo al tempio, ha tutti i diritti di stare nella casa di Dio. Il pubblicano, invece, «fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”». Quindi il pubblicano prova disprezzo per se stesso. Non alza nemmeno lo sguardo verso Dio, verso il cielo e la luce. Si batte il petto, come fanno i musulmani sciiti quando recitano il lutto nella festa di Ashura: “O, la pace sia su di voi”, cantano. Qui il pubblicano non chiede altro che misericordia per i suoi peccati. Possiamo facilmente immaginare quali sono: avarizia, avidità, anche lussuria. Possiamo immaginare il pubblicano che taglia un pollo arrosto, con timo e sale, un banchetto che veniva preparato già ai tempi di Gesù. Possiamo immaginarlo mentre usa le sue monete per spassarsela con le prostitute. Possiamo vederlo giocare d’azzardo come Matteo, a poche centinaia di iarde di distanza, sotto un sole cocente.
Ma nel momento di svolta della storia, Gesù conclude: «Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». È questa l’essenza, la morale allo specchio. La superbia, la presunzione, verrà sradicata nella resa dei conti spirituale. Le regole non bastano. E questo, a sua volta, è il messaggio rivoluzionario: le regole sono poco rilevanti. Conta solo il cuore. Chi è umile di cuore, e quindi nella preghiera, verrà elevato alla luce più alta. Riposerà nel petto del Signore.
La parabola che Gesù racconta può trovare nella saggezza popolare, che afferma “gli occhi sono lo specchio dell’anima”, una sua sintesi. Il racconto del Signore è, infatti, una questione di sguardi: un fariseo che apparentemente guarda verso il cielo, mentre in realtà è profondamente concentrato su di sé e sulle sue opere, e un pubblicano “che non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo”, il quale, invece, tiene fisso lo sguardo su Dio, riconoscendosi peccatore e confidando solo nella misericordia, che è il nome proprio di Dio.
Quando lo sguardo del cuore è indirizzato verso Dio l’uomo diventa capace di scoprire la sua povertà: chi, infatti, può uguagliare la bontà e la gratuità del Padre? Per quante opere buone possiamo compiere, la salvezza e l’amicizia con Dio sono sempre un dono gratuito, come ricorda Paolo ai cristiani di Roma: «Noi riteniamo infatti che l’uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della Legge» (Rm 3, 28). La scoperta della propria fragilità conduce, così, a guardare gli altri con misericordia e a non coltivare nel cuore un sentimento di superiorità, che spesso sfocia nel disprezzo, nell’indifferenza o «nell’intima presunzione di essere giusti» (Lc 18, 9).
Gli occhi che guardano verso Dio sono specchio di un’anima umile, che non accampa meriti o diritti davanti a Dio, ma che, invece, riconosce nell’esperienza del perdono la sua dignità, essendo consapevole della sua fragilità e pochezza. L’etimologia stessa di umile, infatti, rimanda alla terra, ricordando all’uomo che egli è stato formato con polvere dal suolo ed è diventato essere vivente grazie all’alito di vita soffiato nelle sue narici da Dio (cfr Gn 2, 7).
L’umiltà è virtù essenziale per il discepolo perché permette di scoprire il vero volto di Dio, quello del Padre che è la fonte della vita, ma allo stesso tempo permette anche di costruire relazioni nuove con gli altri uomini, riconoscendo che anch’essi devono la loro esistenza all’unico Padre che «fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 5, 45). La sorgente della fraternità è, dunque, l’umiltà, smarrendo la quale gli uomini diventano estranei gli uni agli altri.
La Chiesa, invece, ha per vocazione propria quella di includere tutti facendo di tutti gli uomini un solo popolo che, come ricorda il Concilio nella Lumen gentium, ha «per condizione la libertà e la dignità dei figli di Dio... per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amato... per fine il regno di Dio». Una sfida affascinante per la Chiesa e ogni comunità cristiana, che il Signore affida nuovamente ai suoi discepoli in questa domenica, promettendo loro di essere vicino e dare forza, come fece con l’Apostolo Paolo perché potesse portare a compimento l’annuncio del Vangelo (cfr 2Tm 4, 17).
[Nicola Filippi – L’Osservatore Romano]
Gesù insegnaci a pregare con umiltà
Sir 35,12-14.16-18; Salmo 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Vangelo Lc 18,9-14
Dopo averci raccomandato una preghiera insistente e fiduciosa domenica scorsa, Gesù, attraverso la parabola del fariseo e del pubblicano, precisa questa domenica qual è l’atteggiamento giusto e gradito da Dio dell’orante. Più che una parabola, questa è una lezione vitale, una storia esemplare. Quest’istruzione di Gesù sulla preghiera è anticipata nelle riflessioni del Siracide. Egli ricorda un principio tradizionale biblico (“Il Signore è giudice e non v’è presso di lui preferenza di persone”), e vi introduce il tema dell’efficacia della preghiera (“Non è parziale con nessuno contro il povero, anzi ascolta proprio la preghiera dell’oppresso… Chi venera Dio con benevolenza, la sua preghiera giungerà fino alle nubi”).
Il maestro di sapienza suggerisce poi quale deve essere l’atteggiamento di chi si rivolge a Dio. Chi prega si mette nella condizione del povero o dell’umile, che pone tutta la sua fiducia in Dio. Un eco di questa spiritualità biblica appare nel salmo responsoriale, introdotto dal ritornello: “Giunge al tuo volto, Signore, il grido del povero”.
Nel vangelo vengono messi in scena al Tempio due personaggi contrapposti, nel loro modo di pregare o di rapportarsi con Dio: Il fariseo, ossia un osservante scrupoloso della Legge, un praticante fedele della religione, una persona pia per eccellenza; prega nella posizione corretta, secondo la tradizione giudaica (in piedi, la testa alta e le braccia sollevate verso il cielo). Egli inizia con la preghiera più bella: l’azione di grazia. Solo che non ringrazia Yahweh per la sua misericordia e grandezza, ma per ciò che è lui, a differenza degli altri: ”O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri ingiusti, adulteri”. Egli passa in rassegna i tre comandi centrali del decalogo che ha osservati fedelmente. Per fare risaltare meglio le sue benemerenze, egli sente il bisogno di denunciare tutti gli altri (ladri, ingiusti, adulteri) e il confronto col pubblicano gli serve per far notare a Dio che lui non è come quello.
Ringrazia Dio per il bene che ha fatto e fa, per i meriti che accumula con alcune osservanze supplementari (digiuni e decime, riparando così i peccati di tanti miscredenti). Nella preghiera di quest’uomo sicuro di sé e della propria giustizia, che si sente perfettamente a posto con Dio e migliore degli altri, non c’è veramente ringraziamento a Dio. Se mai, Dio dovrebbe ringraziarlo.
Invece il pubblicano, ossia un esattore delle imposte (relegato dai devoti nel rango dei peccatori, a motivo del loro mestiere infamante e della collaborazione con l’occupante romano), non osa alzare gli occhi al cielo né sollevare le mani (vuote di opere buone e colme di abominazioni), le adopera semplicemente per battersi il petto come fa il penitente o chi è disperato. Egli ripete solo un’invocazione che richiama il salmo penitenziale davidico: ”O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Ora, la conclusione è sconcertante. A differenza dell’altro, il pubblicano tornò a casa giustificato. Davanti a Dio è riconosciuto giusto il peccatore pentito rispetto al pio Giudeo osservante della Legge.
La preghiera umile e sincera del pubblicano è la condizione per ottenere il perdono dei peccati. Dio non condanna certo le opere buone del fariseo, né tanto meno approva le disonestà dell’esattore. Semplicemente, la condotta buona dell’uno, il fariseo, si traduce in un atteggiamento sbagliato di fronte a Dio e nei confronti del prossimo, mentre la condotta peccaminosa dell’altro, il pubblicano, sfocia nell’atteggiamento giusto nella preghiera: non ha nulla di buono da offrire, non ha nulla da rivendicare, e quindi tutto da ricevere da Dio; la propria miseria gli basta e conta unicamente sulla grazia o misericordia di Dio.
Don Joseph Ndoum
Il fariseo di ieri e di oggi
Il fariseo, di ieri e di oggi, si crede puro, giusto, diverso, migliore e superiore rispetto agli altri, possessore, in esclusiva, della verità e col diritto a giudicare, disprezzare e condannare. Il cuore della sua preghiera è il suo stesso io: io digiuno, io pago, io prego..., io esigo. Il fariseo non dialoga con Dio. Il suo ringraziamento è un monologo di auto compiacenza. Una persona così si nega all’amore e all’accoglienza di Dio come amore, Padre/Madre di tutti.
Il Pubblicano è ben cosciente di tutti i peccati che pesano su di lui. Nonostante ciò che si possa dire di lui, la sua unica speranza di sentirsi accolto è Dio. Lo stesso Dio che altri usano per mettergli addosso la paura e la percezione di sentirsi rifiutato. Il pubblicano cerca, ha bisogno di accoglienza, di dolcezza, della comprensione di Dio, del Dio che non si ritrova nelle istanze pubbliche ed ufficiali della religiosità tradizionale, che lo giudica e lo rinnega.
Gutierrez C.
Annunciare il Vangelo è il primo servizio della Chiesa all’umanità
Siracide 35,15b-17.20-22°; Salmo 33; 2Timoteo 4,6-8.16-18; Luca 18,9-14
Riflessioni
Nella Parola di Dio per quest’ultima domenica di ottobre, mese missionario straordinario, campeggia la figura di S. Paolo, l’instancabile e ardente annunciatore del Vangelo ai popoli al di fuori del popolo ebraico, ad gentes, cioè ai gentili, ai pagani, alle genti, come si dice tecnicamente nei documenti del Concilio Vaticano II. Nel brano odierno della seconda lettera al discepolo Timoteo (II lettura) Paolo prevede il suo prossimo martirio, è pronto “per essere versato in offerta” (v. 6). Nel momento di lasciare questa vita, egli ha una consolante certezza interiore: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede” (v. 7). La sua certezza si fonda sulla fede, anche se la fede non esclude che l’uomo, l’apostolo, faccia esperienza della sua fragilità e viva momenti di paura. Nella prova Paolo ha sperimentato la vicinanza del Signore, che “mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero” (v. 17).
Nella sua brevità, questa parola di Paolo presenta l’intero arco della missione affidata da Gesù agli Apostoli e alla Chiesa: l’invio, l’annuncio, l’universalità, la fatica, la fede, la comunità, la testimonianza, i risultati, il martirio… Il tutto vissuto nella certezza della presenza del Signore. In questo, Paolo è modello del missionario che parte e annuncia il Vangelo fidandosi totalmente del Signore. Alla fine della sua esistenza (v. 6), Paolo potrebbe ostentare i suoi meriti di battaglia, vittoria e fedeltà (v. 7), ma egli non fa leva su meriti personali; professa la sua piena fiducia nel Signore Gesù, che non abbandona chi lo attende con amore (v. 8). Paolo attribuisce al Signore l’esito della missione compiuta, Lo loda e si abbandona a Colui che lo “porterà in salvo nei cieli, nel suo regno” (v. 18).
Il Signore Gesù convoca e coinvolge ogni battezzato nella missione. Il cristiano serve la missione pregando, partendo e collaborando con chi parte. (*) Anzitutto pregando (I lettura). La preghiera insistente del povero e dell’oppresso ha una forza particolare presso il Signore, il quale, pur accogliendo tutti, “ascolta la preghiera dell’oppresso”, dell’orfano e della vedova (v. 16-17). Nella sua giustizia, il Dio della Bibbia ristabilisce l’equità schierandosi dalla parte del povero. Gesù lo conferma con la parabola dei due oranti del tempio: il fariseo e il pubblicano, dittico esclusivo di Luca (Vangelo). Ha una sua logica umana il fariseo, che si presumeva giusto: egli espone a Dio le sue pratiche morali e le osservanze esemplari (v. 11-12), in forza delle quali, secondo lui, merita di essere premiato. Il fariseo non si attende la salvezza come dono, ma come un diritto acquisito con le sue opere buone. Nella preghiera del fariseo non c’è apertura a Dio, ma solo auto-ostentazione e, di conseguenza, allontanamento e rifiuto degli altri (v. 11-12); egli ringrazia sé stesso, non Dio. Non prega Dio, contempla solo sé stesso; la sua è una preghiera senza Dio. Si sente autosufficiente; di conseguenza giudica severamente gli altri.
Il Signore, invece, offre la salvezza a chi, con umiltà, sa di non esserne degno; al pubblicano, che ha certamente peccato, ma ne implora pietà: «O Dio, abbi pietà di me peccatore» (v. 13). È cosciente dei suoi limiti. Non si permette di giudicare. Riconosce il suo peccato. Non gli rimane che affidarsi e aprirsi alla misericordia di Dio. Alla fine solo il pubblicano torna a casa sua “giustificato”, cioè reso giusto da Dio (v. 14). Al fariseo non viene chiesto di rinunciare alle sue osservanze, ma di abbandonare l’immagine falsa di un dio contabile e cassiere, condizionato dalle opere umane. Il pubblicano, invece, che ha sperimentato la misericordia gratuita di Dio, vedrà fiorire in sé le opere buone come segno che il Signore - solo Lui! - lo rende giusto. Ciascuno di noi deve confrontarsi con questa parabola di Gesù, perché in ognuno di noi c’è un po’ del fariseo e del pubblicano!
I missionari che marcano la storia (come Paolo, Francesco Saverio, Comboni, Libermann, Vénard, Chanel, Cabrini, Teresa di Calcutta e molti altri) sono convinti di essere custodi ed annunciatori di un Vangelo che viene dal cuore di Dio per la vita del mondo. Seguendo i loro passi, ogni missionario e missionaria, ogni cristiano, in virtù del battesimo, è chiamato ad annunciare ad altri il Vangelo. Perché l’annuncio del Vangelo è un servizio prioritario e urgente alla famiglia umana: “è il primo servizio che la Chiesa deve all’umanità di oggi, per orientare ed evangelizzare le trasformazioni culturali, sociali ed etiche; per offrire la salvezza di Cristo all’uomo del nostro tempo” (Benedetto XVI; RMi 2).
Per la diffusione del Vangelo, la testimonianza personale vale più delle parole, come già insegnava il martire S Ignazio di Antiochia (17 ottobre), all’inizio del secondo secolo: “È meglio essere cristiano senza dirlo, che proclamarlo senza esserlo”. Conosciamo già le forme di collaborazione missionaria (preghiera, sacrificio, vocazioni, informazione, opere di misericordia e altri gesti di solidarietà). Come parte della loro testimonianza missionaria, oggi i cristiani sono chiamati ad offrire segni di speranza e a divenire fratelli universali, per fare del pianeta la casa di tutti i popoli, secondo il piano di Dio. Sfida esaltante, per ciascuno! Sfida irrinunciabile della Missione!
Parola del Papa
(*) “Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla propria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato dai Sacramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo e celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana nel rispetto della libertà personale di ognuno, in dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. La missio ad gentes è sempre necessaria alla Chiesa… La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo Speciale sulle Chiese in Amazzonia mi porta a sottolineare come la missione affidataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale e necessaria anche per quelle terre e per i loro abitanti… Le Pontificie Opere Missionarie (Pom) sono come una rete globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario, con la preghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mondo intero… Nel rinnovare il mio appoggio a tali Opere, auguro che il Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019 contribuisca al rinnovamento del loro servizio missionario al mio ministero”.
Papa Francesco
Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2019
P. Romeo Ballan, MCCJ