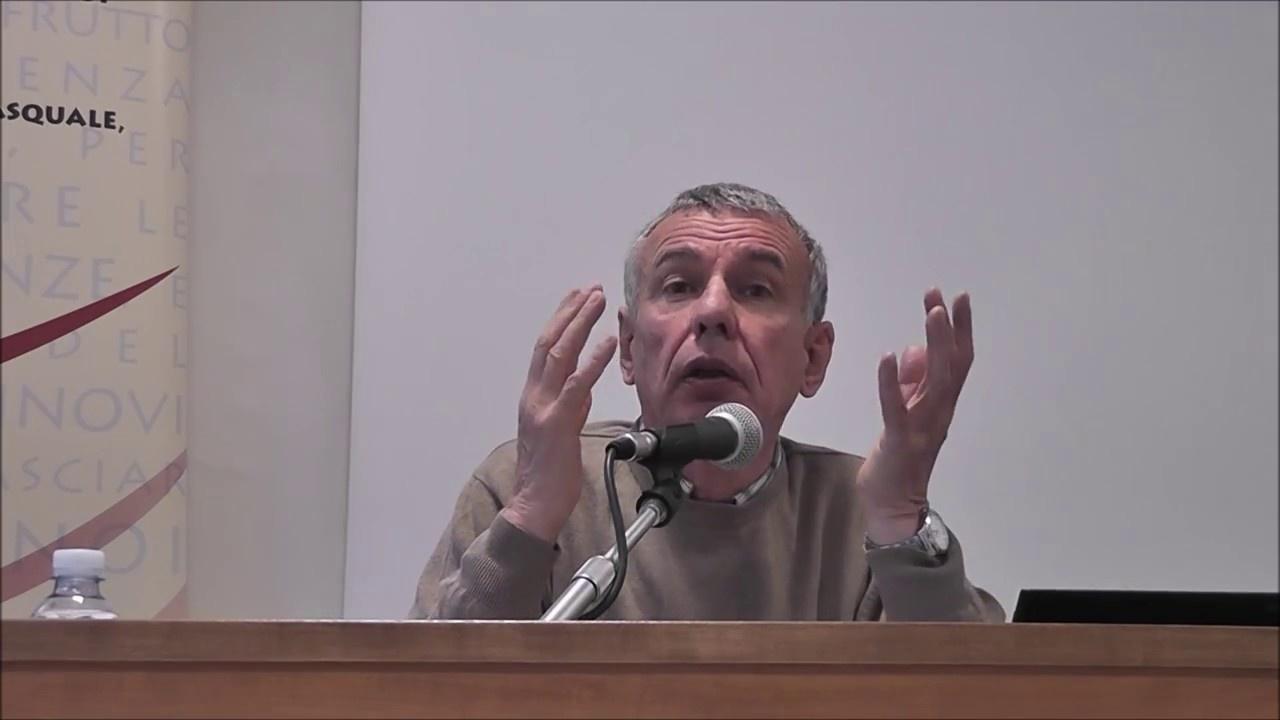Daniel Comboni
Missionários Combonianos
Área institucional
Outros links
Newsletter
Lunedì 8 settembre 2025
In Sud Sudan la pace resta un orizzonte fragile e necessario, da costruire giorno per giorno nelle comunità, tra ferite ancora aperte e povertà strutturali. Ne è convinto mons. Christian Carlassare, missionario comboniano e vescovo della giovane diocesi di Bentiu, eretta da papa Francesco nel 2023. (...) [Foto: Caritas italiana. Testo: SIR]
In Sud Sudan la pace resta un orizzonte fragile e necessario, da costruire giorno per giorno nelle comunità, tra ferite ancora aperte e povertà strutturali. Ne è convinto mons. Christian Carlassare, missionario comboniano e vescovo della giovane diocesi di Bentiu, eretta da papa Francesco nel 2023. Un territorio vastissimo, segnato da conflitti, sfollamenti e precarietà, dove la Chiesa si fa famiglia, spazio di incontro e di speranza. Carlassare racconta le sfide e le fatiche di un popolo che “aspira alla pace”, e il compito della comunità ecclesiale chiamata a resistere alla logica delle armi e a generare fraternità.
Nel 2021, poco prima della sua ordinazione episcopale, lei è stato vittima di un grave attentato. Quell’esperienza ha prodotto più cicatrici o linfa?
È stata una esperienza molto dolorosa sia per me che per la chiesa in Rumbek. Porto le cicatrici sulle gambe, ma altri le portano nel cuore, soprattutto chi ancora non riconosce l’errore fatto. Abbiamo tutti bisogno di verità, conversione e perdono. In diocesi ci siamo tesi la mano, ci siamo rialzati e abbiamo iniziato un bel percorso insieme. Quindi direi che le ferite hanno portato più linfa che aiuta la guarigione. È stato un momento di grazia, fraternità e cambiamento che continua a portare frutti per capire meglio cosa significhi essere chiesa, comunità più matura nella fede e nell’amore. La sfida è togliere l’etichetta di una chiesa/agenzia umanitaria perché si veda sempre più il vero volto di una chiesa famiglia, comunità alternativa di resistenza e cambiamento nella fede.
Quali sono le sfide più grandi in un contesto complesso come il Sud Sudan, ferito da guerra, vulnerabilità climatica, tensioni sociali che lacerano la società e acuiscono la povertà?
Il paese aspira alla pace. Ma la pace non scende dal cielo se non siamo pronti ad accoglierla nei nostri cuori e costruirla a partire dalle comunità, giorno per giorno, superando le relazioni conflittuali. La chiesa può svolgere un ruolo cruciale nell’educazione alla pace delle giovani generazioni. Prima di tutto attraverso la denuncia e la profezia, parlando apertamente contro la proliferazione delle armi, l’arruolamento di giovani, violenze e ingiustizie. I media ci possono aiutare a trasmettere messaggi di speranza, piuttosto che alimentare sconforto con pregiudizi e ideologia.
Cosa significa essere vescovo di Bentiu, zona devastata dal conflitto, con il più grande campo profughi del paese e 130 mila sfollati totalmente dipendenti dall’aiuto umanitario?
Essere vescovo qui mi chiede di fermarmi, di chinarmi e farmi prossimo di una popolazione che è stata vittima di briganti. Ci vuole tanta pazienza, e compassione. Le risorse sono limitate: non abbiamo che vino e olio per trattarne le ferite, e quanto basta per pagare due giorni alla locanda che accoglie tutti. Ma la risorsa più bella è la nostra umanità e la solidarietà. La Provvidenza non mancherà nella misura in cui vivremo la fraternità con coraggio e speranza. Sarà importante sostenere iniziative per lo sviluppo umano integrale e la giustizia sociale incoraggiando attività economiche e accesso a servizi essenziali come acqua e salute. Siamo nel mezzo di una palude dove da 5 anni il 30% del territorio è sott’acqua, ma non abbiamo acqua potabile e nei mesi scorsi, abbiamo avuto una terribile epidemia di colera che si è portata via quasi 200 vite, soprattutto anziani e bambini.
Papa Leone XIV ha sottolineato che “La nonviolenza come metodo e come stile deve contraddistinguere le nostre decisioni, le nostre relazioni, le nostre azioni”. Una scelta che chiede, però, anche cambiamenti strutturali…
È tempo di un nuovo risveglio. La politica è subordinata agli interessi del mercato. Si continua a fare la guerra perché ci sono interessi economici sostenuti da gruppi di potere. Si parla di riarmo e deterrenza, ma è ideologico pensare che le armi possano aiutarci a mantenere la pace. In realtà si mantiene il mondo in una dinamica permanente di conflitto e di emergenza umanitaria. Prima o poi quelle armi saranno vendute, scambiate o regalate. Allora in questo momento storico che sembra avere perso la strada della pace, del dialogo e della nonviolenza, dobbiamo avere il coraggio di invertire la rotta. Come dice papa Leone: “Il male non trionferà”.
È possibile ricomporre fratture coinvolgendo tutti e creare comunione, attraverso un dialogo che riconosce e attraversa differenze e conflittualità?
È importante creare spazi di incontro e dialogo. Una parte di popolazione non è mai entrata in contatto con lingue, culture, etnie diverse, mentre in alcuni contesti si è imparato a vivere insieme, come nelle città, o nei centri dove la popolazione era sfollata. Lì si era sviluppato un forte senso di solidarietà, ma il conflitto e la politica degli ultimi 20 anni hanno fatto leva sulle divisioni, con conseguenze drammatiche. Per esempio la popolazione Nuer e la popolazione Dinka di Ruweng hanno vissuto per decenni insieme sentendosi parte di uno stesso popolo, ma da 10 anni non è più così. La gente porta le ferite degli eccidi del 2013 e del 2014 su base etnica, dove sia Nuer che Dinka sono stati uccisi. Oggi il problema più grande è la divisione del territorio: ognuno vuole le aree ricche di materie prime e pozzi petroliferi. La politica dovrebbe intervenire per unire, non per dividere.
Come promuovere cura e cultura della pace nel quotidiano, attraverso relazioni, storie, iniziative che aprono alla speranza e concorrono allo sviluppo integrale e alla giustizia sociale?
Sogno che, oltre a quelle comunità cristiane che già vivono il Vangelo della speranza, si possano creare villaggi della pace, con persone di diversa etnia. Ci sarà bisogno di autonomia economica e si potrebbe pensare a progetti agricoli e di allevamento. Ma anche attività di artigianato e produzione, come l’industria alimentare che è quasi inesistente in Sud Sudan. Segnalo poi una realtà: da qualche anno all’università cattolica del Sud Sudan c’è il corso per la pace che studia percorsi di risoluzione dei conflitti, convivenza e sviluppo. C’è anche l’intenzione di avviare la facoltà di legge per contribuire a una società con meno corruzione, più spazio per la giustizia e rispetto per la dignità di ogni persona.
I giovani nella Chiesa e nella società sud-sudanese hanno certamente bisogno di esperienze di speranza. Può raccontarcene una?
Una bella esperienza è quella con i giovani di Rumbek: un pellegrinaggio di pace per incontrare le comunità e trasmettere un messaggio di comunione e speranza. Il primo è stato nel 2023: con circa 80 giovani abbiamo camminato nove giorni per incontrare papa Francesco a Juba. In passato è capitato che i giovani reclutati in varie milizie hanno marciato con fucili in mano. Ora invece si sono messi a camminare insieme, per conoscere le diverse comunità e affermare che la pace è possibile se si ha il coraggio di cercarla e costruirla ogni giorno. Quell’esperienza continua e unisce giovani che saranno capaci di impegno costante per la comunione e la pace.
La scuola può diventare ambiente di educazione e formazione alla pace, ai diritti umani, alla cittadinanza responsabile?
Le scuole stanno muovendo i primi passi con maestri spesso non qualificati e programmi zoppicanti. Ma sono veri e propri luoghi di speranza. Al momento solo il 20% dei bambini hanno accesso all’istruzione primaria, e solo il 5% frequenterà la scuola superiore. Per le bambine è peggio. La scuola non deve solo istruire ma educare e formare su queste tematiche trasversali.
Quale messaggio vuole dare alla Chiesa e alle comunità italiane che continuano ad accompagnare e sostenere gli sforzi della Chiesa del Sud Sudan, ben sapendo che sono gocce in un mare di bisogni?
Il mondo è una casa comune: non si può vivere bene in una parte quando si distrugge e se ne affama un’altra. Abbiamo la responsabilità di rendere questo mondo più umano e fraterno e opporci all’ideologia del riarmo, della sicurezza, dei confini. Bisogna rinascere nella speranza e avere il coraggio di cambiare, sapendo che il Signore accompagna e redime la storia attraverso anche il nostro sì alla Sua chiamata, un sì alla vita.
Progetti Cei in Sud Sudan
La Chiesa cattolica nel Paese è molto giovane, ci sono vocazioni locali e anche una grande presenza di religiosi missionari. Una realtà molto viva che la Conferenza episcopale italiana ha sostenuto e accompagnato. In particolare attraverso il Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli ha finanziato 58 progetti grazie a 16,5 milioni di euro provenienti dai fondi 8xmille destinati dai cittadini alla Chiesa cattolica. È stato possibile intervenire in vari settori: sanità, con ospedali e cliniche, agricoltura, approvvigionamento idrico, istruzione, con scuole di tutti i livelli e progetti di educazione inclusiva come quelli realizzati con AVSI. Ma anche in altri ambiti, come appunto quello dei ragazzi di strada, o quello della salute mentale, con il progetto M(H)IND (Mental Health and Integration for Development), coordinato da AMREF per avviare e rafforzare servizi integrati. Sono stati anche messi a disposizione fondi per far fronte alle emergenze causate dalla guerra, dalla siccità, dalle inondazioni per realizzare, attraverso Caritas Italiana, interventi di carattere sanitario e nutrizionale di Medici con l’Africa CUAMM, dando anche supporto all’ospedale comboniano di Wau e a progetti di riabilitazione socio economica della Caritas locale.
Scheda Sud Sudan
Il Sud Sudan ha una straordinaria diversità culturale con oltre 60 gruppi etnici e più di 80 lingue parlate e una grande ricchezza, il petrolio, che però alimenta corruzione e conflitti. È il Paese più giovane, ma anche tra i più poveri del mondo. È all’ultimo posto nella classifica dell’Indice di Sviluppo Umano dell’UNDP, segnato da instabilità politica e insicurezza, emergenze alimentari, siccità, inondazioni e collasso economico. Più della metà della popolazione è in condizioni di crisi umanitaria e il sistema sanitario dipende quasi interamente dai partner internazionali. Insieme al Ciad e all’Egitto ospita il maggior numero di persone in fuga dal Sudan. Nato il 9 luglio 2011, frutto di un referendum che ha posto fine a decenni di guerra civile, dopo 14 anni quel sogno sembra svanire. Le elezioni che dovevano svolgersi nel 2024, sono state posticipate di due anni.
Ferruccio Ferrante – SIR