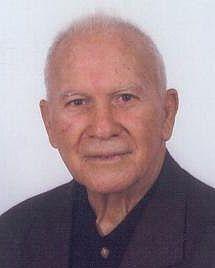Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
In Pace Christi
La Salandra Antonio
Era nato a Troia (Foggia) il 13 giugno 1923, da una famiglia povera, di mezzadri, e aveva perso il papà a sei anni. La sua vocazione si rivelò all’improvviso: una sera, a casa, dopo il rosario, la mamma chiese chi dei figli volesse farsi prete e Antonio, senza pensarci, rispose subito: “io!”. Il giorno dopo partì per Troia con un compaesano che viaggiava con il carretto e si recò, da solo, in seminario. Fu accolto bene e gli fu assegnato un sacerdote che in pochi mesi lo aiutò a prepararsi e a superare con successo gli esami di prima media. Nel seminario diocesano vescovile di Troia completò anche il ginnasio; poi fece la Filosofia e la prima e seconda Teologia nel seminario regionale Pio XI di Benevento.
Avendo chiesto di entrare dai Comboniani, fu ammesso nel noviziato di Firenze nel 1946 e concluse gli studi di Teologia a Venegono Superiore. Fu ordinato sacerdote il 19 maggio 1951 dal Cardinale Ildefonso Schuster.
Destinato alla missione dell’Uganda, andò per un anno in Inghilterra a studiare l’inglese, secondo quanto stabilito dal governo britannico per gli italiani che si recavano in Uganda, allora protettorato inglese.
In Uganda
P. Antonio fu assegnato al West Nile, dove ha svolto il suo apostolato per 54 anni, cioè fino al 2007. La sua prima missione fu Maracha. Dovette darsi da fare per imparare la lingua, nella quale non c’era nulla di scritto, e le usanze, accorgendosi ben presto, come ebbe a scrivere, che “la mia cultura era molto lontana da quella del mio popolo, con altri valori umani e altri costumi, con un’etica diversa da quella europea e italiana”. Imparò anche a fabbricare mattoni, a fare il muratore e il carpentiere. “Quando arrivai a Maracha, i cristiani erano non più di cinquemila, ora (1986) sono più di cinquantamila, compresi i cattolici di Olovu, che fu distaccata da Maracha il 25 gennaio 1965”.
Nell’agosto del 1953 fu trasferito a Ediofe (Arua), che allora comprendeva metà territorio di tutta la tribù dei logbara. Qui capì l’importanza, oltre che delle visite a domicilio, delle scuolette (bush-schools) per aumentare l’istruzione scolastica, quasi inesistente, e il numero dei catecumeni. Un altro fattore importante furono le cappelle, attorno alle quali si organizzavano la vita cristiana e sociale. La sua prima cappella fu quella di Olupi.
Verso la fine del 1957, P. Antonio ebbe l’incarico di parroco a Lodonga, che contava allora (con Otumbari) quasi ventimila cattolici su una popolazione di ottantamila e un territorio che si estendeva dal Sudan alla valle del Nilo per un raggio di 80 km. I cristiani erano quasi tutti nella zona di Otumbari, mentre verso Lodonga erano pochi e disseminati tra i musulmani che costituivano la maggioranza. Aveva sempre ben presente il consiglio che P. Pietro Valcavi gli aveva dato sul letto di morte: “Il Signore ti amerà con la stessa misura con cui tu amerai i tuoi africani”, e infatti scriveva: “È questa la forza, il motivo, la ragione per cui ho sacrificato tutta la mia vita di missionario con questa gente logbara. Si sono presentate occasioni per una vita più facile, tentazioni di scapparmene, situazioni propizie per lasciare, come la guerra del 1979-81, lo scoraggiamento per un apostolato infecondo e fallimentare: ma quella figura ieratica del primo missionario di Lodonga e quella sentenza ‘nella misura in cui...’ mi hanno tenuto inchiodato, senza piegare a destra o a sinistra, in mezzo a questa popolazione che è per me mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle”.
Dopo dieci anni d’Africa, ritornò in Italia per le vacanze. Qui gli fu chiesto di fare propaganda vocazionale missionaria nei seminari del meridione; così cominciò presto la visita dei seminari: conferenze, esercizi spirituali, vendita di libri e proiezione di film a sfondo missionario.
Mons. Tarantino, però, lo volle di nuovo in Uganda per costruire il seminario diocesano a Pokea, su una collina a tre km a ovest della missione di Ediofe. Nel lasciare l’Italia, P. Antonio disse: “Questa è la seconda volta che parto per l’Uganda. La prima volta non sapevo a cosa andavo incontro, sapevo solo quello che lasciavo qui in Italia. Adesso invece so cosa lascio e cosa troverò, so cosa andrò a fare, con chi avrò a che fare: questa seconda partenza mi costa di più, perciò la mia gioia è più completa”. Durante i suoi sei anni e mezzo di servizio in seminario vi furono due grandi avvenimenti: nel 1962 iniziò il Concilio Vaticano II e ci fu l’indipendenza del paese dal colonialismo inglese (9 ottobre). Poi, nel 1964, vi fu la rivoluzione in Congo, che allora si chiamava Zaire. “Essendo confinanti con lo Zaire (4 km), fummo spettatori di scene crudeli di gente che scappava dalla propria patria per nascondersi nei villaggi ugandesi”. Le cose non andarono molto meglio in Uganda, dove, secondo P. Antonio, “gli ugandesi sono stati traditi prima dagli inglesi e poi dai loro illegittimi capi”.
Terminato il suo servizio in seminario e dopo una breve vacanza in Italia (1968), P. Antonio fu mandato nuovamente nella missione di Maracha. “Per me fu molto facile adattarmi alla vita della parrocchia. Conoscevo un gran numero di cristiani e catechisti di questa missione che era stata il mio primo amore. Succedetti alla guida di questa parrocchia a P. Giuseppe Zeno Picotti, un uomo molto zelante e buono con la gente, che aveva costruito molte scuole e dato molto impulso al nascente ospedale. Era un momento di transizione: dal tempo pionieristico a quello dell’approfondimento della fede e del consolidarsi della Chiesa. Nel tempo pionieristico si lavorava più da individualisti, da paternalisti, a seconda delle potenzialità personali e dell’estro del saper fare. Mancava un indirizzo dell’apostolato d’insieme e delle iniziative per una nuova evangelizzazione. Si cominciò cercando di implementare le riforme del Concilio Vaticano II, iniziando dalla liturgia, dalla celebrazione dei sacramenti, dall’iniziazione cristiana, dalla catechesi degli adulti. Si passò ad insegnare che la Chiesa doveva autosostentarsi e autogovernarsi. La gente diceva: ‘Per questi cambiamenti ci vorranno degli anni e forse i figli dei nostri figli capiranno qualcosa’. Ci vollero sei mesi per realizzare qualcosa. Si riuscì a formare il consiglio pastorale spiegando i vari compiti dei diversi membri”.
Le ausiliarie laiche e il dialogo con i musulmani
“Fin dai miei primi anni di missione sono stato fortemente colpito dalla povertà della donna, dalla sua condizione di schiavitù nei confronti dell’uomo. Mi andavo ponendo un interrogativo, che mi assillò per lungo tempo: che fare? In seminario c’erano delle ragazze che aiutavano nel riassetto della biancheria e nel confezionare le vesti ai seminaristi: furono di grande aiuto. Nel frattempo cercavo di farle partecipi del mio piano su di loro: avrebbero dovuto formare un gruppo di laiche impegnate nella Chiesa e nella società, esempio di emancipazione, di occupazione di un ruolo preciso nella Chiesa, nella famiglia e nella stessa politica. Pregavo e cercavo come attuare questo disegno, che ormai era chiaro nella mia mente”.
Nel 1969 iniziò il progetto delle “ausiliarie laiche” (Lay Helpers) con la costruzione di un primo fabbricato, con l’aiuto di Fr. Rodolfo Arosio, che poteva ospitare una trentina di ragazze. Dopo la formazione, che durava da uno a due anni, la ragazza faceva una promessa semplice promettendo di vivere secondo la costituzione dell’associazione, s’impegnava a essere di esempio di vita cristiana per le donne e a lavorare per la loro promozione umana.
Nel 1979-81 l’Uganda fu spaventoso teatro della guerra civile che portò alla cacciata del dittatore Idi Amin Dada e ai conseguenti orrori. Nel luglio 1979 i missionari avvertirono i catechisti di consigliare alla gente logbara di rifugiarsi nel vicino Congo o in Sudan. Vi fu un esodo di oltre trecentomila persone. P. Antonio poté ritornare a Maracha solo nel dicembre del 1980 ma non trovò che devastazione e desolazione. Avendo saputo dell’arrivo di P. Antonio, la gente cominciò a farvi ritorno. Nel gennaio 1983 P. Antonio iniziò il Centro Catechistico di Maracha.
Dopo Maracha fu trasferito a Lodonga, dove rimase dal 1987 al 1997, per la ricostruzione materiale e spirituale della parrocchia, la più colpita dalla guerra. Quando la popolazione fece ritorno alla missione, dopo sei anni in Sud Sudan, lo stato di deterioramento della zona era desolante. P. Italo Piffer si prodigava a distribuire coperte, sale e zappe, a cristiani e musulmani indistintamente. Anche la Basilica della Mediatrice si presentava in uno stato disastroso. “Fortunatamente le campane non avevano subito danni, il loro tocco era lo stesso che ai tempi di P. Bernardo Sartori. Il loro squillo riempiva la valle del Cocci”. Alla fine della ristrutturazione, fatta seguendo le indicazioni liturgiche del Concilio, la Basilica divenne meta di pellegrinaggi.
Davanti a tanti giovani rientrati dall’esilio, P. Antonio ebbe l’idea di offrire loro una scuola tecnica o artigianale perché potessero apprendere un mestiere. Iniziata nel 1988, fu registrata e approvata dal ministro dell’educazione come centro di esami e di diploma tecnico: “più di 500 giovani sono stati diplomati e hanno trovato un lavoro dignitoso”, scriveva P. Antonio. “Nel 1997 partii per l’Italia per le vacanze, lasciando le istituzioni ben avviate: la scuola tecnica, il dispensario, l’asilo e il centro pastorale”.
Ancora altre missioni in Uganda
La sua missione successiva fu quella di Odravo (1997-1999), staccata dalla missione madre di Lodonga e a 50 km da Arua, con settemila cattolici in una popolazione a stragrande maggioranza musulmana. “Ai primi di gennaio del 1997, in viaggio per le vacanze, mi fermai al Cairo con l’intento di approfondire di più la mia conoscenza dell’islam. Rimasi al ‘Dar Comboni’ per tre mesi. Mi misi di buona lena a studiare gli elementi di arabo e islamologia. Ero già vecchio, avevo 74 anni. Gli altri studenti ridevano di me. Ma io facevo sul serio perché dovevo preparami ad affrontare il dialogo con i miei musulmani. Fu una bella esperienza, a contatto con una realtà per me misteriosa, mista a contraddizioni con i valori umani”. Ritornato in Uganda, P. Antonio fondò e promosse il dialogo interreligioso nella diocesi, unico mezzo per unire le diverse fedi nella tolleranza e nel rispetto reciproco. “Nella formazione di catechisti, i diritti umani, la dottrina sociale della Chiesa e l’islam erano i temi più importanti delle nostre discussioni”.
A Odravo, in meno di un anno, si ebbero il centro pastorale, la casa dei padri a due piani e il centro di formazione per la donna. “Il pozzo fu come una delle sette meraviglie del mondo. La gente non credeva che scavando si trovasse acqua e quando apparve la prima acqua, gli scavatori saltarono fuori dal pozzo: pensavano di sprofondare e di andare a finire nel Nilo”.
La missione subì alcuni attacchi dei ribelli del vecchio esercito di Amin e anche P. Antonio rischiò la vita più di una volta, fino a che anziani e ufficiali governativi, compreso lui, iniziarono degli incontri con i ribelli per trovare una via di pace che arriverà all’accordo del febbraio 2003.
A metà novembre 1999, P. Antonio fu costretto a lasciare la missione per motivi di salute e a ritornare in Italia, probabilmente a causa della malaria. Ristabilitosi, partecipò al Corso di Rinnovamento a Roma.
Ritornato in Uganda, dopo una breve permanenza a Ombaci, ebbe dal vescovo l’incarico di aprire una nuova missione a Yumba, nel cuore di una regione abitata dai musulmani. Con lo spirito di un missionario novello, all’età di ottantun anni, costruì la casa dei missionari, la scuola e la bella chiesa di Maria, Regina del cielo.
Il ritorno
Nel 2007 ritornato in Italia, andò a risiedere a Troia. Dopo un breve ricovero nella casa comboniana di Castel D’Azzano, il 7 agosto 2015 è morto all’età di 92 anni. I funerali sono stati celebrati lunedì 10 agosto nella cappella della casa. Il feretro è poi partito alla volta di Troia per la sepoltura.
Ricordiamo che P. Antonio ha scritto anche numerosi libri sulla storia della Chiesa, sui Logbara, sui sacramenti, ecc., alcuni dei quali in lingua logbara. Ne menzioniamo alcuni: The History of the Catholic Church in West Nile, Storia del catechista della Chiesa del Nilo occidentale, Sì e No. Una vita per l’Uganda (la sua autobiografia), Ho amato i Lobgara, e l’ultimo, pubblicato l’anno prima della sua morte, Storia del seminario, della casa dei Comboniani e della parrocchia Mediatrice di Troia.
È bello concludere con le parole che aveva scritto in occasione del suo 50° di ordinazione sacerdotale: “Voglio dar gloria a Dio e alla Vergine Santa. Voglio ringraziare mio padre Giuseppe e mia mamma Marietta per avermi generato. Voglio onorare i miei Logbara e far memoria di loro, cui devo la mia conversione alla povertà e ai valori umani; lo devo a loro se sono il missionario che sono. Poi intendo scrivere ai giovani in genere e ai giovani comboniani in particolare, perché leggendo queste righe possano entusiasmarsi alla loro vocazione alla missione. Voglio rendere omaggio all’Istituto comboniano per avermi adottato. Infine voglio accomunarmi a tutti quei missionari comboniani che hanno fatto della loro vita un olocausto a Cristo, Primo Missionario, al quale va ogni onore e gloria”.
Da Mccj Bulletin n. 266 suppl. In Memoriam, gennaio 2016, pp. 90-98.