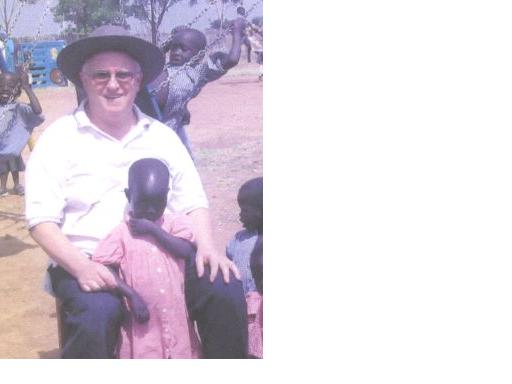Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
In Pace Christi
Ferrazin Giovanni
P. Giovanni Ferrazin proveniva da una famiglia di braccianti, dai solidi principi cristiani. La vita era dura, a quel tempo, per i lavoratori della terra, tanto che la famiglia emigrò a Merano (Bolzano). Inoltre, il papà, per guadagnare qualcosa in più andava periodicamente all’estero in cerca di lavoro. Quando, dopo le elementari, Giovanni manifestò il desiderio di entrare in seminario, papà Lino si trovava in Svizzera dove aveva trovato un buon lavoro. Sulle spalle di mamma Ida Pasqualin ricadde tutto il peso della formazione dei figli. Il futuro missionario era il sesto di otto figli.
A 13 anni Giovanni lasciò la famiglia ed entrò nel piccolo seminario comboniano di Padova. Aveva conosciuto P. Augusto Frison che batteva la diocesi in cerca di vocazioni. Il ragazzino dimostrò subito impegno e buona volontà. “Intelligente, ma lento a persuadersi delle cose – scrisse il superiore, P. Angelo Giacomelli –. Poi aggiunse: “Ha bisogno di essere incoraggiato e sostenuto, specialmente dal lato scolastico. Ho fiducia che possa riuscire un ottimo missionario”. Dopo le medie a Padova, passò a Brescia per il ginnasio, quindi, nel 1955, fu ammesso al noviziato di Gozzano, dove era padre maestro P. Pietro Rossi. “È sempre stato costante e pieno di buona volontà – ha scritto. – Pietà molto buona e buon criterio. È un po’ timido e impacciato, ma tanto generoso, di sacrificio e caritatevole. È molto attaccato alla vocazione”.
Con queste credenziali, il 9 settembre 1957 emise i voti temporanei poi passò a Verona per il liceo e a Venegono Superiore per la teologia. P. Igino Albrigo, superiore nel liceo di Verona, ha scritto di lui: “È un esempio alla comunità. Si segnala specialmente quanto a sacrificio, generosità, obbedienza, pietà e carità. Le sue grandi virtù ben suppliscono a qualche difficoltà da un punto di vista scolastico”. Nelle sue richieste per il rinnovo dei voti, insisteva su questo punto: “Voglio consacrarmi al Signore per diventare più simile a Gesù”.
Fu ordinato a Verona, nella chiesa del tempio votivo, dal cardinale Gregorio Agagianian. Questa ordinazione “fuori sede” doveva essere un omaggio ai missionari espulsi dal Sudan meridionale proprio quell’anno.
Prima tappa: missionario in Uganda
Sacerdote novello, P. Giovanni venne inviato a Londra per lo studio dell’inglese in vista della missione in Uganda. Ciò era richiesto dalla legge coloniale per i missionari che si sarebbero dedicati all’insegnamento. Le missioni che videro la presenza di P. Giovanni sono: Otumbari (1965-1970) come viceparroco; Olovu (1972-1973); Lodonga (1973-1975); Olovu (1975-1976); Ajumani (1977-1978); Moyo (1979-1982). Ad Otumbari era superiore P. Bernardo Sartori. P. Giovanni ebbe la fortuna di vivere fianco a fianco con questo sant’uomo, di assorbire il suo zelo missionario e l’amore alla Madonna. Quando si trattò di scrivere la biografia di P. Sartori, P. Giovanni fu uno dei più zelanti nel raccogliere documenti, ricordi e testimonianze. Se oggi P. Sartori è Servo di Dio, un po’ del merito è anche di P. Giovanni.
L’esperienza successiva di P. Giovanni fu nella missione di Lodonga, all’ombra della basilica dedicata alla Madonna Mediatrice, Sultana d’Africa. Il suo ministero preferito era andare tra la gente, visitare i vecchi e i malati, aiutare i poveri con tanta misericordia e bontà. Si preoccupava di costruire cappelle che diventavano “centri eucaristici” dove si pregava e si adorava il Signore.
A Lodonga passò un momento difficile: per mandare avanti la missione dovette contrarre qualche debito, ma a P. Giovanni i debiti non piacevano. Allora scrisse al Superiore Generale dicendo: “Sono nei guai finanziariamente e quindi grido aiuto. Ho gridato aiuto da tante parti, ma l’unica risposta è stata quella di mia mamma e dei miei amici di Merano. Visto che la Provvidenza non ha fretta di venirmi incontro, ho pensato di andare io da lei. Per questo chiedo di venire in Italia per una paio di mesi in modo da potermi dedicare alla Giornate Missionarie. Mi pare che questo sia stato il metodo messo in pratica da Comboni, quindi mi sento in buona compagnia. Intanto altre tre cappelle hanno l’Eucaristia e la gente prega, anche se i confratelli mi dicono di non lamentarmi dei debiti se continuo a costruire chiese. Il vescovo è largo di benedizioni, ma tutto si ferma lì…”. “Se tutti i missionari che sono nel bisogno venissero in Italia, sarebbe un disastro – gli rispose il Superiore Generale – tuttavia presenterò il tuo caso al procuratore il quale farà il possibile per darti una mano”. Piegò la schiena e strinse i denti: pagò i debiti ed ebbe anche le chiese. Poi andò in Italia per le vacanze e per risolvere qualche problema di salute.
Rimase a Roma solo dal 1970 al 1972 per il Corso di Rinnovamento e poi, dal 1983 al 1984, per un servizio in Curia generalizia come assistente del segretario generale, un incarico di grande fiducia ma che a lui andava stretto. E i superiori vollero venirgli incontro.
Seconda tappa: missionario in Sud Sudan
Così, P. Giovanni fu destinato al Sud Sudan, dove rimase dal 1984 fino alla morte, con una sola permanenza a Roma, per fare l’anno sabbatico, tra il 1991 e il 1992, e un secondo periodo a Padova come animatore missionario tra il 1992 e il 1999. Riportiamo, di seguito, le tappe del suo apostolato in Sudan: Loa (1984-1986); Juba (1986-1991); Nairobi (delegazione del Sud Sudan, 1999-2000); Moyo (2001-2005); Lomin, Kajo Kaji (2005-2006).
Per quanto riguarda il periodo padovano, nel giugno del 1990, a Padova, era stato chiuso il liceo per mancanza di vocazioni, mentre aveva iniziato a svilupparsi la comunità GIM e l’associazione “Unica terra” con il fine di assistere gli extracomunitari nelle loro pratiche legali. La casa si preparava a ricevere, nel settembre successivo, il postulato fratelli. Nel 1992, proprio all’arrivo di P. Giovanni, era cominciata la ristrutturazione della casa per adattarla ai postulanti. Il suo lavoro, era quello formativo. Il suo spirito di pietà, il suo attaccamento alla vocazione e l’esperienza della vita africana erano ottimi ingredienti per formare quei giovani allo spirito missionario.
In realtà, questi periodi in Italia avevano anche lo scopo di consentirgli di curare un po’ di più la salute. Anche in Italia, però, si dava molto da fare: ormai, utilizzava il computer che gli facilitava enormemente il lavoro di traduzione dei testi sacri, anche se il suo cuore, come quello di Comboni, non ha mai lasciato l’Africa e la sua gente assetata di Parola di Dio.
Nell’opera di traduzione dei testi, si faceva aiutare dai catechisti che lo aiutavano a trovare le parole più adatte per spiegare i concetti teologici. Aveva fatto questo lavoro anche quando era tra i Logbara a Moyo. Il primo messale festivo in quella lingua porta la sua impronta.
Nel 1991 fu assegnato alla missione di Loa. Qui si dedicò al lavoro pastorale con grande zelo, senza troppi riguardi per la salute. Visitava i villaggi, andava a trovare gli anziani, i malati, i lebbrosi e a tutti elargiva la sua carità. I confratelli vedevano che deperiva e gli dicevano di riguardarsi un po’, ma P. Giovanni era preso dai bisogni della gente e considerava un peccato tirarsi indietro. Quando le forze cominciarono ad abbandonarlo, si decise a rientrare in Italia per un anno sabbatico (1991-1992), anche se in realtà era per curarsi. Il Superiore Generale, P. Francesco Pierli, gli scrisse: “Dio ci parla attraverso gli eventi della vita. In questi ultimi anni si è visto che la tua salute non resiste alle difficoltà inerenti alle incertezze sociali dell’Uganda e del Sudan. Perciò mi sembra ovvio pensare a una tua tappa in Italia. Ciò ti dà la possibilità non solo di rimetterti ma anche di stabilizzare la salute”.
Apostolo della carità
P. Alfredo Mattevi che è stato insieme a P. Giovanni in missione verso gli anni 1990, scrive: “Mentre eravamo a Juba, nei pressi della missione c’era un povero giovane handicappato che spesso minacciava i missionari a parole e anche tirando sassi. Un giorno P. Giovanni gli è andato incontro e lo ha abbracciato in maniere affettuosa come se salutasse un fratello. Il giovane ha capito la lezione e, vinto da quel gesto di carità, non ha più importunato i missionari. A Juba, ha aiutato molti poveri, soprattutto rifornendoli di ami per pescare. Il Nilo, infatti, si trovava due passi e forniva pesce in abbondanza. Aiutava anche le madri di famiglia procurando loro le sementi per seminare, le zappe per coltivare la terra e altri attrezzi da lavoro. Aiutava la gente, ma con intelligenza, quasi portandoli a bastare a se stessi senza ricorrere continuamente alla carità del missionario”.
Durante l’omelia funebre a Lomin, il provinciale del Sud Sudan, P. Luciano Perina, ha raccontato questo episodio: “Due settimane fa stavo andando da Lomin a Moyo con P. Giovanni. Al posto di blocco del confine tra Sudan e Uganda ci siamo fermati per il controllo dei documenti. Mentre stavamo riprendendo la strada verso Moyo si sono avvicinate alcune donne con i loro recipienti per andare a prendere l’acqua. Mi sembravano troppe per prenderle a bordo e quindi ho detto loro che avevamo fretta e che andavamo vicino. P. Giovanni, facendosi loro avvocato, ha cominciato a spiegarmi che ogni giorno queste donne dovevano fare parecchi chilometri a piedi per andare ad attingere l’acqua per la famiglia e che, quando tornavano, avrebbero dovuto fare tutta la strada in salita col peso dell’acqua sulla testa. Poi, vedendomi ancora incerto, ha continuato dicendo che a volte dovevano fare tutto il percorso anche due o tre volte in una stessa giornata. E ha aggiunto che non avremmo dovuto lasciarle lì a metà strada, che, in fondo, non ci costava niente. Così le abbiamo prese tutte a bordo e abbiamo continuato verso Moyo. Lungo la strada, parlando in italiano, mi faceva notare com’era faticoso portare l’acqua sulla testa lungo un sentiero in salita e, per di più, sdrucciolevole. Arrivati al posto dove c’era l’acqua e fatte scendere le donne, P. Giovanni era veramente contento, più del solito, e ha continuato il suo sermone facendomi notare che certa gente ha una vita dura e andrà in paradiso con le scarpe, ‘anzi, senza, perché qui non hanno neppure quelle’. E ha sorriso dicendo che in Africa bisogna cambiare anche i proverbi.
Penso che questo fatto, accaduto poco prima della sua morte, riassuma bene ciò che è stata la vita di P. Giovanni, una vita tutta spesa nella tensione e nella preoccupazione per il bene degli altri”.
Trasmettitore della Parola di Dio
A Juba si applicò a fondo alla traduzione della Bibbia in lingua madi. “La Parola di Dio – diceva – per entrare nel cuore e per mettere radici, deve essere capita”. Questo lavoro divenne quasi esclusivo quando la salute cominciò a venire meno. Scrive in una lettera del marzo 1006: “Ora comincio a preparare il lezionario C per il prossimo anno. Non si tratta solo del lezionario ma di tanti altri piccoli lavori: rosario meditato, piccolo breviario per catechisti e commento del Vangelo della domenica. I catechisti della parrocchia e della diocesi devono avere qualcosa in mano per la liturgia domenicale che presiedono nelle loro cappelle. Un sacerdote locale mi disse: ‘Avevamo proprio bisogno di quello che stai facendo’. Come vedi, anche la malattia che mi costringe a passare molte ore davanti al computer è provvidenziale”.
Nel 1999, tanto insistette da essere mandato nuovamente in missione. Questa volta, però non andò in prima linea, ma ebbe l’incarico di segretario del provinciale del Sud Sudan che risiedeva a Nairobi. Intensificò il suo lavoro di traduzione perché aveva la percezione che la sua vita non sarebbe stata ancora molto lunga. Intanto “importunava” i superiori per essere mandato in prima linea. Quando compì il settantesimo anno di età, scrisse ad un amico: “Oggi ho raggiunto l’età biblica di 70 anni. Per questo chiedo a te e amici tutti di ringraziare con me il Signore per il dono della vita e della vocazione missionaria. Non solo ringraziare, ma chiedere misericordia e perdono per i miei peccati.
Dovrei cantare il Nunc dimittis con il profeta Simeone, ma con il Papa Giovanni aggiungo: ‘Non mettiamo limiti alla Provvidenza’. Il salmo 89 che parla di questa età (e dei più forti che arrivano agli 80 e più) ci invita a pregare così: ‘Insegnaci, Signore, a contare i nostri giorni per arrivare alla sapienza del cuore’ e ancora: ‘Saziaci al mattino col tuo amore e gioiremo per tutti i nostri giorni’.
Sono in Sudan meridionale, a Lomin (25 chilometri da Moyo) e incomincio, almeno per ciò che riguarda la lingua, tutto da capo, come un bambino con un po’ di impazienza (ciò che i bambini non hanno). Non so ancora balbettare niente in lingua bari. Ma ho imparato con un po’ di fatica l’Ave Maria e qui bisogna dirne tante di Ave Maria, perché siamo immersi in un mondo a maggioranza protestante e la Madonna non la pregano affatto. Il Signore mi dà tanta buona volontà e pazienza, ma la mia memoria è quella che è, o meglio, quella che è sempre stata, una frana.
Papa Giovanni diceva ai suoi cardinali che gli volevano insegnare l’inglese: ‘Campa cavallo che l’erba cresce’ Ma io non devo fare il Papa e spero proprio di imparare almeno un po’ di questa lingua per essere utile all’evangelizzazione. Ho computerizzato i tre anni di Lezionario festivo in bari, il messale e mezzo vocabolario. Le parole sono lì nel computer e spero che verranno alla luce anche nella mia testa”.
Nel 2002 tornò in Italia per un periodo di riposo. Gli fu riscontrato un tumore maligno alla prostata. Fu fatto di tutto per curarlo e, dopo un anno e mezzo di cure e interventi chirurgici, all’inizio del 2004 poté tornare a Moyo, anche se con qualche conseguenza pratica piuttosto fastidiosa. Tuttavia P. Giovanni non si lamentò mai e cercò di portare avanti il ministero come quando era sano. Il suo provinciale, a questo proposito, disse: “L’operazione gli lasciò qualche fastidio umiliante eppure non l’abbiamo mai sentito lamentarsi. Era così preoccupato del bene degli altri che non gli restava il tempo per lamentarsi e, forse, neanche per badare alla sua penosa situazione”.
Nei campi profughi
Intanto si aprì un altro campo di lavoro per il suo zelo: i campi profughi. Migliaia e migliaia di persone, prive di tutto, si erano ammassate con le loro famiglie a Kokoa. P. Giovanni moltiplicò le sue forze e dilatò i confini della sua carità. Quando vedeva un bisogno, nulla lo tratteneva. Vedendo che i rifugiati dell’etnia Kuku non avevano libri di preghiera nella loro lingua iniziò per loro la traduzione dei libri liturgici. A metà 2005 si trasferì a Lomin, in terra Kuku dove era più facile assolvere a questo compito così impegnativo. E qui consumò le sue ultime energie.
Scrisse in una lettera del marzo 2006: “Con la Quaresima è arrivata la prima pioggia che ci fa respirare e rivivere. Nello stesso tempo soffro per quelle 1.500 persone che sono fuggite da zone poco sicure e hanno trovato rifugio nella nostra parrocchia. C’è qualcuno che la pace non la vuole proprio. Il caldo è stato veramente forte, tanto che pensavo di non farcela (anche a causa delle medicine che devo prendere per sopravvivere). Tante volte ho pensato di venire a svernare in Italia, ma poi ho cacciato il pensiero come una tentazione. Ti mando alcune foto dei bambini dell’asilo. Sono più di 250. Nella prima aula sono 97. Le altre sono foto del Collegio Comboni con 450 alunni. Senza esagerare, è il non plus ultra del Sudan meridionale. Le adozioni a distanza sono un aiuto grandissimo per noi. Grazie alla buona volontà e carità dei benefattori i bambini possono istruirsi e mangiare. Ora vorremmo aiutare i nostri catechisti e le piccole comunità a costruirsi una piccola cappella e una scuoletta con tre aule: una per l’asilo, le altre due per le elementari. Non abbiamo i grandi aiuti delle organizzazioni internazionali ma quelli piccoli-grandi di voi miei amici fedelissimi che mi seguite da sempre nel mio lavoro missionario. Gesù risorto, che celebriamo a Pasqua e ogni giorno nell’Eucaristia, vi ricompensi con la sua pace e gioia. Mi affido e vi affido a Maria nostra madre nelle mie preghiere”.
Quando scriveva queste cose mancavano due mesi alla morte. Intanto, per riposarsi un po’, chiese di andare nella missione di Ombaci in Uganda (Lomin è al confine tra Sudan e Uganda) dove lo colse una forte malaria perniciosa.
La testimonianza di P. Pierli
P. Francesco Pierli, che ha conosciuto a fondo P. Giovanni, ci invia la seguente testimonianza: “In P. Giovanni Ferrazin vorrei sottolineare tre punti che sono della massima importanza per un missionario dei nostri tempi: primo, i rapporti con gli agenti pastorali indigeni. È uno degli aspetti più delicati per i missionari, perché, quando i dirigenti pastorali africani prendono le opere iniziate dai bianchi, scoppia sempre una crisi. Il clero indigeno manca di esperienza e non ha le disponibilità finanziarie che avevano invece i missionari. A questo punto può succedere uno scambio di accuse, un rimpallarsi delle colpe e la tensione aumenta. P. Giovanni era uno che univa, che non si lasciava coinvolgere nello scambio di colpe. Per lui la cosa più grande era la fraternità e la solidarietà tra mondo indigeno e mondo missionario. Ciò gli derivava dal suo grande senso di umanità e di umiltà. E gli africani non avevano paura di lui, non si tenevano “alla larga”. Partecipava alle loro feste, condivideva il denaro che arrivava dall’estero e anche il suo tempo. Questo è un aspetto grande per un missionario.
Secondo: il coraggio di cambiare missione dall’Uganda al Sudan. A volte sembra che cambiare missione sia visto come una specie di tradimento. Ferrazin aveva chiaro due cose: innanzitutto che la Chiesa in Uganda era ben sviluppata con numerosi e buoni sacerdoti locali, per cui si è reso disponibile ad andare dove la Chiesa era più fragile e l’evangelizzazione più incerta. Quindi ha fatto l’opzione per il Sudan a circa 60 anni, quando ormai non si ha più voglia di cambiare o ci sono difficoltà per la lingua. Ha saputo andare in una situazione di insicurezza, di isolamento e di povertà anche se la sua salute era ormai compromessa. La sua attenzione è sempre stata rivolta alla prima evangelizzazione. Questo, date le sue condizioni di salute e la sua età, è stato un gesto eroico.
Terzo: malattia e missione. P. Giovanni era consapevole della sua grave malattia ma l’ha interpretata come croce che salva. Quindi, se da una parte il suo male gli toglieva l’efficienza, dall’altra gli aumentava l’essere assimilato a Cristo che si offre per la salvezza degli altri (la malattia gli toglieva la dimensione dell’apostolato, però gli aumentava la dimensione del discepolato). Ha messo la cura pastorale, almeno come presenza tra il popolo di Lomin dove mancava il parroco, al di sopra della sua salute”.
Come un chicco di grano
Il 31 luglio 1985 P. Giovanni aveva scritto al suo provinciale: “Caro P. Mazzolari, pace e bene dal Signore Gesù. Ti scrivo questa lettera per dirti che desidero essere sepolto nel posto dove mi trovo a lavorare quando il Signore mi chiamerà. Grazie. Memento ad invicem”. Poche parole che esprimono tuttavia il cuore del vero missionario che vuole diventare chicco di grano che viene sepolto nella terra dove ha sudato e sofferto per portare frutto.
Ad Ombaci, invece di migliorare, cominciò a peggiorare. I confratelli lo portarono all’ospedale di Angal, ma nel trasporto fu colto da infarto. A nulla valsero le attente e qualificate cure del personale sanitario e delle suore. Morì tra le loro braccia il 1° giugno 2006.
Il giorno in cui aveva lasciato Lomin, aveva detto con gioia e soddisfazione: “Sono veramente felice e contento. Ho completato la traduzione anche dell’anno liturgico C e il messale festivo”. Il Signore aveva aspettato a chiamarlo in un momento di grande soddisfazione per lui. Il frutto era maturo e il Signore lo colse.
Il funerale si è svolto nella chiesa parrocchiale di Lomin, il 3 giugno 2006. Durante l’omelia, P. Luciano Perina che ha condiviso con lui gli ultimi quattro anni di vita, ricordando qualche episodio accaduto, ha detto: “La sua è stata una vita tutta spesa per il bene degli altri. Mi ha sempre meravigliato la sua costante serenità, il suo sorriso buono e rasserenante, la sua voglia di scherzare, la sua capacità di sdrammatizzare, il suo costante ottimismo. Il lavoro dei suoi ultimi anni è stato un lavoro da certosino, lungo, paziente, prezioso. Oggi in tutte le chiese della diocesi la Parola di Dio viene proclamata nella lingua locale, grazie al suo lavoro paziente e alla sua dedizione costante”.
P. Giovanni Ferrazin, uomo mite, sempre sorridente, di intensa preghiera e di grande carità verso gli africani, ci lascia l’esempio di un Comboniano autentico, attaccato alla sua vocazione che ha vissuto in pienezza logorando se stesso fino a morire in un’età relativamente giovane. La sua salma riposa nel cimitero di Lomin, nel Sudan meridionale.
(P. Lorenzo Gaiga, mccj)
Da Mccj Bulletin n. 232 suppl. In Memoriam, ottobre 2006, pp. 75-84