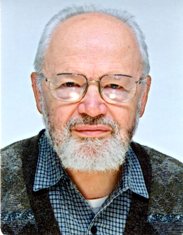Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
In Pace Christi
Galimberti Enrico
P. Enrico Galimberti nacque a Seregno da Teresa e Giovanni Galimberti il 13 settembre del 1927. A 13 anni, dopo aver concluso il primo anno di scuola commerciale, prese la via del seminario.
Dopo questa iniziale scelta del seminario diocesano, nacque in lui la vocazione missionaria. Ne parlò con il padre che, in un primo momento, si oppose. Enrico allora smise di mangiare fino a quando non ottenne l’autorizzazione del padre e poté proseguire gli studi nell’Istituto Comboniano.
Il 7 giugno 1952 fu ordinato sacerdote dal Beato Card. Ildefonso Schuster. Nel 1955 venne destinato a Bologna, per sostituire P. Romeo Panciroli, direttore dell’allora Editrice Nigrizia, diventata poi EMI (Editrice Missionaria Italiana), e di “Amici dei Lebbrosi”. In questo incarico, che avrebbe dovuto durare qualche mese, P. Enrico rimase per dieci anni.
Amici dei Lebbrosi
P. Enrico è considerato il fondatore dell’associazione ‘Amici dei Lebbrosi’. In un’intervista con P. Lorenzo Gaiga, dice: “Eravamo nel 1955: una delle cose più belle di quel periodo fu scoprire un libro di Raoul Follereau, uno sconosciuto in Italia, a quei tempi. Il titolo era Si le Christ frappe a votre porte. Lo ordinai a Parigi e lo divorai in una notte. Lo feci leggere a P. Enrico Bartolucci, allora direttore di Nigrizia, e a P. Raffaele Gagliardi, direttore del Piemme, che in pochi giorni ne fece una stupenda traduzione. Il libro ebbe un grande successo e molte edizioni in altre lingue. Ma la cosa non finì lì, anzi lì è cominciata. Nel dicembre 1957 due sconosciuti suonarono alla mia porta e mi mostrarono una lettera di Raoul Follereau che li mandava a parlare con me per cercare di fare qualcosa a favore dei malati di lebbra. Erano il dottor Giampietro Sini e il geometra Luciano Elmi. Decidemmo di fare un foglio ciclostilato da distribuire nelle parrocchie di Bologna in occasione della ‘Giornata mondiale dei malati di lebbra’ del gennaio 1958. Agli inizi di febbraio, cominciammo a ricevere le prime adesioni. È nata così l’associazione ‘Amici dei Lebbrosi’. Ci riunivamo nella libreria Pavoniana dei comboniani, prima sede dell’associazione che, intanto, si diffondeva in altre città come Firenze, Roma, Bari. Nel 1962 passammo dal foglio ciclostilato ad un giornale. La lotta contro la lebbra è stata dura, ma ha riportato belle vittorie. Ora, però, ci sono altre lebbre da sconfiggere: l’associazione, che oggi si chiama ‘Amici di Raoul Follerau’, lotta anche per quelle”.
In Brasile
Nel 1965, incontrando il Superiore Generale a Verona, P. Enrico gli espresse il desiderio di andare in missione. “Conosco solo il francese, quindi, sarei pronto per il Togo, il Burundi o il Congo”, e invece fu destinato al Brasile.
Così, il 7 dicembre dello stesso anno, partì per il Brasile dove poi è rimasto per il resto della sua vita: sette anni e mezzo ad Agua Doce, undici anni (a due riprese) a Taguatinga, sei anni a São Paulo, dieci a Ecoporanga e, dal febbraio del 1999, a São José do Rio Preto. In questi anni ha costruito 38 chiese, un ospedale, un ricovero per anziani e la sede delle riviste comboniane in Brasile.
Le prime due missioni
Ad Agua Doce (1966-1973) costruì e ristrutturò molte chiese e cappelle, costruì un ospedale e la casa per il medico, mentre visitava regolarmente, in media ogni quaranta giorni, ben ventisette comunità servendosi di jeep, mulo o cavallo. Nel 1973 fu destinato a Taguatinga, città satellite della capitale Brasilia. Per due anni celebrò le funzioni in un garage, poi con l’aumentare dei fedeli, si passò alla baracca che usava come abitazione e che veniva utilizzata anche come deposito del legname di recupero; infine si arrivò alla costruzione di una chiesa vera e propria. E più tardi, alla costruzione di due grandi chiese che formavano inizialmente una sola parrocchia di centomila abitanti. Alla sua partenza le comunità erano più numerose e le parrocchie di “soli” 30.000 abitanti.
Nel 1976 fu destinato a São Paulo, essendo stato eletto economo provinciale. Viaggiò molto per seguire le varie comunità, fino al 1982. In quel periodo, dopo la desistenza di P. Manuel de Oliveira Rouxinol, assunse anche la direzione della rivista “Sem Fronteiras” con P. Ubaldo Steri. Poi fu rimandato a Taguatinga dove per cinque anni rimase praticamente da solo a gestire la pastorale.
Ecoporanga
Nel 1989 fu destinato a Ecoporanga dove, assieme a P. Carlo Furbetta, visse gli anni (circa dieci) delle tensioni sociali relative ai senza terra e al grosso problema del latifondismo. Secondo P. Enrico, il problema più difficile da affrontare, in Brasile, fu quello di “procurare un pezzo di terra ai senza terra, perché si trattava di ingaggiare una lotta serrata contro i latifondisti. È stata dura, durissima, qualcuno ci ha lasciato la vita come il nostro confratello P. Lele Ramin. Il latifondismo ha spinto la gente verso la città, aumentando il numero dei disoccupati nelle favelas, senza strutture igieniche, senza prospettive, creando disperazione e molto spesso criminalità”.
A Ecoporanga, P. Enrico, sempre in collaborazione con P. Furbetta, seguì quaranta comunità, che alla sua partenza erano diventate cinquantacinque. Costruì altre chiese, una delle quali dedicata a San Daniele Comboni e una alla Madonna di Santa Valeria (venerata nel suo paese natale), varie scuole e un ricovero per anziani con quaranta posti. Nel 2000 era presente alla consegna della parrocchia di Ecoporanga al clero locale. “Questa è la vita del missionario: lavora, impianta le opere, le consegna agli altri e va a iniziarne delle altre”, furono le sue parole.
São José do Rio Preto
Così P. Enrico ripartì per una nuova destinazione: São José do Rio Preto, nello stato di São Paulo, come coordinatore della comunità dei missionari anziani ma autosufficienti. Nel frattempo, era anche parroco della parrocchia di São Pedro e São Paulo, con una chiesa da finire, in costruzione da sette anni, e una chiesa troppo piccola per le funzioni religiose.
Oltre che amministratore parrocchiale, era anche tesoriere (“senza tesoro”, come amava ripetere) dell’opera sociale São Judas Tadeu, una scuola professionale per il recupero dei ragazzi di strada, che cercava di offrire loro un’educazione e un insegnamento professionale per evitare che diventassero emarginati o criminali.
P. Enrico, nel 2006, scriveva a P. Piergiorgio Prandina: “Il giorno 18 dicembre 2005 abbiamo avuto una grande gioia; 65 adolescenti, che hanno frequentato in questi anni la nostra scuola professionale, hanno terminato il corso: 28 segretari, 9 falegnami, 12 fabbri e 16 tipografi. Così 65 nuove leve sono state immesse nel mondo del lavoro e salvate dalla strada”.
In Italia
Rientrato in Italia per cure, nel dicembre 2009, è stato ricoverato a Milano, nel Centro Ammalati. P. Lino Spezia lo ricorda così: “P. Enrico in questi tempi ci ha parlato in modo particolare di speranza e di vita nuova, quando tutte le evidenze erano contrarie. Se l’angoscia paralizza, la fiducia rimette in cammino, così di fronte alle prime avvisaglie della malattia, penso che P. Enrico avesse compreso bene la natura del suo male, ma ha voluto fare la scelta della missione come segno di amore e di fedeltà a un popolo e a una comunità cristiana, per completare il suo compito, vivendo in pienezza ogni istante che gli era concesso. Era rientrato in Italia poco prima di Natale dell’anno scorso, sapendo a che cosa andava incontro e poi, appena possibile, anche qui ha ripreso a lavorare al computer, con entusiasmo fino all’ultimo momento”.
P. Enrico è morto a Milano il 14 settembre 2010.
Testimonianze
P. Lino Spezia, nell’omelia per il funerale, svoltosi a Milano, ha detto: “P. Enrico ci ha testimoniato tre forze: a) la forza di sfidare la malattia: non ha mai cercato consolazione né si è mai ripiegato su se stesso, anzi! Ha cercato sempre di essere autosufficiente spingendo da solo la carrozzina e accettando solo alla fine che qualcuno lo aiutasse. Ha vissuto il suo impegno quotidiano mettendo tutto se stesso nello scrivere e-mail o preparando parte del giornalino per la sua parrocchia in Brasile; b) la forza dell’amicizia che ha sempre coltivato e vissuto convinto che essa ci mantiene nel cammino dell’impegno contro chi semina qualunquismo o superficialità; c) la forza che fa amare le cose belle e che rendono la vita bella da vivere e da gustare come l’attenzione verso gli altri, il suo amore per il canto e la passione per i bei film, soprattutto quelli di Don Camillo e Peppone, e per le partite a carte alla sera, in Brasile come qui.
Ci ha lasciato un segno straordinario e bello: la testimonianza dell’importanza della preghiera comunitaria dalla quale traeva forza e sostegno. Voleva assolutamente essere presente e la partecipazione era vivere in modo attivo e missionario la fede con cui viveva e con cui coniugava la vita segnata dal male. È per questo che P. Enrico ha saputo infondere, nelle persone che ha incontrato in Brasile, serenità, dignità e fiducia in se stessi”.
P. Angelo Carlo Zen, ricordando P. Enrico, ha posto l’accento sulla sua fedeltà alla vocazione, prima di tutto, alla preghiera e agli orari di comunità. Anche se aveva un carattere forte e impulsivo, sapeva riconoscere i suoi errori e chiedere scusa. Nonostante, a volte, potesse apparire un po’ chiuso e burbero, aveva un cuore d’oro ed era gioviale: ci ha lasciato ben ventidue libretti di barzellette, non solo “per far ridere ma per farci riflettere”. Negli ultimi anni, aveva imparato bene a lavorare al computer e se ne serviva spesso per mandare messaggi di carattere religioso. Sapeva coltivare forti amicizie.
P. Pietro Bracelli: “Sono stato suo compagno nell’amministrazione della provincia di São Paulo e l’ho seguito negli ultimi giorni della malattia a Milano. Nella Messa del funerale a Seregno, il 16 settembre, sono stato invitato a tenere ‘l’orazione funebre’. È stato un discorso fatto nel segno dell’amicizia e della missionarietà: ‘Anche tu, come buon missionario, sei partito e ritornato tante volte in questi quarantacinque anni… P. Enrico aveva fatto suo quel senso della fede che caratterizza la vita di tutti noi. Più che alle parole, dava valore all’atteggiamento interiore che lo orientava in ogni circostanza. Le sue caratteristiche umane, sia nei limiti sia nelle qualità positive prendevano una conformazione di certezza e fiducia in Dio cui sempre si riferiva, con la preghiera personale, liturgica e comunitaria. Sulla vocazione alla missione non ha mai titubato. Era certo della chiamata… e per questo la sua fedeltà era conosciuta da tutti. Nella sua vita pratica questa fedeltà si traduceva in precisione negli orari e nelle forme di preghiera, nella perseveranza in ciò che si era stabilito, in esigenza di fronte ai doveri, prima con se stesso, poi chiedendo lo stesso anche agli altri. La vita comunitaria, per lui, oltre che sull’amore fraterno, era basata anche sulla fedeltà a tutto ciò che la missione richiedeva. Nella malattia, negli ultimissimi giorni, ho potuto notare un distacco vero da questa vita terrena. Viveva in silenzio l’avvicinarsi del grande giorno. Poco a poco si staccava dalle cose. Due giorni prima di morire, alla presenza di molti familiari, volle ringraziare tutti, per tutto. Sentiva di dovere molto ai confratelli, a tutte le persone della sua famiglia e soprattutto ai benefattori. La chiamata alla missione “ad gentes”, P. Enrico l’ha vissuta nella totale disponibilità, rimanendo nello stesso posto per periodi abbastanza lunghi, per servire meglio la gente. Per sua personale convinzione e per disponibilità ai programmi della provincia, ha sempre lavorato in ambienti poveri. I molti soldi amministrati non sono mai stati l’occasione per spese personali non necessarie. Erano aiuti per la gente povera. Nei sei anni in cui è stato economo provinciale, con me, si è dimostrato amministratore competente, fedele e trasparente. Negli anni difficili dei cambiamenti post-conciliari, P. Enrico continuava a sentirsi sicuro con l’ecclesiologia e la teologia in cui era stato educato. Sentiva il contrasto, si sforzava di capire ma allo stesso tempo non perdeva la tranquillità interiore, trovava nell’esempio dei santi e nello schema liturgico del Breviario e della Messa il cibo spirituale necessario per la missione. Adesso, possiamo affermare: missione compiuta. 83 anni il 13 settembre 2010. All’ora di pranzo, sul suo letto, ha voluto tagliare la torta per i confratelli. Alla sera ha avuto ancora la forza di dire una preghiera con me e di fare da solo il segno della croce. È stato l’ultimo gesto di un figlio che si sentiva accolto dal Padre. P. Enrico è il primo comboniano che muore il 14 settembre, festa della Santa Croce. Sarà, anche questo, un modo singolare di ricordarlo”.
Da Mccj Bulletin n. 247 suppl. In Memoriam, gennaio 2011, pp. 45-51.