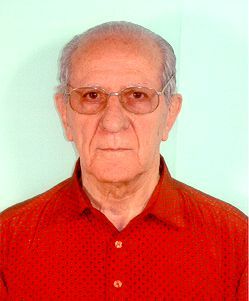Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
In Pace Christi
Mariani Giuseppe
Un vero gentiluomo, intelligente e responsabile, capace di coltivare grandi amicizie. Ha avuto una rara capacità di trattare con affetto, rispetto e dignità i confratelli e il clero diocesano. Ha aiutato migliaia di bambini e di giovani nella loro formazione e molte famiglie bisognose”. (P. Alberto Doneda)
La formazione
P. Giuseppe Mariani era nato a Seregno, provincia di Milano, il 17 giugno 1930. Durante le vacanze estive e le passeggiate sui monti con il parroco e gli amici dell’oratorio conobbe il comboniano P. Gaetano Semini, animatore vocazionale, con il quale entrò in amicizia. Furono proprio le conversazioni con P. Gaetano a convincerlo a fare il passo decisivo, cioè ad entrare nel seminario comboniano alla fine del 1944, all’età di 14 anni. I suoi genitori, profondamente religiosi, non ostacolarono la vocazione dell’unico maschio dei loro cinque figli. La prima tappa fu Crema, poi Brescia. Emise i primi voti a Firenze nel 1948 e il 26 maggio 1956 fu ordinato sacerdote dall’arcivescovo di Milano, il cardinale Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI.
Prima di ricevere la destinazione per la missione, fece una breve esperienza in Spagna, a San Sebastián, come direttore di Aguiluchos. Subito dopo, anche se il suo desiderio era partire per l’Africa, i superiori decisero di affidargli un incarico da tutt’altra parte: in Ecuador, nella città di Esmeraldas. Partì da Seregno l’11 gennaio 1959: “Mi ricordo che nevicava. In pullman, catene alle ruote, ero arrivato al porto di Genova accompagnato dalla mia famiglia e da un gruppo di giovani di Santa Valeria. Ricordo la malinconia del saluto, affacciato al parapetto della nave che prendeva il largo con molta lentezza, mentre correndo sul molo gli amici quasi la accompagnavano”.
A Esmeraldas, in Ecuador
P. Giuseppe trascorse i suoi primi ventidue anni come missionario a Esmeraldas, in Ecuador. Fu insegnante di latino presso l’Università laica “Luis Vargas Torres”, professore per tre anni del Collegio del Sacro Cuore, fondatore della Città dei Ragazzi, che diresse per otto anni, mentre assisteva il vescovo come Vicario generale (un ufficio che portò avanti sotto i tre vescovi di Esmeraldas) e dal 1978 al 1981 fu incaricato dei mezzi di comunicazione sociale.
Esmeraldas era il capoluogo di una provincia grande quanto la Lombardia, con un territorio solcato da molti fiumi e affacciato sull’Oceano Pacifico. Un’unica strada asfaltata permetteva di raggiungere la capitale, Quito; per il resto, bisognava familiarizzare con il “trasporto equino”, le canoe, che percorrevano corsi d’acqua spesso impetuosi, e altri mezzi di comunicazione dei più impensati. In un clima molto caldo e umido e in condizioni ambientali certo non facili, vivevano allora circa 120.000 abitanti, con una notevole prevalenza di neri. Solo qualche tribù, come quella dei Cayapas, nativi della regione di Esmeraldas, conservava ancora il suo aspetto primitivo e le antiche usanze.
Le etnie presenti nella città erano accomunate da un’estrema povertà e, di conseguenza, da una situazione di arretratezza. Erano i primi anni della missione comboniana in Ecuador, caratterizzati, riguardo alla prefettura di Esmeraldas, dalla necessità di rievangelizzare una società nella quale la cura pastorale era stata abbandonata da troppo tempo. Perciò la responsabilità iniziale fu la cura religiosa dei pueblos vicini a Esmeraldas, raggiungibili con molta difficoltà, a cavallo e guadando fiumi e torrenti dalle forti correnti. Fu in uno di questi trasferimenti che la missione perse uno dei suoi membri e uno degli amici più cari di P. Giuseppe, Fr. Giovanni Piacquadio, morto mentre stava attraversando un fiume: la canoa si capovolse e Fr. Giovanni cadde sbattendo la testa su una roccia. Il corpo fu ritrovato solo tre giorni dopo. Fu il primo Comboniano a perdere la vita in Ecuador.
I giovani
Nel 1961 il vescovo Angelo Barbisotti incaricò P. Giuseppe di seguire i ragazzi che si trovavano nella Casa correzionale per minori di Esmeraldas, dove una trentina di giovani con precedenti penali venivano tenuti in uno stato veramente deplorevole. Lo stesso P. Giuseppe ce ne offre una desolante descrizione. “I locali dove vivono, da noi non sarebbero considerati nemmeno come stalla. Sono vestiti di stracci. Ho dovuto comprare quasi tutti gli utensili da cucina oltre che sedie e lenzuola. Dopo tre giorni mi mancava tutto di nuovo: i ragazzi stessi me li avevano rubati e venduti. Adesso sto vedendo come far fare loro una camicia e un paio di pantaloni decenti, perché almeno perdano la mania di prendere quelli che sono nelle vetrine o sulle bancarelle o stesi in riva al fiume ad asciugare. È un’opera enorme, quella che ci siamo sobbarcati e in più, abbiamo l’opposizione delle autorità. Quando il governo ha dato a monsignore la direzione di quest’opera sociale, in parlamento e sui giornali hanno detto contro di noi tutto quello che si poteva dire”.
La Ciudad de los Muchachos
Il lavoro missionario di P. Giuseppe, dopo l’esperienza con i ragazzi del riformatorio, continuò nel tentativo di formare delle generazioni che, affrancate il più possibile dalla disoccupazione e dalla malattia e dotate di una più consistente cultura, potessero rappresentare un elemento di speranza per la derelitta comunità di Esmeraldas. Sotto questi auspici nacque, nell’agosto del 1962, la “Ciudad de los Muchachos”. L’intento era dare una casa e il calore umano di una famiglia ai numerosi ragazzi che vagabondavano per le strade della città senza nessuno che si occupasse di loro. L’idea era originale: i ragazzi erano divisi in gruppi di non più di dieci e abitavano insieme in una casa indipendente con un Fratello comboniano o un aiutante laico che fungeva da padre in quella che, con lo stringersi dei rapporti e l’instaurarsi di regole di convivenza, diventava una vera e propria famiglia. Lo studio e il lavoro erano le due attività con le quali si cercava di trasformare giorno per giorno questi giovani. “La Ciudad de los Muchachos sorse a quattro chilometri da Esmeraldas, su cento ettari di terreno. Nel settore residenziale, oltre a un edificio destinato alla direzione e amministrazione, sono state costruite otto case per i ragazzi. Nel settore industriale funzionano le officine di meccanica e di falegnameria con un’area di 300 metri quadrati ciascuna e tre aule destinate alla sartoria, tipografia e calzoleria”. Vi si praticava anche l’agricoltura e l’allevamento.
P. Giuseppe, ormai meglio conosciuto come P. Pino, amò molto quest’opera, come testimoniano le parole con le quali salutava gli amici, poco prima di ripartire per Esmeraldas, dopo un breve periodo di riposo a Seregno nell’estate del 1967. “Torno alla mia ‘Città dei ragazzi’, dove ho imparato ad amare tanti poveri bambini infelici che non hanno mai avuto niente nella vita e che, per lo più, non hanno nessuno. I bambini che non hanno nessuno, sono figli di tutti; perciò questi ragazzi sono anche figli miei e figli anche di ciascuno di voi”.
Pari all’intensità del suo attaccamento alla “Città dei ragazzi”, fu il suo dispiacere nel vederne la chiusura in tempi abbastanza recenti, dopo che i Comboniani da diversi anni avevano affidato il centro alle autorità amministrative ed ecclesiastiche locali. Quando questo era avvenuto, P. Giuseppe non si era sentito defraudato, convinto che l’opera avrebbe continuato a vivere e a svilupparsi anche in altre mani.
Il Villaggio del fanciullo
P. Giuseppe si dedicò anche ad un altro progetto, questa volta rivolto all’infanzia. L’Istituto voleva creare un centro dove raccogliere i piccoli orfani e i bambini abbandonati. Nacque così il “Villaggio del fanciullo”, che arrivò ad accogliere 110 bambini bisognosi. L’orgoglio di P. Giuseppe erano le centinaia di fanciulli che in trent’anni di attività ne sono usciti indipendenti, diversi, con un diploma di scuola superiore e – una ventina, soprattutto donne – con una laurea.
Ma l’inesauribile P. Giuseppe non si fermò qui, anzi, contemporaneamente partecipò ad un’iniziativa portata avanti dai missionari italiani e spagnoli tesa ad affrontare il grave problema della condizione dei diversamente abili, fisici e mentali, che in quelle zone vivevano reclusi in casa in quanto considerati dalle famiglie una maledizione. Fu quindi costruita e inaugurata nel 1978 una grande struttura dove questi bambini venivano accolti e curati: nasceva “l’Istituto di Educazione Speciale Giovanni Paolo II per bambini”. In tutta questa sua opera umanitaria a favore degli ecuadoregni di Esmeraldas, P. Giuseppe fu costantemente supportato dagli amici di Seregno, sua cittadina natale, che fecero sempre sentire al missionario non solo il loro appoggio morale e spirituale ma anche materiale nei momenti di maggior bisogno.
Motivi di incoraggiamento in un ambiente difficile
“Quando uno ritorna in missione per la seconda volta, sa che nel suo bagaglio non c’è più posto per la poesia, conoscendo ormai fin troppo bene la quantità e la qualità della prosa che l’aspetta. Però a dispetto di tutta questa prosa che ho già imparato a masticare religiosamente durante sette anni e che ora m’impedisce di sognare, vi assicuro che parto per la missione con lo stesso entusiasmo di quando m’imbarcai la prima volta”.
Infatti il buon rapporto creato con la gente della città e dei villaggi e il loro progressivo e continuo avvicinamento alla pratica religiosa, costituivano il prezioso carburante che permetteva a P. Giuseppe di continuare a lavorare con tanta speranza in questo ambiente difficile. Nel 1967 annotava con soddisfazione: “Le 68 comunioni registrate nel periodo pasquale del 1955, si sono trasformate attualmente in alcune centinaia di comunioni giornaliere. A Esmeraldas ci sono quattro parrocchie con 18 Messe festive che sono però insufficienti dato il notevole afflusso di fedeli. I battesimi poi non si contano”.
Nel 1973 P. Giuseppe ritornò in America Latina con un sostanzioso contributo che gli permise di realizzare un’emoteca con una buona scorta di sangue per garantire ai più poveri un pronto intervento nei casi di necessità. A questo proposito formò nella missione un gruppo di donatori che consentì un approvvigionamento costante di plasma al piccolo centro medico.
Situazione economica del paese
D’altra parte mai come in quel momento e in quel luogo c’era bisogno di un riferimento positivo sia dal punto di vista sociale che assistenziale, in considerazione delle gravi difficoltà in cui versava la popolazione e nelle quali i Comboniani si trovavano ad operare. Più volte nel corso degli anni P. Giuseppe sottolineò e descrisse la precarietà della situazione civile ed economica a Esmeraldas. “Le condizioni economiche sono molto gravi e così pure le condizioni morali. La famiglia è quella che ne fa soprattutto le spese. Sono pochissimi, infatti, i matrimoni civili celebrati e ancora meno numerosi quelli celebrati in chiesa. Il problema più grosso e più generalizzato è sempre la povertà galoppante che ha tutte le carte in regola per essere promossa a squallida miseria. Le conseguenze sono sempre le stesse: violenza, fame, malattie che colpiscono i settori più deboli e indifesi. Dati pubblicati dall’Unicef denunciano che il 46% della popolazione dell’Ecuador vive con un dollaro e mezzo al giorno; l’inflazione ha superato il 60%. La croce più pesante è sempre quella degli ammalati, senza medicine nelle farmacie o senza soldi per comprarle. Nell’anno del Giubileo ci sarà poco da giubilare”.
In Italia e poi in Colombia
Il periodo di permanenza in Ecuador di P. Giuseppe non fu però continuativo. Nel 1984 l’Istituto lo richiamò in Italia per affidargli un incarico presso l’EMI, la casa editrice bolognese che costituisce la cooperativa per tutti gli istituti missionari presenti in Italia. Rimase in patria fino al 1992, quando le esigenze pastorali lo riporteranno nuovamente in America Latina.
Questa volta la destinazione sarà diversa, non più l’Ecuador ma la Colombia (a quel tempo, formavano un’unica provincia), nella città di Cali, una delle metropoli colombiane – la terza in ordine di grandezza – con una popolazione di due milioni e mezzo di abitanti. Situata a mille metri di altitudine, è il maggiore centro industriale, commerciale e agricolo della Colombia sud-occidentale. E una delle città con il più alto tasso di criminalità al mondo, dov’è nato il famoso “Cartello di Cali” dei grandi narcotrafficanti e dove la legge fatica di più ad imporsi. Anche in questo caso, P. Giuseppe puntualmente ci offre un preciso e documentato rapporto sulle caratteristiche soprattutto sociali del luogo in cui si trova. “È un lavoro non molto facile, svolto in un mondo di forti contraddizioni: una religiosità radicata, vissuta in un ambiente sociale fortemente violento. Secondo dati ufficiali, ripetuti da giornali e telegiornali i questi giorni, alla fine di ottobre 1995 i morti di morte violenta superano i 25.000. Il numero dei sequestrati si aggira sui 4000. A Cali, da gennaio a giugno ci sono state 1232 morti violente e 271 sequestri di persona, 45 al mese”.
Nuovamente in Ecuador
Alla fine del 1995, P. Giuseppe, all’età di 66 anni, lasciava la Colombia per tornare nella mai dimenticata Esmeraldas, dove affronterà, come prima, il durissimo periodo della crisi economica ecuadoregna. Superata la soglia dell’anno 2000, appare soddisfatto del lavoro spirituale effettuato e dei risultati ottenuti. “Il giorno dodici di questo mese (gennaio 2000) abbiamo celebrato una grande festa per l’ordinazione di quattro diaconi, cosa mai vista in Esmeraldas. Abbiamo diciotto seminaristi nel Seminario Maggiore; aumentano le vocazioni religiose; sono moltissimi i gruppi giovanili con grande vitalità, gruppi di preghiera, ecc. Festa solenne per l’ordinazione sacerdotale di tre diaconi di tre razze differenti: uno bianco, uno nero e uno dell’etnia cayapa. Ogni ordinazione sacerdotale è sempre festa grande per la nostra Chiesa”.
Le riflessioni di P. Giuseppe su quello che è stato il suo impegno missionario, tracciano un profilo completo e profondo non solo della sua vicenda personale ma del senso e dell’attualità – come lui ritiene – dell’opera dei missionari, soprattutto presso le popolazioni più afflitte dalla miseria e dalla mancanza dei più elementari bisogni, come il cibo. “Purtroppo è vergognosamente vero. Gli unici a denunciare questa vergogna sono rimasti i missionari, per mantenere svegli organismi internazionali, governi, parlamenti e opinione pubblica, perché essi, i missionari, sono stati e continuano ad essere, di questa tragedia di enormi proporzioni, i testimoni oculari di quelle scene raccapriccianti, di quei volti di adulti e di bambini distrutti dalla fame che pochi giorni, o poche ore, dopo essere stati filmati da tante televisioni, sono realmente morti di fame. Il missionario, oggi, oltre a saper ascoltare quello che il Vangelo gli dice, deve continuare a vedere la degradazione inumana cui sono condannati i poveri, i prediletti del Vangelo, e ascoltare tutto quello che i poveri gli dicono, per dare una risposta lucida, coerente, generosa e audace come quella che Cristo darebbe a ciascuno di loro, così che tutti abbiano una vita degna di essere vissuta”.
Radio Esmeraldas
Non solo una riflessione, dunque, ma anche una denuncia e un manifesto in favore degli umili e degli indigenti, che si trasformò, nell’inesauribile dinamismo di P. Giuseppe, in un’altra iniziativa, tesa appunto a dare una voce concreta a questa massa di disperati: Radio Esmeraldas. L’idea di una radio del vicariato nacque dalla notevole esperienza giornalistica del vescovo di Esmeraldas, Mons. Enrico Bartolucci, convinto assertore della forza comunicativa della radio. Oggi la rinominata “Antena Libre” è fra le radio locali più ascoltate di Esmeraldas. L’emittente non ha scopi commerciali e non accetta pubblicità contraria a un’etica basata su solidi valori cui fa riferimento, fra cui il rispetto per l’ambiente. I programmi da sempre sono basati sul lavoro di molti collaboratori sparsi nei quartieri di Esmeraldas e nei villaggi della provincia che inviano i propri servizi, essenzialmente di carattere sociale e di cronaca, alla redazione centrale.
Uno dei programmi più noti è “El Campesino”, durante il quale la radio trasmette esperienze, testimonianze e opinioni raccolte fra gli agricoltori. Altre trasmissioni molto seguite sono quelle realizzate per favorire l’educazione scolastica dei giovani in collaborazione con l’associazione dei genitori della provincia di Esmeraldas, e quelle che si occupano dei problemi della salute, dove si divulgano informazioni fondamentali per affrontare malattie ancora diffuse in quella zona come la febbre gialla, la malaria, il colera e altre malattie la cui origine è dovuta all’uso di acqua non potabile che è un bene cui attinge poco più della metà della popolazione ecuadoregna.
Il ritorno in Italia
Negli anni successivi i rientri a Seregno si fecero più frequenti, compresi quelli per i festeggiamenti del 40° di sacerdozio nel 1997 e del 50° nel maggio del 2006. Poi, nel 2010, P. Giuseppe rientrò definitivamente in Italia e fu mandato per cure al Centro Ambrosoli di Milano, dove è deceduto l’8 agosto 2012.
Da Mccj Bulletin n. 254 suppl. In Memoriam, gennaio 2013, pp. 40-49.