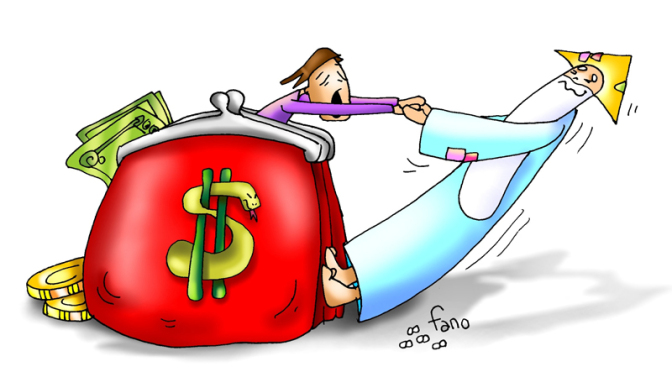Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
Le letture di questa domenica possono risultare di difficile comprensione. Nella prima lettura Amos, il profeta pastore e contadino del VIII secolo, prende la difesa dell’indigente e minaccia la vendetta di Dio contro quelli che “calpestano il povero” (Amos 8,4-7). Un monito quanto mai attuale. Ma nel Vangelo Gesù racconta una parabola in cui sembra lodare un amministratore disonesto. Si tratta di una delle più discusse parabole del Vangelo. In realtà, quello che si vuole mettere in risalto è la prontezza e scaltrezza di questo amministratore. Sono queste qualità che Gesù propone ai “figli della luce”. Per questo la parabola è chiamata anche dell’“amministratore sagace”. (...)
Amministratori risoluti e scaltri
“Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta”.
Luca 16,1-13
Le letture di questa domenica possono risultare di difficile comprensione. Nella prima lettura Amos, il profeta pastore e contadino del VIII secolo, prende la difesa dell’indigente e minaccia la vendetta di Dio contro quelli che “calpestano il povero” (Amos 8,4-7). Un monito quanto mai attuale. Ma nel Vangelo Gesù racconta una parabola in cui sembra lodare un amministratore disonesto. Si tratta di una delle più discusse parabole del Vangelo. In realtà, quello che si vuole mettere in risalto è la prontezza e scaltrezza di questo amministratore. Sono queste qualità che Gesù propone ai “figli della luce”. Per questo la parabola è chiamata anche dell’“amministratore sagace”.
Amministratori, non possidenti!
Trascureremo gli aspetti esegetici più problematici per focalizzarci sul messaggio principale. La parola chiave è amministratore. I termini amministratore /amministrazione /amministrare (in greco oikonomos, oikonomia, oikonomeō) appaiono 7 volte nel nostro testo. Non si tratta di una terminologia comune nel NT. Tuttavia, sebbene appaia poche volte, il concetto di “essere amministratori” (oikonomos) di ciò che Dio ci ha affidato è un tema ricorrente e fondamentale nella teologia neotestamentaria.
San Paolo ci dice: “Ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio” (1 Cor 4,1); e san Pietro: “Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio” (1 Pt 4,10). Non pensiamo solo alle grazie spirituali, ma anche ai doni naturali e ai beni materiali.
Qui veniamo al primo punto della nostra riflessione: noi siamo dei semplici ‘amministratori’, non possidenti. Cioè dobbiamo occuparci delle cose, dei beni, del denaro, come gestori. Anche i beni sono talenti affidati a noi. Non sono nostri e non possiamo trattenerli. Bisogna farli circolare e fruttificare con risolutezza e sagacità! Non a proprio tornaconto, ma al servizio degli altri e del Regno.
Oggi non c’è più nessun valore così universale come il denaro. La maggior parte del nostro tempo lo spendiamo a guadagnarci da vivere. Ma anche i soldi che ci siamo guadagnati con il sudore della fronte non sono nostri, da usare a nostro piacimento. Del resto, sappiamo che il sistema monetario attuale è ingiusto e iniquo. Non possiamo auto-assolverci dicendo che non ci possiamo fare nulla. Bisogna amministrarli con saggezza e tenendo conto di quanto dice Paolo VI nella Populorum Progressio: “La proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario” (n. 23).
I poveri, portieri del Paradiso!
La Parola di questa domenica ci parla anche dell’amicizia. Dei rapporti umani inquinati dall’avidità e dall’ingiustizia, denunciati dal profeta Amos. Dei rapporti di fratellanza con tutti gli uomini, che garantiscano pace e giustizia, come dice san Paolo nella seconda lettura: “perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio” (1 Timòteo 2,1-8). Ma è soprattutto Gesù, nel Vangelo odierno, a fare una proposta inattesa: “Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne”.
Ma allora i poveri saranno i portieri del paradiso? A quanto pare, sì. Secondo Matteo 25,11-12 Gesù sarà il Giudice che deciderà chi potrà entrare nel Regno dei cieli: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi conosco”. E similmente in Mt 7,22-23: “In quel giorno molti mi diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”.
Qui in Luca 16,9 invece suona un po’ diverso. Ecco come un catechista del Mozambico lo spiegava ai suoi catecumeni, secondo il racconto di un collega missionario.
Quando arriviamo alle porte del paradiso e bussiamo per poter entrare – sì, perché il paradiso ha delle porte, non vi entra chiunque! – spunta fuori san Pietro, a chi Gesù ha delegato le chiavi del Regno dei cieli, e chiederà
– “Chi sei?”
– “Sono il tal dei tali”.
Ma come farà Pietro a conoscere tutti quanti?! Molto semplice: Pietro griderà verso l’interno e chiederà:
– “Ehi, amici, c’è un tal dei tali che chiede di entrare; qualcuno lo conosce?”.
Allora qualcuno dirà (almeno così si spera):
– “Sì, lo conosco, mi ha dato tante volte da mangiare”. Ed un altro: – “Lo conosco anch’io, mi ha visitato tante volte quando ero malato”. Ed un altro ancora: – “Mi ha dato dei vestiti per coprirmi”.
Allora Pietro gli aprirà la porta:
– “Entra amico, sei dei nostri”!
Ma se dal di dentro scuotono la testa, dicendo che non lo conoscono, allora sì che saranno dei guai seri!
Sembra quindi che i poveri sono la giuria di san Pietro. Ecco perché Gesù raccomanda: “Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne”. Per questo non esita a darci “l’amministratore disonesto” come esempio di scaltrezza!
Si direbbe quasi che per entrare in paradiso servano delle raccomandazioni! Ma non a san Pietro, ma ai poveri, e qui sulla terra, prima che sia troppo tardi!
Manuel João Pereira Correia, mccj
Il dono
Gesù prosegue sul suo rivoluzionario cammino. Non offre solo una parabola ma poesia. Nel leggerlo ci presta un manuale. Come potremmo leggere Gesù stesso e i suoi paradossi contro-intuitivi? Come dovremmo leggere le sue scandalose ironie, potremmo quasi dire il suo senso dell’umorismo?
Nella parabola dell’amministratore di fatto Gesù elogia un uomo disonesto che ha gestito male le finanze del suo padrone. L’amministratore sta per essere cacciato, umiliato, diventare povero. Peggio ancora, sta mettendo in gioco la sua vita eterna. Perché allora Gesù elogia quest’uomo empio? Non è forse un imbroglione, un materialista? È questo che l’amministratore sembra avere fatto: ha alzato i prezzi di olio e grano ai debitori del suo padrone e ne ha ricavato dei profitti per sé. Ora è stato scoperto e capisce di non essere abbastanza forte per zappare la terra e di essere troppo orgoglioso per chiedere l’elemosina. Può risolvere la sua difficile situazione?
«So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua», dice. Quindi «chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”».
L’amministratore riduce i loro debiti, probabilmente dello stesso ammontare che aveva addebitato in eccesso per ricavarne un profitto. I debitori ora non sono solo contenti ma anche grati. Certamente lo aiuteranno e lo accoglieranno quando la notizia del suo licenziamento giungerà alle loro orecchie.
Quando il padrone viene a conoscenza dello stratagemma del suo amministratore si complimenta non per la sua onestà o il suo senso morale ma per la sua scaltrezza, la sua astuzia. L’amministratore ha perso il suo margine di profitto; è stato prudente e ha sacrificato la sua avidità ma ha guadagnato amicizia. Potrebbe essere un calcolo, ma può essere anche un barlume di pentimento. Quando il Padrone in questa vita, l’immagine terrena di Dio, verrà a sistemare la sua proprietà la troverà in ordine.
«Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare [quando il denaro perderà ogni significato alla nostra morte], essi vi accolgano nelle dimore eterne». Quindi Gesù dice che il denaro rubato, o il denaro sporco, utilizzato per suscitare amicizia, ovvero elargito, è denaro speso per ottenere il perdono. È un dono che ripristina l’equilibrio metafisico, quello che l’antico poema epico indiano Mahabharata definisce il dharma del mondo. Un dono che ci avvicina di più alla forza divina, vale a dire gli uni agli altri.
«Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera?». Rimediando ai propri errori con il denaro rubato, l’amministratore può iniziare a guardare al paradiso, all’orizzonte lontano. «Chi è fedele con il denaro è fedele anche verso Dio», ci ricorda Luca altrove. Siate fedeli nelle piccole cose e le grandi seguiranno.
Il padrone stesso, con la voce di Gesù, offre la fine di questa parabola meravigliosa, seppur inizialmente strana: «Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché […] i figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce». Per i figli e le figlie di questo mondo, per ognuno di noi, c’è speranza proprio perché la nostra astuzia ci può portare, quasi a nostra insaputa, a questa soglia di luce.
[Lila Azam Zanganeh – L’Osservatore Romano]
Non potete servire Dio e la ricchezza dice Gesù. Sembrerebbe invece che si possa fare piuttosto facilmente. Si serve Dio con una appartenenza formale, conveniente ed esibita, e si serve la ricchezza divenendone addirittura schiavi. Gesù porta alla luce del sole ciò che noi volentieri nascondiamo, il rapporto tra la vita cristiana e l’economia, un rapporto molto delicato, necessario, che se diventa un vincolo, un giogo, a poco a poco ci ruba l’anima, anestetizza la fede, e ci rende meno umani.
Quando san Francesco d’Assisi accettò il dono della sua vocazione, iniziò gettando i denari a terra davanti al padre. Un gesto straordinario, bellissimo, cristiano, che dovrebbe essere di tutti noi; egli spezzò un giogo, si liberò da una dipendenza, ricollocò il denaro al posto giusto, cioè nell’ordine dei mezzi.
Le ricchezze non sono un fine, ma uno strumento nelle mani degli uomini. Troppo spesso sono diventate uno strumento ingiusto perché l’uomo se ne è servito per dominare gli altri uomini e assoggettare interi popoli al controllo di alcune elite. Anche nella Chiesa la storia ci insegna che non pochi si sono allontanati dalla fede, perché hanno ricevuto una cattiva testimonianza nell’uso del denaro e delle ricchezze.
Gesù invita i suoi discepoli a essere “scaltri” nell’uso delle ricchezze. Chiede a ognuno di noi un diverso rapporto con le economie sia sul piano individuale che in quello comunitario. Il vangelo che per sua natura è anche una Buona Notizia sociale, ci ricorda che il corretto uso del denaro, della ricchezza, è quello di farne uno strumento di liberazione e di riconciliazione tra i popoli. Grazie a Dio il progresso culturale delle scienze economiche sta favorendo una sempre maggiore presa di coscienza, circa il bisogno di una più equa distribuzione delle ricchezze del pianeta. Alcune organizzazioni internazionali e alcune nazioni più sviluppate stanno lottando per nuovi equilibri sociali, ma la battaglia è ancora molto lunga e difficile.
Denaro sporco, potere, carriera, corruzione, lobbismo, clericalismo stanno dalla stessa parte e vanno in giro cercando chi divorare. Gesù ci dice che per vivere e annunciare il vangelo, liberi da ogni integralismo e da ogni dipendenza economica, bisogna con Lui “mettersi in cammino verso Gerusalemme”.
Non è solo importante, ma è necessario che ciascuno di noi salga a Gerusalemme, che non è la città delle banche centrali, ma la città che uccide i profeti, accogliendo la drammatica e magnifica proposta di vita del Signore, pronti a pagare un prezzo molto alto, con la serenità che il Suo giogo è dolce e il Suo carico leggero. Solo il Dio di Gesù Cristo ci insegna ad amare senza confini, senza limiti, senza integralismi e sempre gratuitamente.
[Francesco Pesce – L’Osservatore Romano]
La condivisione toglie alle ricchezze il ‘veleno’ di disonestà
Amos 8,4-7; Salmo 112; 1Timoteo 2,1-8; Luca 16,1-13
Riflessioni
L’evangelista Luca ha spesso un giudizio critico verso il denaro, le ricchezze, l’accumulazione dei beni… Vari brani del Vangelo di queste domeniche estive ne danno prova: le parabole del ricco stolto, l’amministratore infedele, il ricco epulone e altri. Per Luca, evangelista sensibile alla situazione dei poveri e dei meno abbienti, il denaro ha spesso una connotazione di ambiguità, sospetto, disonestà, ingiustizia, pericolosità, poca trasparenza... Il monito è sempre valido e attuale, anche oggi, di fronte alle molteplici forme di arricchimento indebito: speculazione, usura, giochi finanziari, tangenti, corruzione, riciclaggio di denaro sporco (Luca lo chiama disonesto, v. 9.11) per droga, mafia, sequestri…
Fin dai primi secoli, la tradizione cristiana ha recepito questo messaggio circa il valore, l’uso e la pericolosità delle ricchezze. La parola di alcuni Padri della Chiesa è eloquente e sferzante. S. Basilio scrive: “Non sei tu un ladro quando consideri come tue le ricchezze di questo mondo, ricchezze che ti sono state consegnate solo affinché tu le amministrassi?”. E S. Ambrogio: “Non dobbiamo considerare ricchezza ciò che non possiamo portare con noi. Perché ciò che dobbiamo lasciare in questo mondo non ci appartiene, è degli altri”. S. Giovanni Crisostomo ha un ampio e provocatorio insegnamento in materia, che si può riassumere così: “Il ricco o è ladro o è figlio di ladri”. Si può non condividere alcune espressioni, ma è da persone sagge confrontarsi onestamente con esse.
Le abitudini del denaro ingiusto e disonesto sono antiche quanto l’umanità. Il profeta Amos (I lettura), nel secolo VIII prima di Cristo, in un’epoca di splendore del regno di Israele, denuncia con toni di fuoco coloro che si arricchiscono sulla pelle dei poveri e degli umili (v. 4), fino a “comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali” (v. 6); sono smaniosi di fare soldi con le solite astuzie mercantili: giocando sui tempi e falsando le misure e le bilance (v. 5). Mille anni dopo, gli fa eco S. Basilio contro gli usurai del suo tempo: “Tu sfrutti la miseria, ricavi denaro dalle lacrime, tu strangoli colui che è nudo, schiacci l’affamato”. (*)
L’amministratore di cui parla Gesù nella parabola (Vangelo) è infedele e scaltro. È infedele, perché ha abusato della fiducia del padrone, ne ha sperperato gli averi, meritandosi il licenziamento (v. 1-2). Ha prevaricato, è stato disonesto e corrotto. Sulla cattiva gestione dei beni del padrone il giudizio è e resta negativo; anche se nella seconda parte della parabola l’amministratore, con sorpresa, viene lodato. La lode che il suo padrone gli riserva (v. 8) e gli spunti che ne ricava Gesù riguardano solo il modo scaltro come lui se la cava, cercandosi amici per il suo futuro incerto. Egli sa trasformare il denaro da mezzo di sfruttamento in occasione di condivisione; la sua scaltrezza consiste nell’usare il denaro per farsi degli amici. “Potremmo dire, il malfattore diventa benefattore” (E. Ronchi). La parabola insegna
a farsi degli amici, a circondarsi di affetti, costruirsi attorno relazioni vere e profonde, utili per il futuro.
La prassi è diversa ai nostri giorni. La Bibbia di Gerusalemme, al v. 16,8 di Luca, spiega che, secondo l’uso allora tollerato in Palestina, gli amministratori - che non erano pagati - avevano diritto di rifarsi incassando una percentuale sui prestiti maggiorati concessi ai debitori dei loro padroni. Il beneficio personale degli amministratori consisteva appunto nella differenza fra il prestito reale e la ricevuta maggiorata. Lo scaltro amministratore della parabola non toglie al padrone la quantità reale che gli spetta; semplicemente riduce la ricevuta del debitore alla quota reale, rinuncia alla parte di interesse che gli spetterebbe, favorendo gli eventuali futuri amici, che, in tal modo, pagheranno al padrone solo il debito netto, senza interessi né usure. La scaltrezza dell’amministratore, che anche Gesù elogia, consiste nel saper rinunciare a un interesse economico immediato, per puntare sul beneficio di amici per il futuro. C’è qui un invito a investire non tanto sulle cose che periscono, ma sui valori che permangono. Per Gesù tali valori sono anzitutto due: la condivisione dei beni con i poveri in vista delle dimore eterne (v. 9) e la libertà di fronte alle cose che schiavizzano il cuore (v. 13).
È forte qui l’invito all’apertura del cuore, alla sensibilità verso gli altri. Questa apertura, afferma S. Paolo (II lettura), si ispira nel Cuore di “Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità” (v. 3-4). Proprio tutti: lo ripete quattro volte (v. 1.2.4.6), per sottolineare il progetto generoso di Dio (v. 4), l’opera di Cristo (v. 6), la dimensione universale della preghiera del cristiano (v. 1-2.8), chiamato ad essere ovunque messaggero di Cristo (v. 7).
Parola del Papa
(*) La Santa Madre Teresa di Calcutta “si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato; ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra, perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini – dinanzi ai crimini! - della povertà creata da loro stessi”.
Papa Francesco
Omelia nella canonizzazione della Beata Teresa di Calcutta, 4.9.2016
P. Romeo Ballan, MCCJ
La scelta di servire Dio o mammona
Am 8,4-7; Salmo 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13
La parabola dell’amministratore scaltro, riferita solo nel vangelo di Luca, dà il tono alla liturgia della parola di questa domenica. Questa parabola sorprendente, in cui viene fatto l’elogio di un uomo disonesto, è preparata dalle parole del profeta Amos (vissuto otto secoli prima di Cristo), nella prima lettura, che denuncia le manovre di molti ricchi che controllano il mercato del grano in Israele. Il profeta descrive le ingiustizie compiute da questi disonesti, che mentre osservano con pignoleria le prescrizioni puramente esteriori della Legge, erano poi capaci di vendere un povero al prezzo di “un paio di sandali”. Ma Dio, per mezzo del profeta, si presenta come difensore dei diritti del povero.
Nella seconda lettura l’apostolo Paolo scrive al suo discepolo Timoteo, con le raccomandazioni sulla preghiera: occorre pregare sempre, tutti per tutti. Questo è lo specifico della preghiera della cristiana: essa deve sempre avere un’apertura universale, poiché Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini.
Nel vangelo, si tratta indubbiamente di una parabola imbarazzante, però che raccomanda la virtù della prudenza ed è seguita da consigli ai discepoli sull’uso sapiente delle ricchezze. Questa storia di una truffa, operata da un amministratore scaltro ed infedele, che riduce notevolmente l’ammontare dei debitori del suo padrone (venti per cento per il grossista di grano, e cinquanta per quello dell’olio), e che poi viene elogiato dal padrone, suscita degli interrogativi. Com’è possibile lodare un comportamento disonesto? Il “padrone ricco” delle parabole spesso è Dio stesso, e l’amministratore rappresenta, ogni uomo, ciascuno di noi.
L’approvazione del Signore va all’amministratore astuto, certo; tuttavia la lode non riguarda la sua disonestà, bensì la scaltrezza di cui ha dato prova. Egli rappresenta senz’altro i “figli delle tenebre”, ma è il suo agire che viene proposto come modello ai “figli della luce”. Gesù non pronuncia un giudizio morale sulla condotta truffaldina, ma apprezza l’intraprendenza del suo furfante. La lezione riguarda anche ognuno di noi, poiché risulta difficile di avere sempre i registri a posto. Per poco che Dio ci dia un’occhiata, c’è da tremare.
L’amministratore astuto è chiamato phronimos (saggio) perché ha saputo prendere una decisione coraggiosa, lucida e rapida per cavarsi fuori da una situazione drammatica e per assicurarsi il futuro. lì si trova il punto focale della parabola, la lezione di fondo. Infatti Gesù annuncia che il regno di Dio è vicino. Chi vuole prendervi parte deve fare come l’amministratore della parabola, cioè, senza dilazioni e ripensamenti, approfittare della situazione presente ed agire di conseguenza per assicurarsi il destino futuro. L’urgenza del regno di Dio comporta una decisione immediata e pratica di fronte alle parole ed azioni di Gesù. L’amministratore infedele trova un varco che gli permette di uscire dalla sua situazione difficile attraverso una scoperta decisiva: la scoperta degli altri. Finora non si era accorto veramente della loro “esistenza”; pensava solo a sé a ai propri interessi. Adesso scopre la propria identità nel suo “essere per” i prossimi; e la propria salvezza passa attraverso questa apertura al prossimo.
Per quanto riguarda l’uso delle ricchezze, la proposta principale è quella di farsi amici i poveri con la condivisione dei beni materiali (di cui siamo solo amministratori e non proprietari) per essere accolti nella vita eterna. Non è consentita l’autogestione. Questi sono provvisori ed appartengono ad altri. E’ il poco del tempo presente rispetto alla felicità eterna. “Nessuno può servire a due padroni…”. Bisogna scegliere tra Dio e mammona (le ricchezze). La ricchezza personalizzata, in chi la considera come fondamento della vita, crea l’illusione della (falsa) sicurezza. Gesù vuole avvertici circa il rischio di fare una valutazione falsa dei beni materiali.
Don Joseph Ndoum
Simbolo o Idolo.
Il denaro nel Vangelo di Luca
Il denaro ha un ruolo importante nella vita degli uomini. Parlarne suscita sempre interesse e perplessità. Il « boom » economico, frutto dei passi da gigante compiuti grazie alle scoperte scientifiche, ai progressi tecnologici e industriali ed allo sviluppo degli scambi economici e finanziari, ha largamente contribuito al miglioramento della qualità della vita umana. Nonostante ciò, esso ha originato nuove problematiche che si pongono come sfide al mondo moderno. Il benessere non va necessariamente di pari passo con lo stare bene. La globalizzazione della società dovrebbe servire alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo. Purtroppo, la mondializzazione del mercato ha assunto un ritmo che non soltanto favorisce la crescita delle disuguaglianze sociali, ma in più, semina germi distruttori del tessuto sociale, familiare, culturale e religioso.
Nel mio paese, la Repubblica Democratica del Congo, così come in quasi tutti i paesi del Terzo mondo, la povertà ha raggiunto un livello drammatico che non può lasciare indifferente il pastore e il teologo, tanto più ogni qual volta è possibile vedere le conseguenze del marasma socioeconomico nella vita e nella missione della Chiesa. In Occidente, così come in varie parte del Pianeta, ci troviamo immersi in una cultura consumista e di profitto a tutti i costi che riduce l'uomo ad uno strumento al servizio di interessi finanziari. Siamo testimoni e vittime di un sistema economico che vuole che tutto sia organizzato in base al modello ed al diritto imposti dalle grandi potenze e dalle organizzazioni finanziarie.
Il modo in cui « la religione dell'economia e del denaro » domina la società impone un cambiamento di mentalità, di comportamento e di strutture. Inoltre, esso fa appello alla verità intima di tutti coloro che si dichiarano credenti. A ognuno di noi viene posta una domanda fondamentale: Chi è il tuo Dio? In chi, e in che cosa, hai fiducia? Il nostro rapporto con il denaro, vale a dire il nostro modo di acquisirlo e l'uso che ne facciamo, traduce il nostro rapporto con Dio, la nostra visione dell’uomo e della vita in società. Prima d'essere di natura economica, quindi, il problema posto dalla nostra gestione del denaro e dei beni del Creato è in primis di natura religiosa e etica.
Pur riconoscendo la complessità delle questioni economiche e delle sfide del mondo attuale, che richiedono competenze specifiche, uno studio biblico sul denaro resta utile per alimentare la riflessione teologica e per rischiarare le scelte di vita personali e sociali in vista dell’instaurazione del Regno di Dio. Una corretta conoscenza dei valori, nei quali tutti i Battezzati debbono impegnare la loro libera responsabilità, è per essi e per la loro coscienza un quesito sul senso della vita. La saggezza evangelica interpella la funzione del denaro che cercano di avere o che possiedono, il senso della rinuncia e della gratuità, la loro battaglia per la giustizia, l’inventiva della loro carità e, in fin dei conti, l'autenticità della propria conversione al Vangelo e della propria adesione al Regno di Dio.
L'ingiustizia consiste in rapporti viziati con Dio e in relazioni di fratellanza compromesse. Laddove c’è ingiustizia, v'è il culto di un altro dio. L'ingiustizia rivela una sacralizzazione, una deificazione di qualcosa. Il denaro, che in questo caso diviene «Mamona», è il più astuto e il più pericoloso degli idoli; la sua potenza separa l'uomo idolatra da Dio, spingendolo a perdere fiducia in Lui e allontandolo dagli altri, l'idolatria del denaro mette in pericolo di morte l'idolatra stesso, gli altri e la comunità dove egli vive.
Gesù ha parlato più spesso del denaro sulla strada di Gerusalemme. Secondo l'autore del terzo Vangelo, il pericolo dell'idolatria del denaro occupa una posizione centrale nel nostro cammino di fede. Coloro che rifiutano di cedere alla tentazione di idolatrare il denaro, entreranno con Gesù nella Nuova Gerusalemme. La porta del Regno di Dio non è chiusa a priori per nessuno. La salvezza viene offerta a tutti.
Gesù manda i suoi discepoli ad annunziare il suo Regno. Ne saranno capaci soltanto se, come Lui, mettono la loro fede nella potenza che viene dall’Alto e non sul potere di «Mamona» (9,16.23-25; 10,17-20). Senza rinuncia, gratuità, libertà, umiltà e misericordia, non potranno trasmettere la vita, offrire la salvezza. Chiamato ad esercitare lo stesso ministero di Gesù, il discepolo deve vivere come «figlio di Dio». Il vero discepolo di Gesù, il «giusto» lavora affinché il Regno di Dio si avvicini agli uomini per suo tramite, col potere del Figlio di Dio e come figlio di Dio.
Mgr Jean Basile Mavungu Koto