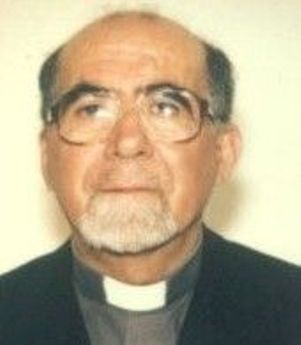Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
In Pace Christi
Gostoli Elvio
P. Elvio Gostoli era nato a Furlo di Acqualagna, in provincia di Pesaro, il 1° gennaio 1924. Seguì gli studi superiori, fino alla prima teologia, nel Pontificio Seminario Diocesano di Fano. Nel settembre 1945 entrò dai Missionari Comboniani nella casa di Firenze, continuando gli studi teologici a Fiesole. Finito il noviziato, emise i primi voti il 9 settembre 1947. Continuò poi gli studi teologici a Verona e a Venegono. Fu ordinato l’11 giugno 1949 nella chiesa del suo paese natale. Subito dopo, incaricato dell’animazione missionaria e vocazionale, fu mandato in varie case comboniane: Trento, Pesaro, Rebbio e Sulmona.
In Sudan
Nel 1955 P. Elvio fu destinato al Vicariato del Bar el Gebel, provincia dell’Equatoria, Sudan Meridionale, con capitale Juba. Dopo un breve periodo di adattamento nelle vicinanze di Juba, la sua prima vera missione fu Loa, fra la tribù Madi, 200 km a sud di Juba, vicino al confine con l’Uganda. Qui trovò P. Umberto Cardani, suo primo maestro di lingua Madi. “Il giorno dopo il mio arrivo P. Cardani venne da me con il catechismo e mi disse: ‘oggi insegna questa parte’. Sorpreso, cercai di dire che non capivo una parola di quella lingua, ma mi rispose: ‘non fa niente; comincia e lascia che ridano, anzi ridete insieme e vedrai che in poco tempo comincerai a capire’”. La sua missione fra i Madi, però, fu molto breve – cinque mesi – perché, per sostituire un missionario che si era ammalato, fu mandato a Kadulè, tra i Mundari, in un territorio esteso dall’estremo sud all’estremo nord del Bar el Gebel.
La missione di Kadulè era veramente immensa. Comprendeva i territori delle due sponde del Nilo e le tribù dei Mundari, Nyangwara e Pajulu: 10.000 kmq, 75.000 abitanti. I missionari erano solo due. “Per visitare tutti i villaggi, viaggiando a turno in bicicletta o a piedi per un safari di almeno 3 settimane, ci impiegavamo un anno e mezzo... I villaggi sono 246 e i centri che riusciamo a visitare apostolicamente sono circa 120. Si visita un villaggio al giorno. Vi si arriva nel primo pomeriggio, quando il sentiero scotta sotto i piedi e l’afa toglie le forze. Ci si accampa, si fanno le debite visite, mentre il cuoco prepara qualcosa. Poi, via, in cerca di cristiani, di capanna in capanna”.
Era un problema trovare acqua potabile e cibo, si dormiva all’aperto, con nugoli di zanzare, in luoghi dove si aggiravano leoni, iene, elefanti, serpenti, scorpioni e, vicino all’acqua, ippopotami e coccodrilli. E si doveva lottare contro l’implacabile malaria. “Finalmente – continua P. Elvio – nel 1960 riuscii ad avere una Land-Rover di seconda mano. Ma non c’erano strade, per cui, quando andavo in safari, portavo con me un gruppo di giovanotti per aprire dei tracciati di strade anche attraverso il bosco”. Dopo l’espulsione dal Sud Sudan, P. Elvio rimase a Pesaro per un anno incaricato dell’animazione missionaria.
45 anni in Uganda
Nel 1965 Mons. Sisto Mazzoldi, espulso anche lui da Juba, assunse l’incarico nella regione del popolo Karimojong, divenendo vescovo di Moroto, nel nord-est dell’Uganda. P. Elvio poté seguirlo in quella zona. Il vescovo gli chiese di portare aiuto ai profughi sudanesi della zona Acholi (diocesi di Gulu). Erano stati isolati in due campi profughi – 10.000 all’Agago e 17.000 ad Achol-pi (che significa acqua sporca) – in mezzo al bosco, senza riparo né cibo né acqua né cure mediche. I Comboniani fecero di tutto per aiutarli. P. Elvio tutti i giorni visitava questi campi e tutti i giorni riempiva la Land Rover di malati che portava all’ospedale di Kalongo, dove P. Giuseppe Ambrosoli e le suore comboniane “li accoglievano senza mai dire di no”. Quando parte dei profughi sudanesi furono trasferiti nella missione di P. Elvio, gli fu più facile prendersi cura di loro, anche dal punto di vista spirituale.
P. Elvio rimase poi un anno a Kangole, tre anni a Nabilatuk, quindici anni a Lorengedwat, otto anni a Namalu, nove a Naoi e infine a Moroto dal 2002 fino alla morte. Appena arrivato a Kangole, la sua prima impressione non fu delle migliori: “Quando iniziai la mia missione tra i Karimojong, fui veramente sconvolto. I Mundari del Sud Sudan era gente pacifica. Non così i Karimojong, pastori seminomadi, guerrieri e predoni, sempre in lotta tra loro o con i Pokot o i Turkana del vicino Kenya per questioni di razzie di bestiame. Dovevo correre due o tre volte alla settimana a soccorrere i feriti, anche se in quel periodo avevano a disposizione solo lance e frecce”. Al mio ritorno da queste missioni, la gente mi batteva le mani dicendo “Padre, la tua auto è un aeroplano”.
Nabilatuk
P. Elvio fu mandato a Nabilatuk nel 1966, per aiutare un missionario molto anziano. Lì, un grande problema era l’acqua potabile, molto scarsa nella stagione asciutta e fangosa nella stagione delle piogge. Una volta, in un periodo di siccità, P. Elvio fu persino accusato dallo stregone di aver prosciugato una pozzanghera. Allora decise di scavare un pozzo con le mani, nel vecchio letto del fiume dove crescevano delle belle acacie. “Quando incominciai a scavare, la gente rideva, dicendo che in quel posto non avrei mai trovato l’acqua. Dopo solo quattro metri di terra e di ghiaia rossa molto compatta cominciò a sgorgare l’acqua. Ma purtroppo, dopo la terra rossa, cominciò la roccia di granito. Preparai degli scalpelli grossi con vecchi semiassi delle macchine, come da piccolo avevo visto fare da uno zio fabbro. Prima dei dieci metri, trovammo una bella vena”. Questo fu il primo pozzo. Il secondo fu costruito più vicino alla missione e procurò acqua in abbondanza per tutta la missione e per la gente dei dintorni.
Il lavoro alla missione procedeva bene. “Avevo giovani, ragazzi e ragazze che venivano per la catechesi tutti i giorni, specialmente il pomeriggio e la sera, poiché durante il giorno dovevano badare alla mandria. Con l’arrivo delle suore, potemmo organizzare meglio l’istruzione, anche per gli anziani e per le famiglie”. Intanto la missione si sviluppava sempre di più e i lavori in corso erano tanti: la chiesa, la casa dei missionari, poi la casa delle suore, un locale da usare come pronto soccorso, una scuola di cucito e il dormitorio per le ragazze e i ragazzi. “Avevo compreso che non si può fare solo evangelizzazione e catechesi, ma che è necessaria anche la promozione umana e l’impegno ad affrontare e risolvere i problemi quotidiani”.
Lorengedwat
A Lorengedwat gli anni 1971-1973 furono difficilissimi. Dal punto di vista religioso c’era poco o niente. Per avere un impatto sulla gente, si portò dei catechisti dalla sua missione precedente e un trattore per il lavoro dei campi. Era un periodo di carestia, dopo due anni di siccità: “la gente moriva di fame e di colera, in particolare i bambini. Ne morivano in media 20 alla settimana; non sapevo dove sbattere la testa per poterli aiutare”. Si rivolse quindi a Don Vittorio Pastori, alla Caritas Italiana e a Mons. Nervo che insieme al dott. Strippoli era dirigente della FAO. L’UNICEF inviò tre infermiere. Furono aiutate anche le famiglie nei villaggi. L’assistenza ai bambini e alle famiglie durò due anni, cioè fino all’arrivo di un buon raccolto.
Con la caduta di Amin Dada prima e di Milton Obote poi, la situazione si fece caotica anche a causa dello sbandamento dell’esercito e del fuggi-fuggi generale. P. Elvio cercò di salvare molte persone, portandole ad almeno 150 km di distanza, viaggiando spesso di notte. I predoni Karimojong erano numerosi e ora armati di fucili mitragliatori sottratti alle caserme dei militari in fuga. La missione di Namalu, dove c’erano stati degli scontri armati, fu saccheggiata e abbandonata.
Namalu
Più tardi P. Elvio si prese cura di questa missione. Un giorno i Pokot, vicini e rivali dei Karimojong, che vivono parte in Uganda e parte in Kenya, organizzarono una grande vendetta contro i villaggi più vicini al confine e che facevano un po’ da base per i predoni-guerrieri Karimojong. Così percorsero la vasta area della zona di Namalu incendiando tutti i villaggi che trovavano sul loro cammino e uccidendo tutti quelli che non erano riusciti a fuggire. P. Elvio, ancora una volta, si prodigò per salvare i feriti. “Partii con quel carico per il nostro ospedale, lontano 150 km, quando un gruppo di predoni Karimojong mi fermò spianando i fucili. Dovetti fermare la macchina, una Fiat Iveco da 3 tonnellate. Scesi, aprii lo sportello posteriore e mostrai loro lo spettacolo di quei feriti in mezzo a tanto sangue e dissi: ‘Sto portando all’ospedale questi vostri fratelli e voi mi fermate per chiedermi denaro?’. I predoni si ritirarono lasciandoci passare”. Nella missione, P. Elvio poteva contare su una ventina di giovani, contenti di essere educati e formati come catechisti. Costruì anche una scuola in muratura per le ragazze. “Dopo un anno avevamo 250 ragazze. Ora è una scuola fiorente con 600 alunne. In missione, il mattino era dedicato alle attività materiali: costruzione, falegnameria e meccanica. Al pomeriggio, educazione cristiana dei giovani aspiranti catechisti e catecumeni e dei gruppi di preghiera delle varie zone”. Terminò anche la riparazione della chiesa, per la quale erano state utilizzate delle impalcature fatte con tronchi di eucalipto. Infatti, durante gli scontri armati, il tetto, di lamiera, era stato ridotto a un colabrodo e i vetri erano andati completamente in frantumi.
La missione più difficile, fra i Matheniko
Alla fine del mese di giugno del 1973, P. Elvio ritornò in Italia per un po’ di riposo e vacanza. Appena in tempo per curare un’emorragia al colon. In ottobre gli fu detto che poteva ritornare in Africa a patto che fosse una missione vicina ad un ospedale. La missione più vicina all’ospedale di Matany era Naoi, così P. Elvio venne mandato lì. Si trovava ora tra i Matheniko. La sua parrocchia contava circa 40.000 persone di questa etnia. “Ebbi modo di capire sempre di più che la missione tra i Matheniko era veramente la più difficile della mia vita missionaria, ma la Provvidenza, che è sempre pronta a venire incontro, mi aiutò anche questa volta”.
Dovette, ancora una volta, ricominciare da capo per conoscere la gente del posto, trovare catechisti, iniziare l’insegnamento e nuovi gruppi di preghiera e occuparsi delle costruzioni. Molte di queste avevano bisogno di essere riparate e c’era la necessità di aggiungere altre sale per gli incontri. Non lontano dalla missione c’era una scuola fatiscente, costruita da un’organizzazione internazionale alle dipendenze dell’ONU. Con l’aiuto di amici e benefattori la scuola fu sistemata, con ben sette aule, e affidata alle suore francesi del Sacro Cuore di S. Maddalena Sofia Barat, tutte insegnanti. Nella Pasqua del 1997, P. Elvio terminò di preparare un centinaio di ragazzi e ragazze per il battesimo. Pensava di costruire un piccolo ospedale. Sentendosi piuttosto stanco, era ritornato in Italia per un po’ di riposo e controlli medici. Il cugino, Angelo Candricci, di Fano, era “pronto a regalarmi tutto il materiale necessario e le relative attrezzature per la costruzione dell’ospedale. Si trattava di pannelli prefabbricati, isotermici, isoacustici e antisismici, un suo brevetto particolare”, racconta P. Elvio. Così, superati i problemi logistici della preparazione del terreno, del trasporto del materiale e della sistemazione dei tecnici, la struttura principale dell’ospedale fu completata in due settimane. In aggiunta, furono installati dei pannelli solari e scavato un pozzo che provvedeva acqua in abbondanza per l’ospedale, per il terreno circostante e per la gente della zona, oltre che per gli abbeveratoi per il bestiame”.
Nel secondo sinodo della diocesi di Moroto si stabilì come priorità la formazione di piccole comunità cristiane di base, affinché i neo battezzati e cresimati, ritornando nei loro villaggi, trovassero il supporto di una piccola comunità cristiana. Poco tempo dopo, P. Elvio poteva dire: “Abbiamo ora quindici piccole comunità cristiane di base, venti gruppi di preghiera e ventiquattro posti di preghiera. Le guide o leader di queste comunità sono spesso donne analfabete che imparano il Vangelo a memoria. Anzi, tra i migliori di questi leader abbiamo una donna cieca (Regina Pulukol), catechista da trent’anni, e un uomo cieco (Marko Ngoya) responsabile di una nostra cappella con quasi 10.000 abitanti. Questa cappella, dedicata a san Daniele Comboni, è larga 8 m. e lunga 25 m. ed è sempre piena quando il missionario vi si reca a pregare, anzi sempre piena dentro e fuori, tanto che non è più sufficiente per quella zona”.
Testimonianze su Ekasikout
Nel 2002 P. Elvio fu destinato a Moroto, capoluogo del Karamoja e sede del vescovo. Qui ha svolto il suo ministero fino alla morte, avvenuta il 6 ottobre 2011. I Karimojong non lo chiamavano con il suo nome ma Ekasikout, che significa “anziano”, un titolo che non fa riferimento solo all’età ma anche all’autorità di un capo o di un leader religioso. Dopo i funerali, presieduti dai vescovi di Kotido, Mons. Giuseppe Filippi, e di Moroto, Mons. Henry Apaloryamam Ssentongo, P. Elvio è stato sepolto nel cimitero della missione. l “Movimento Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo” di Piacenza ha scritto: “P. Elvio è stato un punto di riferimento per tutti coloro che hanno operato in Karamoja e, conoscendolo da 40 anni, possiamo dire che ha saputo incarnare e vivere con forza i valori di san Daniele Comboni, come vero testimone del Vangelo e dell’amore di Dio per i più poveri e dimenticati”.
Suor Paulina Lopez Ridruejo, superiora delle Suore francesi di Naoi, che aveva lavorato con lui nella pastorale per otto anni, dice che P. Elvio, anche se a una prima impressione poteva sembrare un po’ scontroso e irascibile, aveva un grande cuore ed era compassionevole con tutti. Il suo modo di fare catechesi e di preparare la gente ai sacramenti esercitava una grande influenza sulle persone. Era incredibile vedere come riusciva a rapportarsi con quei guerrieri, in maggioranza non ancora battezzati ma desiderosi di imparare.
Nell’ultimo anno, la malattia lo aveva reso dipendente dagli altri e a volte lo si vedeva piangere in silenzio per l’impossibilità di continuare il suo ministero pastorale. La domenica dopo la morte di P. Elvio, Marko, il catechista cieco incaricato della chiesa dedicata al Comboni, ha raccontato un po’ la vita di Ekasikout, accompagnata da aneddoti commoventi che avevano vissuto assieme. Alla fine ha posto l’accento su come P. Elvio era vissuto con loro e per loro, aggiungendo che il suo desiderio era di essere sepolto vicino a loro.
Da Mccj Bulletin n. 251 suppl. In Memoriam, aprile 2012, pp. 7-14.