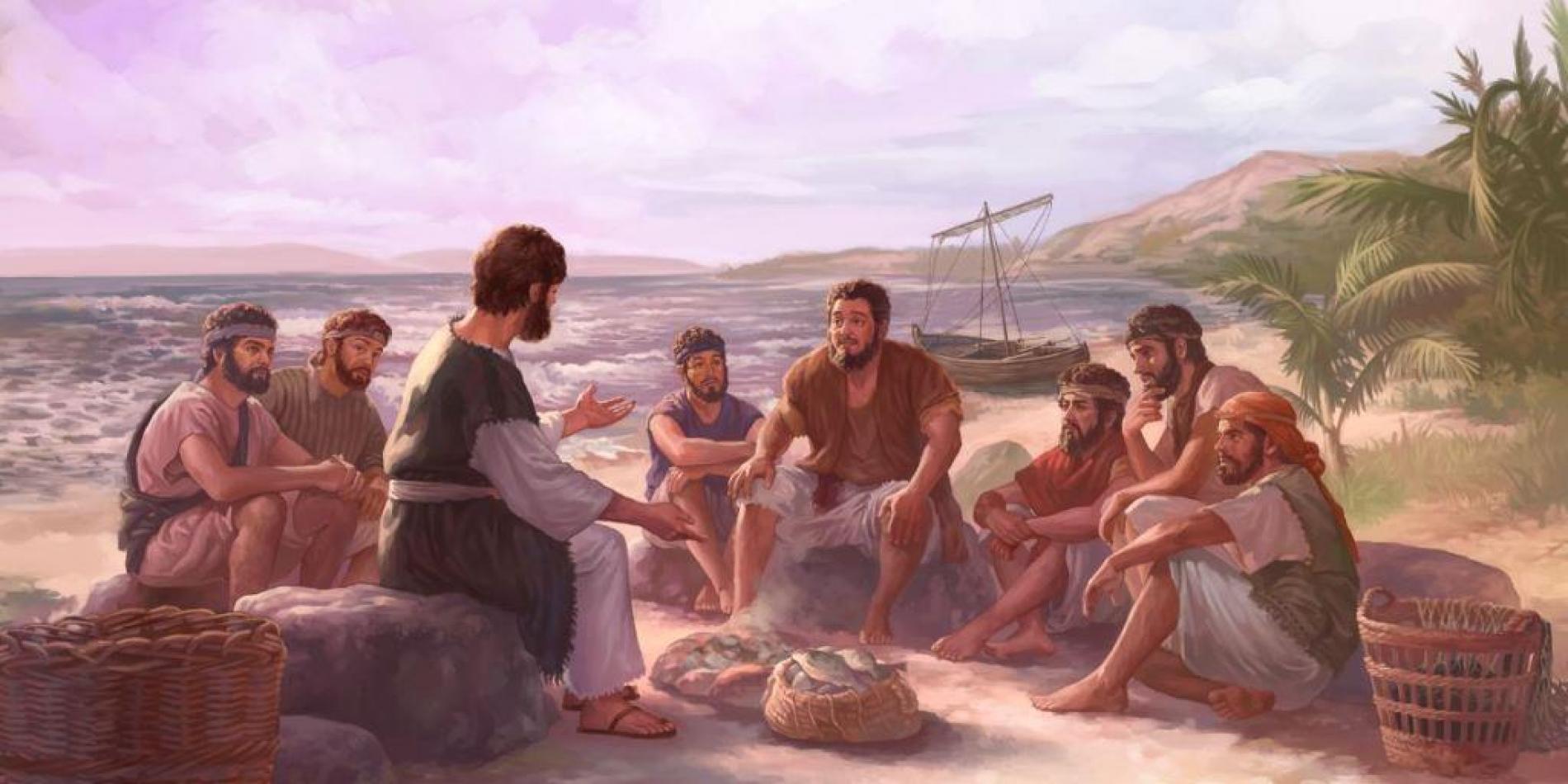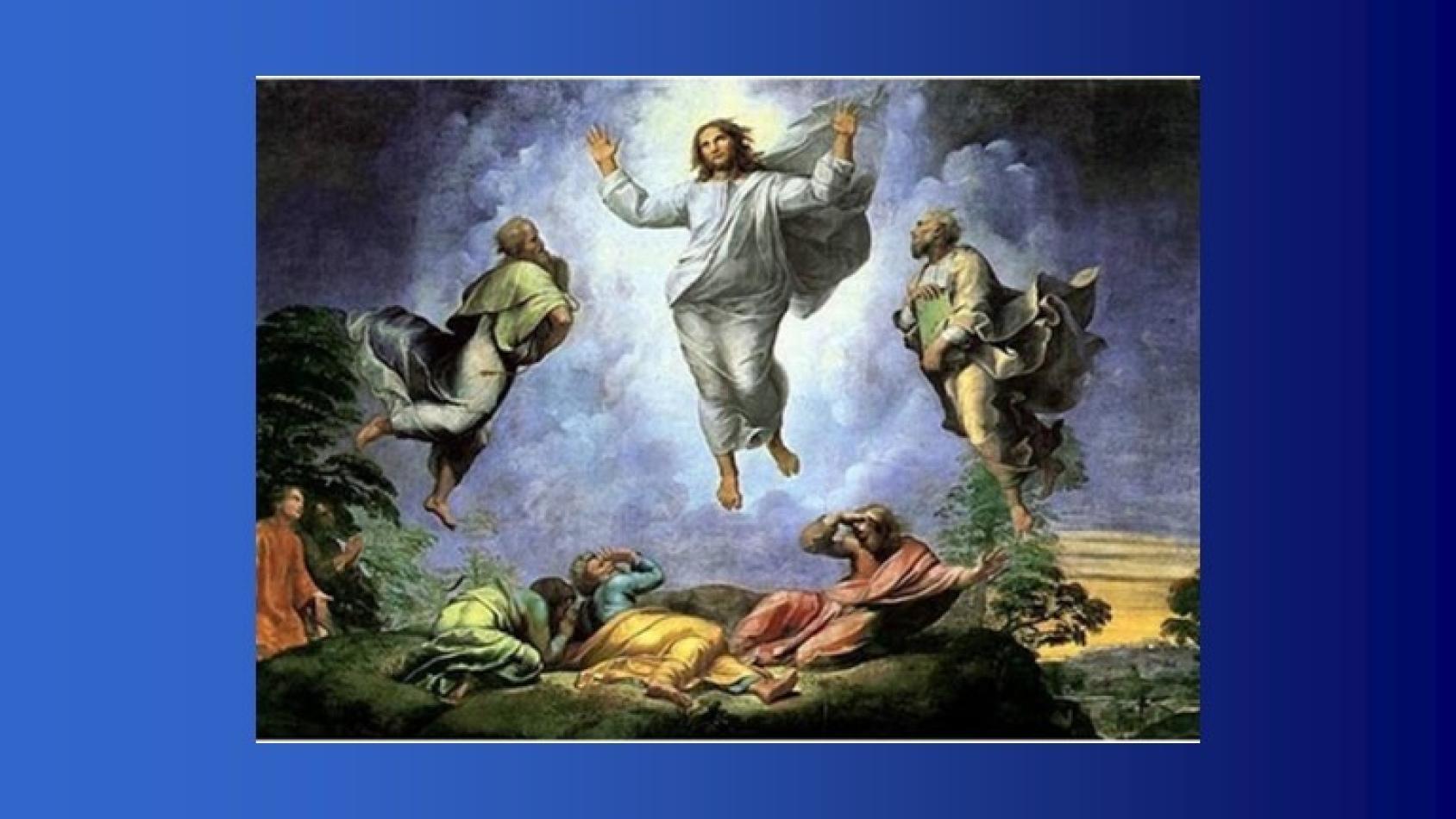Daniele Comboni
Missionari Comboniani
Area istituzionale
Altri link
Newsletter
In riva al lago si respira aria fresca, aria di universalità e di missione nel mondo. Il terzo incontro di Gesù risorto con il gruppo dei discepoli (Vangelo) avviene non più nel Cenacolo di Gerusalemme, a porte chiuse, ma all’aperto, sulle rive del lago di Galilea, in un mattino di primavera. Il fatto di quella pesca miracolosa post-pasquale e la missione che Gesù affida a Pietro sono narrati con il linguaggio proprio dell’esperienza mistica, con ricca simbologia, e con note di una profonda affettività.
“È il Signore!”
Giovanni 21,1-19
Durante il tempo pasquale dell’anno liturgico “C”, la prima lettura è tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, la seconda dall’Apocalisse e il Vangelo da san Giovanni. Domenica scorsa, san Giovanni ci ha raccontato le due apparizioni di Gesù ai discepoli a Gerusalemme, avvenute di domenica, mentre essi erano rinchiusi nel cenacolo. Oggi ci presenta invece la sua manifestazione in un contesto completamente diverso: non siamo più nella città santa, ma nella “Galilea delle genti”, terra di fede incerta; non più di domenica, ma in un giorno feriale, in un ambiente profano. Il Risorto non si incontra soltanto nello spazio sacro della chiesa, la domenica, ma anche negli ambiti quotidiani, nel lavoro, nella ferialità.
Una giornata di lavoro
Tutto parte dall’iniziativa di Simon Pietro, che decide di andare a pescare. I suoi compagni si uniscono a lui: “Veniamo anche noi con te”. Ci chiediamo: che cosa significa questo gesto di Pietro? È forse dettato dalla noia, dal non sapere cosa fare? O da un senso di smarrimento, ora che si ritrovano soli, senza il Maestro? Oppure è un ritorno al passato, alla vita di prima, dopo la parentesi dei tre anni vissuti nella sequela di Gesù? Anche a noi può capitare di trovarci in una situazione simile. Dopo un’esperienza appassionante che si interrompe bruscamente, lasciandoci delusi e disorientati, la tentazione è quella di dimenticare tutto e “ritornare alla vita di prima”.
Il racconto, tuttavia, suggerisce qualcosa di diverso. L’evangelista introduce elementi che lasciano intravedere una portata simbolica dell’evento. Non si tratta di una pesca qualunque, ma della missione loro affidata: essere “pescatori di uomini”. Si parla infatti della barca di Pietro (simbolo della Chiesa); dei sette discepoli (simbolo della totalità della comunità cristiana, a differenza dei dodici che rappresentano Israele); del mare (simbolo delle forze ostili alla vita); di Tiberiade, città costruita da Erode Antipa in onore dell’imperatore Tiberio, città semi-pagana, che Gesù sembra non abbia mai visitato, ritenuta impura perché edificata su un cimitero (F. Armellini).
Insomma, una missione molto simile alla nostra, oggi. In quella barca, rappresentati dai sette, ci siamo anche noi, insieme a quanti lottano per liberare il mondo dalle potenze del male.
Una notte di frustrazione
“Ma quella notte non presero nulla.”
Come mai? Per imperizia? O è forse una conferma che, senza di Lui, non possiamo fare nulla? Tutti abbiamo vissuto momenti simili: frustrazione, senso di inutilità, la sensazione di aver sprecato tempo ed energie… La maturità, sia umana che cristiana, passa anche attraverso questi tempi di prova. La nostra condizione è quella di lavorare nella “notte”, senza esiti garantiti.
Una aurora di speranza
Ma dopo ogni notte, spunta sempre l’alba, che porta luce e speranza nella nostra vita. Questa luce e questa speranza provengono dallo “sconosciuto” che appare sulla riva:
“Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù”.
Forse era stato lì per tutta la notte, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
“Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci”: 153 grossi pesci, una cifra enigmatica che simboleggia l’abbondanza e, forse, la totalità dell’umanità da salvare.
Gesù si rivolge a loro con l’appellativo affettuoso di “figlioli”. Così ci chiama anche oggi, soprattutto nei momenti di tristezza, frustrazione e scoraggiamento. E ci indica dove gettare la rete: a destra, il lato giusto, il lato buono che esiste in ogni persona.
“Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!»”.
Pietro e Giovanni sono i protagonisti di questa domenica, come lo è stato Tommaso la domenica scorsa. Essi non sono antagonisti, ma complementari: rappresentano l’istituzione e il carisma, l’azione e la contemplazione. Sono le due componenti fondamentali della nostra vita cristiana.
Una mattina di consolazione
“Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane… Gesù disse loro: «Venite a mangiare».”
L’incontro con il Risorto si conclude attorno al fuoco pasquale, in un momento di convivialità. L’invito a mangiare diventa un’allusione all’Eucaristia. Il pane e il pesce sono simboli cristologici ricorrenti nella primitiva comunità cristiana.
Ma c’è qualcosa, nell’aria primaverile, che frena l’espandersi della gioia. Le fiamme di quel fuoco riportano alla mente di Pietro i fantasmi di quella notte in cui, proprio attorno a un fuoco, aveva rinnegato per tre volte il Maestro. Nemmeno gli altri discepoli osavano guardare Gesù negli occhi. Nessuno aveva la coscienza a posto. Da un momento all’altro si aspettavano un richiamo, un rimprovero da parte di Gesù per la loro infedeltà. Ma nulla di tutto questo accade.
È Gesù a sollevare il macigno, con una delicatezza amorosa che commuove:
“Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami (verbo greco agapan) più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene (philein)». Gli disse: «Pasci i miei agnelli».”
Gesù domanda usando il verbo agapan, che indica un amore totale, incondizionato (agape), mentre Pietro risponde impiegando philein, che esprime un amore di affetto e amicizia (philia). Alla terza domanda, Gesù stesso adotta il verbo philein:
“«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene».”
E a Pietro, che si era dimostrato inaffidabile, Gesù affida il suo gregge. Lo costituisce Pastore, un titolo messianico che fino a quel momento aveva riservato a sé.
“E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».”
Seguimi, per essere il Pastore che dà la vita per le mie pecore.
Un modello stupendo di consolazione
Concludo con questo bel commento del cardinale Carlo Maria Martini:
“L’agire di Gesù è un modello stupendo di consolazione che, passando sopra a tutti i difetti, coglie il meglio della persona.” Il Risorto non rimprovera nessuno. È vero, aveva ripreso i due discepoli di Emmaus e gli undici per la loro incredulità, ma senza mai accennare alla loro infedeltà o al tradimento (Luca 24,25; Marco 16,14).
“Questa è veramente consolazione regale: non approfittare dell’umiliazione altrui per schernire, schiacciare, mettere da parte, ma riabilitare, ridare coraggio, ridare responsabilità. Per consolare così, penso che bisogna essere come Gesù, cioè avere in sé una grande gioia, un grande tesoro, perché allora è facile comunicarlo. Il Signore, che ha il tesoro della sua vita divina, fa calare la consolazione come balsamo, goccia a goccia. E noi, nella certezza di essere in comunione con lui, possiamo far calare la consolazione goccia a goccia, senza rimproveri né presunzione.”
Ed è proprio per questa consolazione che gli apostoli, dopo essere stati flagellati, “se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù” (prima lettura).
P. Manuel João Pereira Correia, mccj
L’incontro con il Risorto porta alla Missione
Atti 5,27-32.40-41; Salmo 29; Apocalisse 5,11-14; Giovanni 21,1-19
Riflessioni
In riva al lago si respira aria fresca, aria di universalità e di missione nel mondo. Il terzo incontro di Gesù risorto con il gruppo dei discepoli (Vangelo) avviene non più nel Cenacolo di Gerusalemme, a porte chiuse, ma all’aperto, sulle rive del lago di Galilea, in un mattino di primavera. Il fatto di quella pesca miracolosa post-pasquale e la missione che Gesù affida a Pietro sono narrati con il linguaggio proprio dell’esperienza mistica, con ricca simbologia, e con note di una profonda affettività. In tal modo è possibile cogliere il messaggio nella sua globalità: il ritorno feriale alla pesca, il numero di sette pescatori, il mare, il fatto di pescare, la notte infruttuosa, l’alba, il Signore sulla riva, l’abbondante pesca, il fuoco per la colazione, il banchetto; e poi la missione affidata a Pietro con un sorprendente test sull’amore, la triplice consegna del gregge, l’impegno di una sequela per tutta la vita fino alla morte...
Il simbolismo mistico arricchisce il fatto e ne offre una comprensione più piena e universale. Ad esempio, se il mare è simbolo delle forze nemiche dell’uomo, pescare e divenire pescatori di uomini (Mc 1,17) vuol dire liberare dalle situazioni di morte, e la pesca diventa simbolo della missione apostolica. Il successo di tale missione, per quanto rischiosa, si vede nei “153 grossi pesci” (v. 11). Fra le tante interpretazioni di questo numero, ne sottolineo due: anzitutto l’esattezza contabile di un testimone oculare, ma anche il simbolismo del “50 x 3 + 3”, dove il 50 è simbolo della totalità del popolo e il 3 indica la perfezione. Non sfugge quindi nessun pesce. Il banchetto, al quale sono invitati da Gesù, ricorda la conclusione della storia della salvezza.
Le varie apparizioni di Gesù Risorto si possono catalogare in due gruppi: apparizioni di riconoscimento, nelle quali Gesù vuole in primo luogo farsi riconoscere ‘vivente’, e le apparizioni di missione, nelle quali Gesù dà incarichi precisi di immediata applicazione (andate a dire a...) o a lunga scadenza (andate in tutto il mondo, fate discepoli di tutte le nazioni...). In tal modo, gradualmente, per i discepoli si va delineando la portata universale dell’avvenimento ‘risurrezione’: il Risorto (I lettura) è “capo e salvatore” di tutti popoli (v. 31) e questa Bella Notizia deve essere annunciata a tutti, ovunque! Obbedendo a Dio prima che agli uomini! (v. 29) I discepoli cominciano a farlo subito in qualità di testimoni dei fatti (v. 32), con coraggio, “lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù” (v. 41). A Lui, Agnello immolato (II lettura), tutte le creature del cielo e della terra sono chiamate a rendere lode e onore per sempre (v. 12-13).
Pietro e gli altri ne sono pienamente convinti, perché hanno sperimentato la misericordia del Padre e la tenerezza del perdono di Gesù. In particolare, Pietro che, rispondendo alle tre doamnde di Gesù -“mi ami?”- riceve da Lui la triplice consegna missionaria che lo trasforma da peccatore in pastore di tutto il gregge. Se Pietro ama veramente il Signore, deve imparare a prendersi cura degli “agnelli”, dei piccoli, degli ultimi, di coloro che non contano, di quelli che fanno fatica a vivere. Vivere per gli altri è servire, è la nuova regola dell’amore. Chi ama davvero va, esce, si prende cura di tutte le persone che incontra sul suo cammino.
L’esperienza del Risorto va oltre le apparizioni iniziali (Vangelo): si prolunga nel saper riconoscere la presenza vera ed efficace del Signore nella quotidianità semplice della vita. “Gesù si fa riconoscere nei suoi gesti, uno straordinario -la pesca miracolosa- gli altri molto semplici e familiari. Ha preparato del pane e del pesce, e li invita amorevolmente a mangiare. Prende il pane e lo dà a loro e così pure il pesce, come aveva fatto tante volte prima… I cristiani sono chiamati a riconoscere Gesù nei loro fratelli... riconoscere Gesù che si fa presente nei più poveri, nei più umili, nei più bisognosi: là i cristiani devono riconoscere la sua gloria, la gloria misteriosa del loro Signore e la potenza della sua azione divina, che compie prodigi attraverso mezzi umili e semplici” (Albert Vanhoye). Credere in Cristo risorto ci sfida a vivere la vita quotidiana da risorti, nelle scelte concrete di ogni giorno, con fede, amore e un creativo impegno missionario verso gli altri, seminando ovunque vita, speranza, misericordia, riconciliazione, gioia... (*)
Parola del Papa
(*) “Giovanni si rivolge a Pietro e dice: «È il Signore!» (v. 7). E subito Pietro si tuffa in acqua e nuota verso la riva, verso Gesù. In quella esclamazione: ‘È il Signore!’, c’è tutto l’entusiasmo della fede pasquale, piena di gioia e di stupore, che contrasta fortemente con lo smarrimento, lo sconforto, il senso di impotenza che si erano accumulati nell’animo dei discepoli. La presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa: il buio è vinto dalla luce, il lavoro inutile diventa nuovamente fruttuoso e promettente, il senso di stanchezza e di abbandono lascia il posto a un nuovo slancio e alla certezza che Lui è con noi”.
Papa Francesco
Regina Coeli nella III domenica di Pasqua, 10.4.2016
P. Romeo Ballan, MCCJ
Lo stile di Gesù
Se mancasse questa pagina ai Vangeli, mancherebbe molto dello stile di Gesù. Giovanni descrive il Risorto vicino a un fuoco di brace, con del pesce sopra e del pane, lasciando intendere che stia cucinando. Anzi, quando i discepoli approdano con la barca piena di pesci, il Signore chiede di portargli un po’ del pescato, affinché cucini anche quello. Come gli altri viventi, uomini e donne si nutrono, ma a differenza di essi (ed è una differenza sostanziale) cucinano. Cucinare esprime in modo tutto speciale l’attenzione ai legami con le cose e con le persone. Significa avere fiducia sia nella qualità degli ingredienti, nella fattibilità del piatto e nell’apprezzamento di chi lo gusterà. Richiede un grande rispetto per le cose (ingredienti e arnesi) affinché un’azione maldestra o fuori tempo non rovini il sapore delle pietanze. Chi cucina ha bene in mente quanto piace al proprio ospite, ciò che può mangiare, cosa deve mangiare e cosa non è bene che in questo momento mangi. Perciò non sono sufficienti né la propria buonissima intenzione di nutrire né la propria competenza culinaria, poiché se chi cucina non coglie la reale situazione di chi mangerà, anche il più buono dei piatti risulta indigesto o perfino disgustoso, poiché non conforme alla salute e al palato del proprio ospite. La grandezza di un cuoco si misura anche nella capacità di rendere appetitosi cibi che non risultano immediatamente graditi, ancorché
necessari alla salute. Caso emblematico è quello del bambino che aborrisce la verdura; la mamma o il papà abili coi fornelli sapranno preparare pietanze dove la verdura nemmeno si vede e si sente, anche se ben presente. Ma, forse, la gloria del cuoco risplende ancor più quando riesce a stuzzicare l’appetito all’inappetente, a chi non ha fame, ha smesso di averla, o addirittura si è imposto di non sentirla. Qualora il cuoco riuscisse a riaprire il varco chiuso nella carne inappetente è come se risuscitasse un morto, visto che fame e sete sono le prime parole per dichiarare il proprio essere al mondo. In caso di pericolo di morte per fame, non si deve andare per il sottile. Proprio come fece il Signore nel deserto; nutrì tutti con pane e pesce. A tutti la medesima cosa, senza distinzione. Ma quando non si ha più paura — e il Risorto, se lo vogliamo, ci libera dal suo tremendo morso — allora si ha il tempo non solo di nutrire, ma di cucinare, mostrando per ciascuno una cura singolare, un’attenzione irripetibile, un affetto pieno di premura. Anche per questo il Risorto commuove.
di Giovanni Cesare Pagazzi
L’Osservatore Romano
Tutta la Chiesa è protesa verso il Signore Risorto
At 5,27-32.40-41; Salmo 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19
In questa terza domenica di Pasqua, la Parola di Dio ci informa sul come gli apostoli hanno scoperto in Gesù risorto l'amico che ha dato la vita per loro e che è sempre pronto a perdonare. La prima lettura, raccontando l'inizio della Chiesa in Gerusalemme, presenta gli apostoli che vengono rimproverati dal sommo sacerdote perché annunciano a tutti il Cristo risorto. La predicazione dei discepoli di Gesù suona come un'accusa nei confronti dell'autorità del tempio che ha avuto un ruolo determinante nella sua condanna a morte di croce da parte del governatore romano. La riposta di Pietro, a nome del gruppo è un'affermazione della libertà di coscienza: "Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini".
Il principio dell' "obiezione di coscienza" è proprio lì, quando un'autorità umana comanda qualcosa che va contro la coscienza e contro Dio. L'obbedienza di cui parla Pietro coincide con la piena adesione alla volontà di Dio che rivela il suo disegno di salvezza in Gesù Cristo morto e risorto. L'autore degli Atti chiude la scena con la flagellazione degli apostoli che vivono così la beatitudine evangelica dei perseguitati; e se ne tornano "lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù".
La gioia in mezzo alla tribolazione è segno e frutto della presenza e dell'azione dello Spirito Santo. La seconda lettura, dal libro dell'Apocalisse, scritto per confortare i cristiani in tempo di persecuzione, presenta Cristo con la figura molto suggestiva dell'Agnello immolato, che riceve da tutto il creato "lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli".
E' l'affermazione del fatto che "Gesù regna", dopo aver manifestato la prossimità di Dio all'uomo, sperimentata come alleanza e come intervento di liberazione. Il brano evangelico racconta la terza manifestazione pasquale di Gesù ai suoi discepoli. Vi compare in modo particolare la figura di Simon Pietro assieme a quella del discepolo amato. Nel primo brano narrativo, si tratta della pesca miracolosa. Pietro prende la decisione di andare a pescare nel lago di Tiberiade. A lui si associano altri sei discepoli. In quella notte non prendono niente. Al mattino si presenta Gesù.
Nel linguaggio biblico il mattino è il tempo dell'intervento liberatore di Dio. E il buio rappresenta l’assenza di Gesù. Egli invita i discepoli a gettare la rete sulla parte destra della barca. L'effetto della sua parola è immediato. Essi raccolgono una quantità enorme di pesci, quasi sfondano le rete. Giovanni va da Pietro e gli dice all'orecchio: "E' il Signore". Il discepolo prototipo dei credenti passa dal segno della pesca abbondante alla professione di fede pasquale. Appena sente queste parole, Pietro "si cinse ai fianchi la sopravveste, poiché era appoggiato, e si gettò al mare". Pietro si sente proprio spoglio davanti al Signore, dopo l'aver rinnegato tre volte, come Adamo ed Eva nel giardino dopo la disobbedienza a Dio. La rete era piena di 153 grossi pesci, benché fossero tanti, la rete non si spezzò.
Questo linguaggio simbolico allude alla diversità e all'unità della Chiesa. In tale ottica i 153 pesci rimandano alla missione universale della Chiesa resa feconda soltanto dalla presenza di Gesù. Nella seconda sequenza narrativa ricompare la figura di Pietro. C'è un dialogo tra lui e Gesù, con una triplice domanda: "Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?" Pietro risponde positivamente, e Gesù allora gli affida il compito di pascere il suo gregge. L'amore profondo di Cristo appare qui come la condizione sine qua non per pascere gli agnelli e pecore del Signore, per assumere il compito pastorale nella Chiesa. Gesù si comporta con noi peccatori come si è comportato con Pietro pentito. Ci perdona subito e ci restituisce la sua amicizia.
Don Joseph Ndoum
Reciproca amorevolezza
Gv 21, 1-19
Frequentemente, nella nostra quotidianità, sembra che il “fare” pesi di più dello “stare”. L’evangelista Giovanni racconta di un Gesù che desidera “stare” conducendo la sua creatura a fare esperienza della sua natura divina con un semplice ritorno ad un atto di reciproca amorevolezza. Gesù stravolge la modalità di lettura del reale da parte degli apostoli e propone non una azione ma una meravigliosa dichiarazione di affetto.
Pietro, uomo del fare, si attiva e propone, si adopera e opera, ma il punto di inizio per Gesù è comunque da un’altra parte; Gesù non appare interessato a ciò che la sua creatura sta facendo secondo il Suo insegnamento, ma va diretto, con tre domande, al punto per lui centrale: “Pietro, mi ami?”. Appare buffo e peculiare che proprio Gesù richieda l’amore a Pietro, proprio a colui che lo ha rinnegato e che sembra non capire molto di ciò che sta vivendo. Ma Gesù sceglie Pietro e lo raggiunge proprio nella sua ripetuta debolezza umana, e desidera condividere con lui una dimora nel suo cuore; tutto rotea e si gioca su una richiesta di amore. Ogni essere umano desidera amare ed essere amato, eppure è tanto difficile riconoscere e vivere questo desiderio di amore.
Abbiamo costantemente bisogno di spostarci sull’asse dell’operatività, dimostrando a noi e all’altro di essere meritevoli di amore grazie al nostro agire, smarrendo così l’originario motore propulsivo: vivere in sintonia con la nostra vera natura, in cui Dio e noi diventiamo una armonia d’amore. Le scienze psicologiche ci mostrano e dimostrano quanto il nostro essere nel mondo acquisisca un senso solo attraverso il volto amorevole dell’altro. Se manca lo sguardo di tenerezza da parte dell’altro, il cuore tende alla chiusura e si difende, pulsando secondo un ritmo semplicemente automatizzato. La nostra vita rischia spesso di procedere ad una andatura quasi meccanica, caratterizzata da una scansione priva di “intimità” e “amorevolezza”. Ma l’uomo riesce a vivere autenticamente solo se amato senza riserve, allora Gesù sente la necessità di fermare Pietro e riportarlo al suo desiderio originario: “mi ami tu?”, mostrandogli dove risiede il centro dell’uomo.
Per tre volte Gesù chiede a Pietro l’amore e questo ultimo alla fine cede e “si sente addolorato”; finalmente, sollecitato ben tre volte, torna al punto di inizio, finalmente Pietro si permette di rientrare in se stesso facendo contatto con la propria fragilità umana. A volte non basta una intera esistenza per accogliere e dare forma all’amore. Quante volte scegliamo “il fare” allo “stare”, quante volte riempiamo la nostra giornata di attività e facciamo fatica a fermarci e a dire l’amore. Dare parole all’amore, è ciò che ci umanizza e ci rende più vicini alla logica di Dio. Saper identificare ed esprimere l’amore, è il primo passo verso la compiutezza dell’umano, saper tornare e rimanere in questo stato di tenerezza, comporta una grazia particolare e Gesù ha scelto Pietro, forse in lui ha riconosciuto tutta la nostra fragilità creaturale.
Rossella Barzotti
L'Osservatore Romano